Il fine della soteriologia buddhista alla luce del saññāvedayitanirodha
Notoriamente, lo scopo ultimo della soteriologia buddhista è la realizzazione del nibbāna (sanscrito: nirvāṇa), possibile già in vita, ma attinta compiutamente e irreversibilmente dopo la morte. La maggiore approssimazione alla misteriosa liberazione finale sperimentabile quando si è ancora vivi è data da un conseguimento meditativo noto come saññāvedayitanirodha, che il presente contributo indaga sia in se stesso che, alla fine, nella sua relazione col nibbāna.

I tentativi di comprendere il fine ultimo della prassi etica e contemplativa buddhista, nella quale è da tradursi la dottrina in tutta la sua ampiezza e profondità, non possono prescindere dall’analisi di un singolare stato meditativo noto alle fonti pāli come saññāvedayitanirodha, composto che si potrebbe rendere come “cessazione di nozioni ed esperienza”.
Il nibbāna (sanscrito: nirvāṇa), che proprio tal fine costituisce, si trova, difatti, in qualche modo in rapporto con quello che d’ora innanzi chiameremo, per semplicità, nirodha (“cessazione”), che ha costituto l’oggetto di trattazioni all’interno di due manuali di contemplazione d’epoca post-canonica, il Vimuttimagga di Upatissa (II d.C. ca.), di cui resta solamente la traduzione cinese, e il seriore Visuddhimagga di Buddhaghosa (V d.C.), parzialmente debitore verso il Vimuttimagga e di cui possediamo l’originale pāli.
Dipendendo verosimilmente da antecedenti comuni, esistono sovrapposizioni tra i due manuali nel modo di trattare l’argomento in esame: ambedue concordano sulla necessità di coordinare le due forme della meditazione buddhista, samatha e vipassanā, allo scopo di elevarsi interiormente fino al livello sommo del nirodha: l’una forma di meditazione intende calmare la mente riducendone vieppiù le attività attraverso fasi successive di crescente raffinamento psicologico, l’altra di contro, per come viene descritta in maniera articolata nel terzo volume del Visuddhimagga, tramite intuizioni sequenziali (16 in totale), intende approfondire in modo sempre maggiore la natura dell’esperienza, fino al conseguimento degli stadi di risveglio.
Sulla cooperazione di samatha e vipassanā già il Canone si era espresso, benché senza elucidare il percorso pratico da seguire per conseguire il nirodha: il Dutiyakāmabhū-sutta si limita, infatti, a dire che samatha e vipassanā sono utili a tal fine, ma mancano del tutto spiegazioni su come servirsi di questi mezzi contemplativi per raggiungere detto scopo.
Rimediando a siffatta lacuna, il Visuddhimagga spiega come il raggiungimento del nirodha sia subordinato all’alternanza di samatha e vipassanā man a mano che si attraversano quegli stati meditativi di crescente profondità che sono i jhāna, all’emergere dai quali ciascuno è da contemplare alla luce della cosiddetta “triplice caratteristica” (tilakkhaṇa), condivisa da ogni realtà condizionata, vale a dire alla luce dei caratteri impermanente, insoddisfacente e manchevole di un sé permanente, separato e indipendente.
Emerso da quel jhāna che il Dahlke chiamò, con un neologismo tedesco, Nichtetwasheit, ovvero “sfera del non-qualcosa” (ākiñcaññāyatana), il praticante buddhista, prima di progredire oltre, formula quattro propositi da osservare durante la sua permanenza nel nirodha: (1) che gli oggetti appartenenti ai suoi confratelli non vengano derubati o danneggiati; (2) che, qualora la comunità monastica intenda fare qualcosa per cui è richiesta la sua presenza, egli emerga dall’assorbimento meditativo prima che qualcuno lo convochi; (3) che, similmente, egli sia pronto ad uscire dal nirodha prima che qualcuno venga a convocarlo per metterlo al corrente della volontà del maestro di fornire un insegnamento; (4) che egli non perisca durante la permanenza nel nirodha.
Ciò fatto, l’adepto può progredire verso l’ultimo jhāna senza rischio di retrocedere e, infine, raggiunge la “cessazione”. A questo punto, il suo stato psicofisico si differenzia appena da quello di un defunto: vi coinciderebbe del tutto, se non fosse che in lui permangono la forza vitale (āyu) e il calore (usmā), e le facoltà sensoriali (indriya) sono chiarissime.
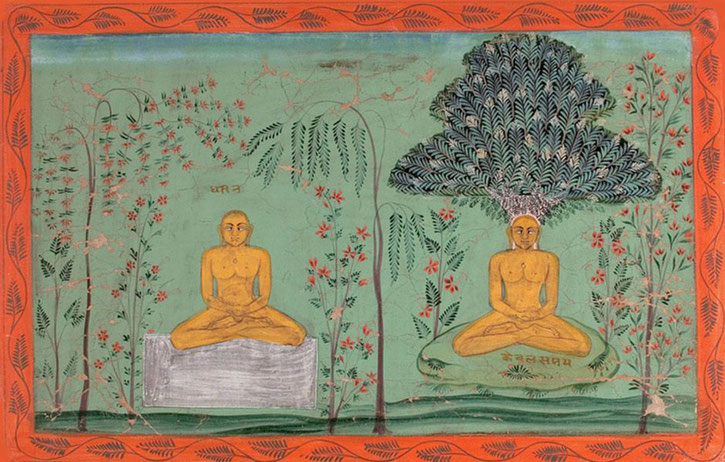
Quel che, probabilmente, più sconcerta è che, già per il Canone e successivamente per il Visuddhimagga, nel soggetto immerso nel nirodha il processo respiratorio è detto interrotto; non si tratta, però, di un caso singolare, non solo per il fatto che anche altre tradizioni indiane, come il jainismo e lo Yoga, prevedono l’arresto della respirazione, ma anche perché la stessa tradizione buddhista riferisce di una pratica attuata dal Buddha, quando peraltro non era ancora tale, nota come appāṇakajjhāna (“assorbimento meditativo senza respiro”).
Eppure, il nirodha è ancora più estremo, poiché in esso l’assenza della respirazione si accompagna alla sospensione di tutto ciò che, nei termini buddhisti, costituisce una persona umana dal punto di vista psicologico, vale a dire gli aggregati (khandha) delle sensazioni (vedanā), delle percezioni (sañña), delle formazioni mentali (saṅkhāra) e della coscienza (viññāṇa). Di ciò che costituisce la persona umana, permane unicamente l’aggregato della forma materiale (rūpakkhandha), cui verosimilmente è da attribuire il ripristino di una condizione d’esistenza ordinaria, malgrado secondo un processo che né il Canone né il Visuddhimagga dettagliano.
Ora, perché la comprensione del fine della soteriologia buddhista avrebbe a che fare col nirodha? Innanzitutto, l’auspicabilità di raggiungere la “cessazione” potrebbe essere dovuta alla realizzazione, a posteriori, del carattere di non-sé (anattā) dei quattro suddetti processi di natura mentale, rivelando come essi sorgano e scompaiano senza che una sostanza permanga inalterata durante il loro scorrere: l’esperienza in ogni sua possibile manifestazione psicologica scompare nel nirodha senza che a questo punto sia possibile scorgere un principio soggiacente; a monte dell’esperienza non c’è, cioè, un’entità permanente cui sia possibile attribuire il nome di “sé” (attā), “anima” (jīva), “conoscitore” (vedagū), “conoscitore del campo” (kṣetrajña)… E questa medesima realizzazione conoscitiva non è di “qualcuno”, ma è del tutto impersonale.
In secondo luogo, il nirodha prefigura quell’arresto definitivo dei costituenti empirici della personalità che si verifica alla morte di un arahant, vale a dire di colui che ha portato a compimento la disciplina e la dottrina buddhiste, così non essendo più destinato a rinascere. Il nirodha vale, dunque, come assaggio della misteriosa liberazione finale, quella pienamente attinta dopo la morte di un “liberato in vita” (jīvanmukta), potremmo dire secondo il lessico del Vedānta, quando i costituenti psicofisici della persona, rinnovantisi da tempi senza inizio, non si manifesteranno ulteriormente: si tratta, insomma, di “sperimentare” in vita l’anupādisesa-nibbāna, il “nibbāna senza residuo”, così detto proprio in ragione del fatto che vi mancano i cinque khandha.
Il Buddha si rifiutò di rispondere alle questioni circa il destino di un liberato dopo la morte, e tuttavia, poiché la “cessazione” è quanto di più vicino esista al nibbāna definitivo, è possibile sostenere che l’arahant che la consegue conosca in prima persona cosa lo attende dopo la morte, in maniera quasi del tutto esatta, poiché a differenziare il nirodha dal nibbāna finale è soltanto la permanenza del rūpakkhandha, oltre all’ovvio fatto che la “cessazione” è un conseguimento meditativo reversibile, a differenza del nibbāna ultimo, dal quale non v’è ritorno.
È dunque necessario, o quantomeno auspicabile, che chi voglia intendere il nibbāna – fine ultimo della soteriologia buddhista – tenga conto del saññāvedayitanirodha, che vi si approssima come nessun altro ottenimento contemplativo conseguibile in vita.
24 ottobre 2023
SULLO STESSO ARGOMENTO
Alexia Ioana Branzea, L'evoluzione del concetto di Autarkeia tra Occidente e Oriente
