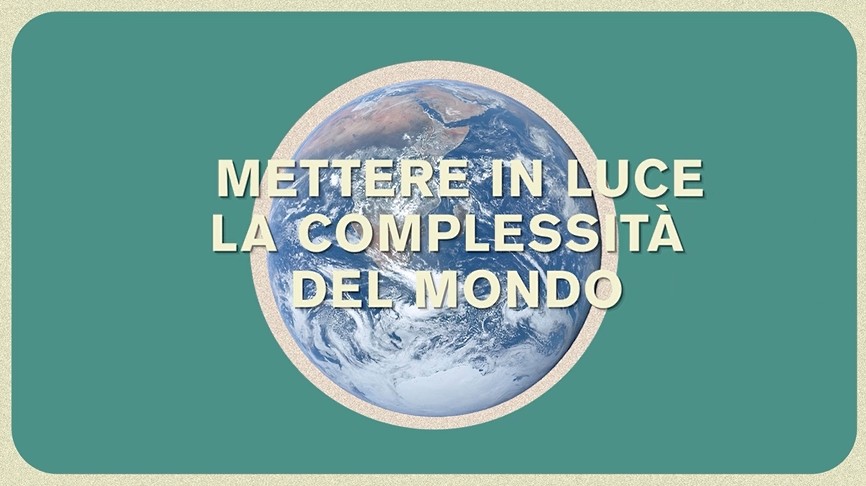Essere come Socrate: la missione di Gazzetta filosofica
La vita e il pensiero socratico sono emblema di un modo di concepire la vita opposto a quello oggi imperante. Contro a qualsiasi visione relativista della realtà, Socrate credeva nell’esistenza della verità e nell’importanza di perseguirla. Ma, contro a ogni dogmatismo – contraltare inevitabile del relativismo stesso –, egli sapeva di non sapere. Era, cioè, consapevole che la verità non si dà una volta per tutte; che l’unico modo per conquistarla, seppur momentaneamente, è il dialogo sincero con chi sta di fronte a noi. Un messaggio che sta alle fondamenta, ormai da otto anni, del progetto di Gazzetta filosofica, e che vorremmo più che mai affermare consolidando e accrescendo le nostre attività.
di Francesco Pietrobelli
Dove manca il dialogo, prevale la violenza
Uno dei presunti cardini della società occidentale in cui molti di noi vivono è la libertà di pensiero: l’idea che ciascuno possa dire ciò che gli pare, fintantoché determinate parole non si tramutino in atti, i quali invece possono essere passibili di sanzioni se contrari alla legge. È un’idea sovente associata al pensiero liberale, ma che si potrebbe rinvenire ben prima di esso, all’interno di un percorso che ci porta dritti fino alla culla della filosofia europea: il mondo greco.
La prospettiva per cui ognuno abbia diritto a esprimere la personale opinione su qualsivoglia tema sembra un principio più che condivisibile. Se ciò non fosse possibile, non solo vorrebbe dire che si vive in uno Stato per certi aspetti autoritario e limitante le libertà personali oltre il dovuto, ma si negherebbe il progresso stesso in qualsiasi ambito. Progresso che è il frutto del continuo confronto fra persone, della possibilità di criticare e mettere in questione le verità invalse, nonostante appaiano ovvie.
Tutti, con facilità, deridiamo la cecità della Chiesa cattolica quando difendeva a spada tratta il dogma geocentrico, per cui la Terra è al centro dell’universo e tutto, sole compreso, ruota attorno ad essa. Proprio quello ci dovrebbe insegnare che, anziché perseguitare chi la pensa diversamente, dovremmo essere disposti a porci al livello del dialogo, dell’argomentazione serrata e rigorosa, capace di mettere alla prova tanto l’altrui idea quanto la propria. Ciò al fine di capire assieme dove stia la verità.
Constatiamo con amarezza, invece, di vivere in un’epoca che non sa dialogare. Dove il rispetto dell’opinione altrui viene garantito solo a parole, ma nei fatti volentieri si tapperebbe la bocca a chi si mostra di vedute opposte. Soprattutto, dove si è persa la capacità stessa del dialogo, nel momento in cui si ragiona nell’ottica bianco-nero: sei contro o a favore della guerra in Ucraina, difendi ogni dogma liberale o sei un comunista, sei favorevole ai vaccini o no-vax, tifi per gli Stati Uniti o per la Cina. In tutto ciò, però, ciò che si perde è la scala di grigi, intesa come la capacità di argomentare: di esprimere la personale e unica posizione. Unica nel senso di non imitabile: ognuno di noi, in quanto essere umano, non è un automa che ripete una filastrocca imparata a memoria da altri. Ognuno si confronta col mondo circostante e sviluppa un pensiero critico, capace di guidarlo nel mondo. La sua prospettiva lo porterà a collocarsi maggiormente in un campo rispetto all’altro, ma senza scadere in dogmatismi o pensieri preconfezionati da altri, se davvero il suo pensiero è critico.
Una persona potrebbe essere contro l’invasione Russa dell’Ucraina, ma al contempo ritenere che il comportamento della Nato abbia istigato certe reazioni russe; potrebbe essere favorevole ai vaccini in linea generale, ma contrario a una specifica vaccinazione se si è in una fascia d’età giovane; potrebbe credere in determinati principi liberali, ma al contempo riconoscere in sistemi politici, come quello cinese, delle logiche politiche utili e da considerare.
Pensieri di tal genere non sposano l’ottica bianco o nero: non permettono un totale adeguamento a uno degli schieramenti di battaglia. Cosa impossibile se si è teste pensanti.
Pensate, tanto per fare un esempio inaspettato, a un emblema del pensiero comunista: Antonio Gramsci. Chi, più di lui, non potrebbe essere concepito come espressione del campo comunista? Eppure, proprio lui era capace di affermare che il marxismo (denominato «filosofia della prassi» nei Quaderni del carcere) è stata la risposta per demolire presunte verità credute nel passato sul funzionamento della società. Ma, come le precedenti dottrine erano nate in un certo periodo ed erano passibili di falsificazione, lo stesso dicasi per il marxismo:
« Se la filosofia della prassi afferma teoreticamente che ogni «verità» creduta eterna e assoluta ha avuto origini pratiche e ha rappresentato un valore «provvisorio» (storicità di ogni concezione del mondo e della vita), […] una tale interpretazione è valida anche per la stessa filosofia della prassi […]. » (Quaderni del carcere)
E proprio per questo Gramsci era uno capace di confrontarsi con pensieri divergenti dal suo – cattolici, idealisti, liberali, monarchici, fascisti –, perché solo dal dialogo, anche aspro, nasce la possibilità di verificare se la personale posizione sia valida, o se si aprano strade per nuove visioni sul mondo ancora più solide.
Quando però, come evidente negli ultimi secoli, si va imponendo una visione del mondo nichilista, che non crede più nella verità, qualsiasi tipo di dialogo perde di valore. Si può affermare che ognuno ha diritto ad esprimersi, ma secondo che logica decidere chi ha ragione? Nessuna. Se non si può approssimarsi a una verità, non si può decidere in una discussione fra due persone chi abbia più ragione; né può accadere che, discutendo, due interlocutori man mano sviluppino una nuova posizione da entrambi ritenuta vera.
Secondo quale principio allora cambiare opinione? Secondo l’arbitrio più totale. E quando lo scontro di opinioni diventa critico – nel momento in cui, ad esempio, bisogna decidere come agire a livello statale o internazionale – entra in gioco la forza: chi ha più seguaci, o chi ha in mano il potere, può obbligare a far prevalere la sua opinione. Che di verità non ha nulla: sia perché la verità si impone nel dialogo, non con la violenza; sia perché nella verità, come detto, non ci si crede più.
Da otto anni, noi di Gazzetta filosofica lottiamo contro la deriva postmoderna, convinti che esistano fondamenta per cui strutturare un vero dialogo e giungere a una verità condivisa, seppur sempre provvisoria e mai lesiva dell’individualità di ciascuno. Da otto anni, pertanto, cerchiamo di perseguire l’esempio di uno dei più noti filosofi antichi: Socrate.
Il processo a Socrate
Una data sappiamo con certezza sulla vita di Socrate: la sua morte. Nel 399 a.C. viene processato ad Atene per empietà, «accusato formalmente di non credere negli Dei della città e di corrompere i giovani con le sue dottrine» (Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana). Ma dietro quest’accusa c’erano ben altri risentimenti e manovre politiche. Più persone, fra cui anche figure influenti, avevano a odio Socrate e non vedevano l’ora di cogliere l’occasione per farlo fuori dai giochi. Questo, Socrate stesso cerca di spiegarlo nella sua difesa, come riportato in uno dei più celebri dialoghi platonici, L’apologia di Socrate.
Difesa in cui Socrate chiede, agli ateniesi e ai giudici presenti, di non badare a come parla e quanti orpelli retorici userà per persuaderli; di non aspettarsi che implori e porti la sua famiglia per far impietosire i presenti. L’unica cosa, per cui vuole essere giudicato, è se dirà la verità.
« [Vi chiedo] che questo consideriate e a questo facciate attenzione, ossia se io dico cose giuste o no. Infatti, il buon servizio di chi giudica sta proprio in ciò, mentre il buon servizio di chi parla è dire la verità. » (Apologia di Socrate)
A fronte delle accuse di empietà, di corrompere i giovani, di far sembrare i discorsi deboli forti e altro, Socrate mostrerà in più passi che tali accuse non sono fondate, rivolgendosi tanto agli accusatori presenti – come Meleto, che aveva presentato l’atto di accusa contro Socrate a sua firma, o il potente politico Anito, principale responsabile e promotore del processo – quanto a quelli che neppure hanno avuto il coraggio di presentarsi, obbligando Socrate a difendersi «come combattendo con delle ombre».
Le accuse sono solo pretesti, utili a coprire il vero motivo per cui Socrate doveva morire: la sua lotta per la verità.
So di non sapere: né relativista, né dogmatico
Cherefonte, amico di Socrate, una volta interrogò l’oracolo di Delfi chiedendo chi fosse più sapiente di Socrate e la risposta fu: nessuno.
Socrate, incredulo di ciò, convinto di sapere ben poco, iniziò a interrogate ad Atene coloro che erano ritenuti sapienti, fra politici, poeti, artigiani e chiunque avesse nomea di essere persona di conoscenza. Eppure, nel dialogo serrato tipico del filosofo greco, a uno a uno gli interlocutori cadevano in contraddizione, mostrando di credere di sapere, ma di non essere davvero sapienti; oppure, di credere, siccome erano sapienti in un’arte specifica – come gli artigiani –, di essere sapienti anche nelle cose di cui nulla sapevano.
La sapienza di Socrate stava, allora, semplicemente in una semplice, ma complicata da mettere in pratica, constatazione: sapere di non sapere.
« Rispetto a quest’uomo, io ero più sapiente. Si dava il caso, infatti, che né l’uno né l’altro di noi due sapesse niente di buono né di bello; ma costui era convinto di sapere mentre non sapeva, e invece io, come non sapevo, così neppure credevo di sapere. » (Ivi)
«La sapienza umana ha poco o nessun valore», ci sta dicendo l’oracolo di Delfi, e questo Socrate ha capito. La sua sapienza sta nel constatare quanto conoscere il mondo che ci circonda, i principi che ordinano l’essere umano e la realtà che vive, sia un compito immane e mai concluso. Qualcosa che richieda la massima umiltà, il constatare che qualsiasi cosa diciamo non sarà mai una verità definitiva.
Si faccia però attenzione: ciò non significa che una verità non esista, che ogni discorso si equivalga. Se così fosse, non si darebbe alcun sapiente, in quanto ognuno avrebbe diritto a pretendere di essere onnisciente. Socrate, però, si fa odiare da molti ateniesi perché va da loro, entra nelle loro case, e con un dialogo implacabile smonta le loro idee, le loro presunte verità:
« La verità – mi pare – essi non la vorrebbero dire, ossia che è risultato evidente che essi hanno la presunzione di sapere tutto e, invece, non sanno nulla. » (Ivi)
Non ogni pensiero si equivale: altrimenti non si potrebbero palesare contraddizioni tanto nelle idee proprie quanto in quelle altrui. Ognuno ha una personale visione del mondo, che ritiene vera: altrimenti non la affermerebbe nelle proprie azioni, nella sua quotidianità. Si può a parole affermare che tutto è relativo, eppure il proprio agire denota sempre che, in un determinato momento, crediamo a qualcosa piuttosto che a qualcos’altro. Già il dire che non esiste alcuna verità è auto-contraddittorio: o tale frase si pone come vera, o non può porsi. E lo stesso dicasi per ogni pensiero negativo: si può dire di non credere negli dèi, ma allora si crederà in altro (in un mondo sorto secondo leggi slegate da qualsiasi Dio). La questione non sta tanto in cosa crediamo, ma secondo che ragionamento giungiamo a credere in qualcosa – a pensare ciò come vero.
Socrate pungola gli ateniesi a continuare a mettersi in questione, a capire se il loro ragionamento sia valido. Consapevole che tale lavoro non finisce mai: come non è relativista, neppure è dogmatico. Essere aperti al dialogo richiede non solo il credere che la verità esista (altrimenti, il dialogo non ha senso), ma anche che non possiamo mai essere sicuri di detenerla in modo assoluto. Ogni uomo, in quanto imperfetto, potrebbe essersi sbagliato. Il dialogo serve allora per mettersi alla prova, per approfondire le proprie posizioni, per superare errori altrimenti non affrontabili.
Il dialogo è allora fondamentale per la vita stessa, in quanto permette di affinare le personali credenze, dunque l’agire che ne consegue. Permette di ridurre le contraddizioni in cui incappiamo quotidianamente, di ricercare con più coerenza il bene e, quindi, essere felici.
« Infatti io vado intorno facendo nient’altro se non cercare di persuadere voi, e più giovani e più vecchi, che non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze né di alcun’altra cosa prima e con maggiore impegno che dell’anima in modo che diventi buona il più possibile, sostenendo che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma che dalla virtù stessa nascono le ricchezze e tutti gli altri beni per gli uomini, e in privato e in pubblico. » (Ivi)
A raggiungere ciò Socrate aiuta gli ateniesi, al punto che la sua morte, più che un danno a lui, sarebbe un danno ad Atene stessa, in quanto mancherà colui che pungola gli altri uomini, spingendoli costantemente a ricercare la verità.
Quanto a Socrate stesso, egli non può fare a meno di questa ricerca, spinto com’è dal suo demone interiore a non abbandonare la missione che gli dèi gli hanno dato. Se evitare la morte significa smettere di filosofare, allora il filosofo preferisce la morte. Non la vita in sé ha senso, ma la vita carica di valori:
« Non dici bene, o amico, se tu ritieni che un uomo che possa essere di qualche giovamento anche piccolo, debba tener conto altresì anche del pericolo della vita o del morire e non debba, invece, quando agisce, guardare solo a questo, ossia se possa fare cose giuste o ingiuste, e se le sue azioni sono azioni di un uomo buono, oppure di un uomo cattivo. » (Ivi)
Per Socrate, la cosa più giusta da fare era vivere ricercando la verità, ragionando sulla virtù e qualsiasi altro argomento che la vita gli ponesse davanti: «una vita senza ricerche non è degna per l’uomo di essere vissuta» (Ivi). E come David Foster Wallace, più di due millenni dopo, disse:
« Si è, solo ed esclusivamente e completamente, ciò per cui si morirebbe senza pensarci due volte. » (Infinite Jest)
Con ancor più forza, ben prima, Socrate disse di fronte alla morte, a difesa del suo operato:
« Non farò mai altre cose, neppure se dovessi morire molte volte. »
La nostra missione
La vita di Socrate rimane tutt’ora un faro per molte persone, come per progetti e realtà quali Gazzetta filosofica. Da otto anni ci impegniamo a lavorare affinché il monito socratico di non chiudere mai la ricerca, l’interrogazione sulla verità, non rimanga inascoltato. Lontani da ogni relativismo, crediamo che il confronto sia luogo fertile per accrescere assieme la consapevolezza sul mondo che ci circonda e su noi stessi. Lontani da ogni dogmatismo, abbiamo sempre ospitato – tramite articoli, interviste, video, pubblicazioni – autori e pensieri divergenti, consapevoli che è proprio l’incontro e il confronto con ciò che è diverso da noi a rendere la ricerca proficua. Negli anni abbiamo, come redazione, preso posizione, e continuiamo a farlo, su questioni di ogni campo (filosofico, storico, economico, politico, sociale, culturale…), consapevoli che la filosofia significa affinare la propria visione sul mondo, la quale inevitabilmente tocca ogni campo del sapere. Ma il nostro “prendere posizione” non ha mai voluto essere dogmatico e privo di argomentazioni, bensì aperto al confronto con chi la pensava diversamente, nella speranza che da ciò la nostra posizione potesse maturare e migliorare.
In sintesi, da otto anni cerchiamo, attraverso il dialogo con i diversi saperi, di mettere in luce la complessità del mondo, la filosofia implicita ed esplicita che sta alla base dell’interpretazione del quotidiano, dei fatti, della realtà.
Da otto anni sogniamo di rendere Gazzetta filosofica sempre più un genuino luogo di ricerca e divulgazione filosofica, che permetta, a chiunque abbia voglia di impegnarsi nello sforzo del pensare, di dare un contributo che possa essere significativo per capire la nostra realtà. Sogniamo di lottare per costruire un pensiero critico che sia da guida all’agire umano, che porti a credere nei valori profondi dell’uomo.
Da otto anni Gazzetta filosofica esiste e ha resistito come puro volontariato, ma le attività e la mole di lavoro continuano a crescere. Non vogliamo deludere tutti coloro che credono nel nostro progetto e, per non spegnere la nostra lanterna in questi tempi bui, abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile.
Non vogliamo rinunciare a sviluppare un pensiero critico. Assieme a voi, grazie a voi
Il nostro desiderio è quello di strutturare Gazzetta filosofica, dando vita ad un centro di ricerca che continui ad avere il suo cuore pulsante nella ricerca filosofica per poterne pubblicare i risultati attraverso articoli, saggi, volumi tematici, contenuti social e video interviste. Oltre a sviluppare corsi di formazione, seminari online e in presenza e collaborazioni con tutte quelle realtà che abbiano un progetto interessante a livello filosofico.
Soprattutto, vogliamo dare vita ad un’organizzazione che non pensi al profitto, ma che sia concentrata sulla ricerca e sul miglioramento della nostra società ormai alla deriva.
Il nostro sogno è quello di rendere Gazzetta filosofica una comunità inclusiva.
Per questo abbiamo bisogno di strutturarci come un’impresa sociale: un obiettivo non da poco e il cui costo iniziale non è indifferente. Per questo, se credete nel nostro progetto e avete interesse a sostenerci, ora è il momento giusto. Qualsiasi partecipazione e contributo sarà prezioso. Grazie per tutto il supporto che ci darete, che, assieme, ci daremo.
Vi aspettiamo quindi alla live di domani sera, lunedì 12 maggio, ore 19.00, sul nostro canale YouTube per parlavi del nostro Progetto e di come poter dare il vostro contributo!
11 maggio 2025