L'uomo come non-senso. Una domanda a cui si risponde senza risposta
Nel mondo contemporaneo, dopo millenni di storia, ancora non sappiamo bene definire cosa voglia dire “uomo”; e se l’esistenzialismo ha cercato a suo modo di rispondere a questa domanda, non possiamo dire che ci sia totalmente riuscito. Ma se la risposta fosse lo stesso porsi la domanda, se la risposta fosse l’assenza stessa della risposta? Il post-modernismo, con il decostruttivismo e il cosiddetto “assurdismo” di matrice esistenzialista, potrebbe contenere le nuove vie per porsi nuovamente questa domanda.
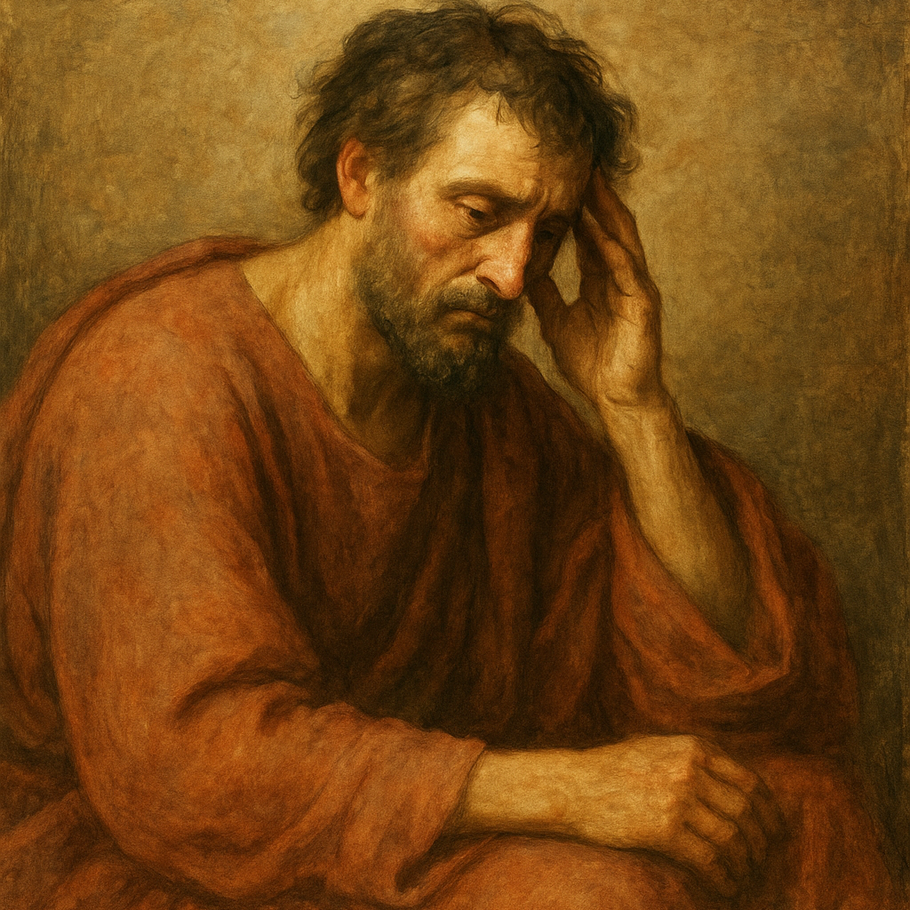
Uno dei testi capitali della filosofia moderna inizia con l’esigenza di riporre la questione riguardo l’essere, a lungo dimenticata. Il testo in questione è Essere e Tempo di Martin Heidegger, che infatti nel suo incipit recita:
« Abbiamo noi oggi una risposta alla domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con la parola “essente”? Per nulla. È dunque necessario riproporre il problema del senso dell’essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non comprendere l’espressione “essere”? Per nulla. È dunque necessario incominciare col ridestare la comprensione del senso di questo problema. » (M. Heidegger, Essere e Tempo)
Il libro in questione è un testo capitale della filosofia moderna e soprattutto dell’esistenzialismo novecentesco. Lo è non solo per le sue risposte, ma per l’intuizione geniale dell’esigenza di una risposta oltre il positivismo che aveva condizionato tutto l’800. Non che in questo articolo ci si proponga di assolvere a un compito così ambizioso; tuttavia v’è una domanda che ancora rimane non risposta e che, a parere di chi scrive, sarebbe utile riportare nel dibattito contemporaneo, non solo accademico, ma anche di coscienza comune. Alla domanda: “Cos’è l’uomo?” non sappiamo ancora rispondere e questo articolo cercherà di essere niente più che un piccolo, minuscolo spunto per iniziare a poter pensare l’uomo come definibile proprio tramite questo punto interrogativo, ovvero come conflitto fra esigenza di risposta e assenza di risposta.
L’identità come conflitto in sé
Se è possibile sostenere una verità hegeliana in maniera quasi sicura, a parere di chi scrive quella è la verità della nozione d’identità come essenzialmente prodotto di conflitto. Questa tesi, quasi spinoziana (si ricordi omnis negatio est determinatio, ovvero “ogni negazione è determinazione), appartiene ad una lunga storia filosofica, la cui discussione più celebre e prossima a Hegel è quella di Fichte. Essa sostiene che perché sia posta una cosa determinata, ovvero qualsiasi cosa che possiamo pensare come quella cosa lì, essa deve essere uguale a sé stessa. Da ciò Fichte inizia a porsi una domanda che interroga il fondamento di tutto ciò, ovvero come si fa a dire quella cosa lì è uguale a quell’altra cosa là? Ovvero: come si fa a dire che A (ovvero un’ipotetica cosa) sia uguale a sé stessa, dunque A=A? E sostiene una tesi brillante: v’è un Io che pone un A e che successivamente pone un’altra cosa diversa da A (chiamiamola non-A) in opposizione a essa; si crea così il conflitto, od opposizione, fra A e non-A e questa opposizione viene poi trasferita all’interno dell’idea di A.
Questo concetto, probabilmente astruso per chi non è familiare con il ragionamento filosofico-teoretico, è riassumibile nella frase spinoziana ricordata sopra: ogni negazione è determinazione. Tutto ciò non vuol dire altro che per porre effettivamente un qualcosa si deve porre anche un suo opposto.
Hegel fa un passo avanti rispetto a ciò e sostiene che ancor prima che A sia posta, ovvero che si determini quella cosa lì vi deve essere un’opposizione. O meglio, sostiene che già nel pensare questo computer con cui sto scrivendo si sta implicitamente “pensando” tutto ciò che questo computer non è. Fichte sostiene che prima si possa dire A e poi si debba dire non-A per definirla e quindi per costituire la sua identità. Hegel sostiene una cosa ancora più profonda: non puoi dire A senza non-A. Nel momento stesso in cui si dice quella cosa lì si sta automaticamente dicendo ciò che rimane dopo avere escluso tutto meno quella cosa lì. Per semplificare ancora di più può essere facile pensarlo come un disegno: su una lavagna nera si disegna una circonferenza che delimita un cerchio separandolo da tutto il resto nero; creare il cerchio e quindi anche eliminare tutto il resto e quindi dire “questo cerchio qui è tutto meno tutto ciò che è oltre questa linea e solo grazie a questo tutto si può dire che allora questo è un cerchio”. Ancora un altro modo di vederla è dire che io sono io solo finché non sono un altro. Dire io sono io è quindi anche dire io non sono un altro.
Ma tutte le implicazioni e tutta la profondità di questo concetto non sono solo impossibili da esprimere in questo articolo, ma non sono neppure necessari al suo punto; quello che per ora questa nozione può donare a questa discussione è solo che per dire cosa qualcosa è si deve accettare un conflitto nella stessa pretesa di dirlo. Definire qualcosa è affondare nella conflittualità.
La conflittualità tra domanda e risposta
Non solo la stessa pretesa di definizione, come abbiamo visto, è necessità di conflitto, ma in particolare la necessità di rispondere all’uomo è una necessità che risponde a un altro conflitto dell’uomo.
La visione che si ha dell’uomo da dopo la decostruzione metafisica di Nietzsche, il decostruzionismo e l’esistenzialismo à la Camus («Non sarai mai felice se continui a cercare di cosa sia fatta la felicità. Non vivrai mai se cerchi il senso della vita») è immerso in un mondo privo di senso (sempre Camus infatti scrive: «Il mondo, in sé, non è ragionevole: è tutto ciò che si può dire. Ma ciò che è assurdo, è il confronto di questo irrazionale con il desiderio violento di chiarezza. L'assurdo dipende tanto dall'uomo quanto dal mondo, ed è, per il momento, il loro solo legame.»), ma non solo Camus sosteneva certe tesi, anche Nietzsche sostiene la medesima cosa in Umano troppo umano, ovvero che scienza, cristianesimo, arte e filisteismo siano nient’altro che risposte all’inquietudine del non-senso del mondo.
Questo articolo non può essere di certo la sede in cui discutere e argomentare la validità di certe tesi, non solo per la loro complessità ma anche per la loro lunghezza; per ora ci si limiti a partire da questa premessa.
Se, dunque, il mondo è non-senso l’uomo non può che essere non-senso a sua volta. Ovvero alla domanda “cos’è l’uomo?” si dovrebbe rispondere senza un senso. Questa stessa domanda è effettivamente ricerca di senso. L’uomo, se c’è una cosa che riesce costantemente a dimostrare, è la sua assurdità, il suo paradosso (il suo non-senso appunto). Basti pensare alla volontà di regnare sulla natura quando noi stessi siamo natura (quasi una volontà di regnare su se stessi). Il punto però è che questa dimensione priva di senso che è costitutiva dell’uomo non viene accettata da quest’ultimo (ritorna anche qui Camus: «L'uomo è la sola creatura che rifiuta di essere ciò che è.»).
E qui entra in gioco non solo la conflittualità insita nel concetto di definizione, ma la conflittualità proprio nella ricerca di una definizione dell’uomo: l’uomo ricerca una definizione a causa di quella che Nietzsche chiamerebbe la “nausea” del guardare il mondo per come esso davvero è, ovvero senza doppio fondo, senza un senso nascosto da qualche parte, senza un noumeno o una sostanza insondabile da ritrovare, ma esattamente come appare: senza senso. L’uomo è l’uomo perché è così, perché sì (la risposta più insensata che si possa dare a una domanda).
Wittgenstein nelle sue Ricerche filosofiche sostiene che il senso altro non sia che una giustificazione; ovvero, per semplificare una tesi estremamente complessa, una spiegazione a una frase: il senso di dire “ora questo computer su cui scrivo è un computer” è che prima era solo un’accozzaglia di rottami messi insieme, ma questo senso che può avere per qualcuno a conoscenza dello stato precedente di questo computer, ovvero quello di essere solo rottami, non è necessariamente condiviso né univoco. Questa frase per me sensata potrebbe essere priva di senso a qualcuno che non è a conoscenza di questo antefatto.
Cosa c’entra però questo con tutto ciò che si sta dicendo? C’entra nella misura in cui la necessità di una definizione dell’uomo è proprio la necessità di un senso, ovvero di un: “che senso ha l’uomo?”, “perché l’uomo è così?” Ovvero definire l’uomo non è solo dargli un nome, una definizione, uno slogan, una semplice descrizione; se c’è qualcosa che le Ricerche filosofiche insegnano è che parlare è pensare e che definire l’uomo non è solo descrivere l’uomo, ma capirlo.
Chiedere “Cos’è l’uomo” è chiedere il senso della parola uomo, e chiedere il senso della parola uomo è chiedere un senso riguardo la sua natura, la sua essenza; perché? Perché l’uomo fondamentalmente non ha senso. Ed ecco che di nuovo si palesa il conflitto.

Una risposta cristiana, una risposta apocalittica…
Se c’è qualcosa che non è opinabile è che la Bibbia, anche per un ateo come chi scrive, possa essere strumento di tante riflessioni e chiave di risposta a tante domande.
Partiamo da un assioma con cui Feuerbach concorderebbe appieno: la trinità è una trasposizione della natura umana in chiave mitico-teologica.
Gesù Cristo: è il verbo che si fa carne, il figlio dell'uomo, che scende in mezzo agli uomini, quindi rappresenterebbe il rapporto uomo-uomo, ovvero l'individuo nel rapporto con gli altri individui. Muore in mezzo agli uomini come uomo, in alcuni vangeli (in particolare nel Vangelo di Marco) si rivedono i timori e le caratteristiche molto umane di Gesù (dal piangere e chiamare Dio Abba, ovvero “papà”, e implorarlo di cambiare i suoi piani per poi comunque rassegnarsi a essi; o nel Vangelo di Matteo dove si getta con la faccia nel fango, così come in quello di Luca dove il sudore assume quasi il colore del sangue). E potrebbe essere una rappresentazione anche della problematicità di questo rapporto uomo-uomo, che si configura come distruttivo. La distruttività costitutiva dell'uomo si rivede nell'uomo che crocifigge l'uomo, elevando questa autodistruttività costitutiva umana a realtà estatica (estatica nel senso di eccessiva, di qualcosa che va oltre; dal gr. ek-stasis): l'autodistruttività dell'uomo è progresso dell'uomo, quasi un male necessario al miglioramento. Una rassegnazione che, per fuggire dall'orrore, viene nobilitata teleologicamente per accettarla.
Lo Spirito Santo: è incorporeo, entra nella vergine e scende a battezzare; questo rappresenterebbe il rapporto con il proprio sé (io-me stesso), visto come puro ma corruttibile, non conoscibile appieno se non come visione intangibile. È origine dell'uomo (parto verginale di Maria a opera dello Spirito Santo), simbolo dell'origine inspiegabile e miracolosa dell'uomo (perlomeno per l'epoca inspiegabile), e della sua purezza (la benedizione dell'uomo avviene con la consacrazione di una parte del proprio sé, della propria anima, come tempio di Dio, che infatti è distinto dall'anima ed è lo spirito), la consacrazione avviene nell'accettare lo Spirito Santo, quindi accettare sé stessi per poter diventare davvero umani.
Dio: è tutto, origine del cosmo, ordinatore, governatore e giudice; quest'ultimo rappresenterebbe il rapporto uomo-mondo/uomo-cosmo/uomo-esistenza. Dominante sulla natura, ma parte della natura (Dio domina su tutto, ma Dio è in tutto ed è tutto), giudice ultimo su di sé e creatore di sé (l'uomo origina l'uomo nel parto e l'uomo solo può giudicare sé stesso), governatore di sé stesso e legiferatore di sé, così come sulla natura (l'uomo decide il proprio governo e le proprie leggi e si governa, così come governa - o così è convinto di fare - la natura). È eccesso, Dio è troppo, è tanto da essere un mistero che non può rivelarsi completamente neppure nel rivelarsi. Questo simboleggia l'incomprensione dell'uomo di indagare completamente se stesso. In Esodo 3:14 Dio è Io-Sono, ovvero la rivelazione di un eccesso divino che però nel rivelarsi secondo questi termini non rivela nulla, ritorna segreto, ritorna ad un eccesso, a un bisogno di altro, a un’estasi.
L’uomo, nel suo rapporto con il mondo e quindi con l’altro, con il suo opposto, con il tutto oltre se stesso, e dunque con la sua definibilità (come detto sopra), può essere visto come questo eccesso. Cos’è Dio? È l’Io-sono, ovvero la sua impossibilità di rivelarsi completamente, la sua impossibilità di definirsi. Allo stesso modo cos’è l’uomo? L’uomo per sé (e le definizioni hanno senso solo nel mondo dell’uomo) non è nient’altro che questa sua incapacità di definirsi.
Conclusione
Lo spunto conclusivo di questo articolo è uno spunto paradossale, un non-senso, ovvero: la risposta alla domanda “Cos’è l’uomo?” è la domanda stessa, è l’impossibilità di definirsi. L’uomo è il suo non riuscire a comprendersi, è la sua assenza di definizione; ovvero è la domanda senza la risposta. È il conflitto non risolto, il non-senso che raggiunge il senso solo come l’assenza di senso, ovvero è il non-senso che si spiega come non-senso camuffandosi da senso. La risposta alla domanda è la ricerca che non finisce. È una parola che non ha una giustificazione (per dirla con Wittgenstein) e che dunque non ha senso e la cui giustificazione è però nell’assenza di quella giustificazione, per cui il suo senso è solo ed esclusivamente nel suo non-senso.
La conflittualità della definizione umana non è solo costituiva della sua definizione in quanto ogni definizione è conflittuale, ma è anche conflittuale nel senso che è un’esigenza che si scontra con una realtà senza mai risolversi; un conflitto non pacificato. È una ricerca senza fine.
Quando l’uomo potrà rispondere a questa domanda, allora la nostra idea attuale di uomo decadrà, muterà, magari si evolverà.
Ovviamente l’esposizione di questo articolo è necessariamente stata breve e divulgativa, dunque sintetica e probabilmente superficiale. Per questi motivi la risposta di questo articolo non può chiamarsi “risposta” nel suo senso proprio, ma è da prendersi come spunto di ulteriore riflessione più approfondita.
10 settembre 2025
DELLO STESSO AUTORE
Schnier, il clown di Böll. La bellezza del particolare e l'epico nel XXI secolo
SULLO STESSO TEMA
M.I. Destito, I limiti dell'uomo
