La coppa del miele e dell’acqua sorgiva: Platone e la vita felice
Viviamo in una società edonista. Al di là dei facili moralismi, sarebbe ingenuo negare che oggi il piacere occupa il primo posto. Il consumismo sfrenato, l’accumulo di beni superflui, il culto dell’apparenza, il dilagare delle dipendenze: tutto sembra indicare che l’imperativo è provare piacere, sempre e comunque, a qualsiasi costo. Ma cosa direbbe Platone di fronte alla nostra morale dell’eccesso? E in che modo il suo pensiero può aiutarci a comprendere il presente?

Ricorrere ai classici per leggere il presente è sempre un’operazione delicata. Da un lato, il classico è per sua natura attuale; dall’altro, è facile ingabbiarlo in griglie concettuali che gli sono estranee. Più lo sentiamo vicino, più tendiamo a colmare la distanza che ci separa, fino a deformarlo. Si genera così un gioco di rifrazione pericoloso: la presunzione di possedere la verità del classico lo trasforma da lente capace di svelare i dettagli nascosti della realtà in uno specchio in cui ci si riflette narcisisticamente.
Diffidare dei rapsodi

La deriva narcisista è evidente quando divulgatori più o meno pop, in auge sui social, “usano” i classici. Luoghi comuni storiografici ormai superati si mescolano a fraintendimenti grossolani, che farebbero rabbrividire chiunque abbia una minima formazione filologica. Eppure, sul versante del marketing, l’operazione funziona: fa cassa. Non importa cosa si dice, ma come lo si dice – la capacità di apparire ispirati.
Platone chiamerebbe “rapsodi” i santi patroni della cultura che pullulano sul web. Nello Ione Socrate ricorre a un’immagine efficace per descrivere chi “recita” la conoscenza. Ione – l’interlocutore di Socrate nell’omonimo dialogo – è un abile interprete dei poemi omerici, un rapsodo per l’appunto. Le sue performance incantano e seducono il pubblico. Socrate lo paragona a un magnete:
« Ione: […] Per quanto mi riguarda, so di sicuro quella cosa, cioè che su Omero parlo in modo più bello di ogni altro uomo, so bene cosa fare e tutti gli altri affermano che ne parlo bene, mentre sugli altri no. Ora, vedi tu di cosa si tratta.
SOCRATE: […] Il fatto è questo: il ben parlare su Omero – di cui or ora dicevi – non ti è proprio come arte; al contrario, è una divina capacità a darti l’impulso, come accade per la pietra che Euripide chiamò Magnete e i più Eraclea. Anche questa pietra, infatti, non solo attrae gli anelli – essi stessi di ferro –, ma inoltre infonde in loro una capacità in conseguenza della quale sono in grado di realizzare esattamente la stessa azione della pietra, cioè attrarre altri anelli: allora si produrrà una grande catena di anelli di ferro appesi l’un l’altro, ma per ciascuno di essi questa capacità dipende da quella pietra. Nel medesimo modo anche la Musa, proprio lei, riempie alcuni uomini di divino, e attraverso questi uomini pieni di divino si salda una catena di altri divinamente ispirati. In effetti tutti i poeti epici – quelli buoni – pronunciano tutti questi bei poemi non sulla base di un’arte, ma perché sono pieni di divino e posseduti, e così anche i buoni lirici » (Platone, Ione, 533c-e).
Allo stesso modo, i nostri rapsodi del web parlano del classico come se fossero posseduti direttamente dall’autore. Nel caso di Platone, non sono loro a parlare: è Platone stesso. La voce, la posa, la gesticolazione, l’abbigliamento, i filtri, tutto concorre a creare un effetto magnetico. Si genera una sacra catena: l’eterna verità di Platone viene svelata, e chi ascolta si sente partecipe di una realtà più grande. Grazie al rapsodo-influencer, Platone è lì davanti a tutti, in carne e ossa.
Così, magari dopo la visione di un reel di un minuto, ci si sente più sapienti, partecipi della Filosofia (con la “F” maiuscola). Mi tornano in mente le parole di Socrate nel Menesseno, quando si descrive l’effetto delle grandi orazioni funebri sugli ascoltatori:
« ascoltandoli [gli oratori] mi abbandono, incantato, come avvertendo che in quel momento sono divenuto più grande, più nobile, più bello. […] Il discorso e il suono modulati dall’oratore sono tanto melodiosi e si insinuano a tal punto nelle orecchie che al quarto o al quinto giorno riprendo appena a ricordarmi di me stesso e capisco dove mi trovo, e fino a quel momento quasi credo di essermi stabilito nelle isole dei beati » (Platone, Menesseno, 235b-c).
Le belle parole risuonano melodiose. La fatica del pensiero svanisce nella verità restituita dal rapsodo-influencer, che con frasi brevi e cristalline rende accessibili i segreti di Platone. La mia non è una digressione, ma un problema etico/metodologico che affonda le radici nella domanda da cui siamo partiti.
Per affrontare con serietà il quesito “Cosa direbbe Platone della nostra società edonista?”, dobbiamo praticare subito una forma di temperanza. Occorre, per un attimo, rinunciare alla risposta immediata, alla soluzione “usa e getta”, alle verità prêt-à-porter. Bisogna, in poche parole, astenersi dal piacere della semplicità.
Del resto, la prima grande lezione del pensiero di Platone è che filosofare significa domandare, e che la riflessione traccia campi di forza, non confini precisi.
Si può rendere accessibile Platone, ma non ridurne la complessità – pena la sua stessa mistificazione.
Stili di vita edonisti
Edonismo ingenuo e edonismo calcolante
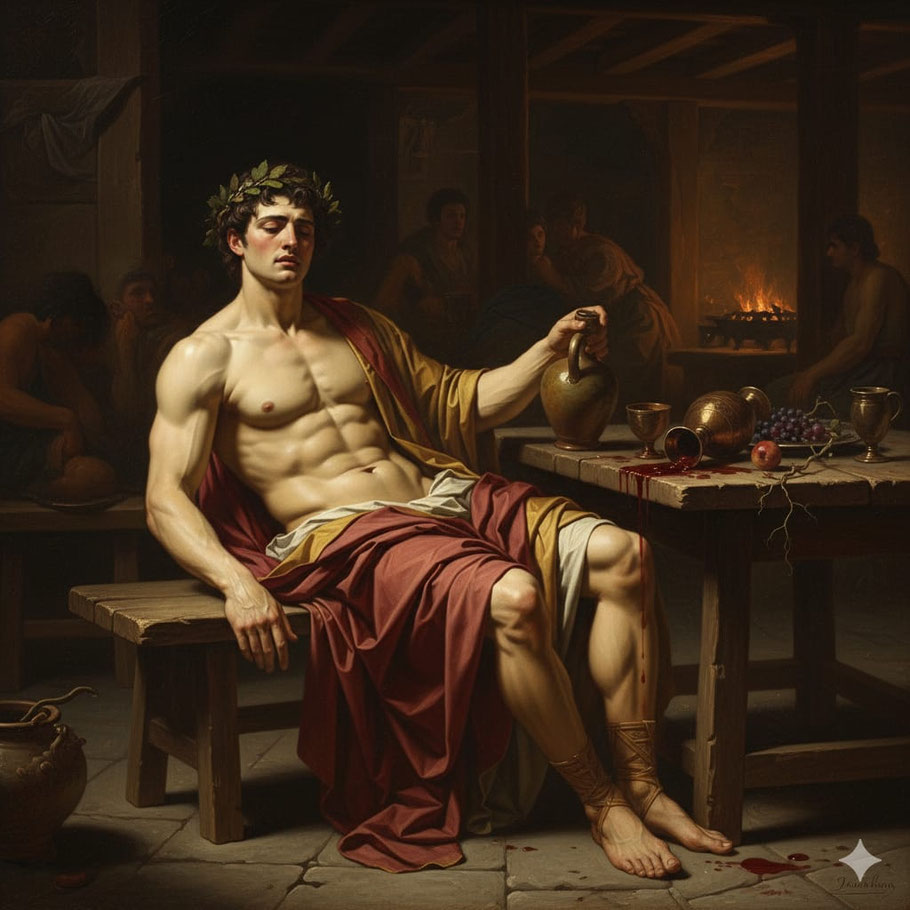
Tra i tanti luoghi comuni su Platone, vi è sicuramente il suo presunto anti-edonismo. Platone sarebbe un filosofo che disprezza il piacere, che considera il corpo tomba dell’anima. La sua figura rigida e austera si erge a castigare i costumi corrotti dell’Atene che ha condannato a morte Socrate, «un uomo – dice Platone – che non ho affatto paura di dichiarare il più giusto del suo tempo» (Platone, Settima lettera, 324 e).
Certo, Platone fu molto critico nei confronti della società ateniese. È un errore però ridurre la sua riflessione sul tema a un’invettiva moralista. Nei dialoghi platonici è ravvisabile una profonda analisi della questione del piacere sotto due importanti aspetti: concettuale e pratico – oggi diremmo esistenziale. Come spesso accade in Platone e nei filosofi antichi, teoria e prassi sono due facce della stessa medaglia. Interrogare il piacere significa mettere al centro degli stili di vita. L’edonista ha infatti molteplici volti, che Platone esplora in particolare in tre dialoghi: il Protagora, il Gorgia e il Filebo.
Per cominciare, si può essere edonisti nostro malgrado. Nel Protagora Platone delinea con un’espressione efficace l’uomo comune che si sente “vittima” del piacere.
« SOCRATE: Ad ogni modo sai che la maggior parte degli uomini […] dicono, che, pur conoscendo il meglio e potendolo seguire, non lo vogliono, ma agiscono in tutt’altra maniera; e a quanti ho domandato quale ne sia la causa, hanno risposto che lo fanno perché sopraffatti o dal piacere o dal dolore o perché dominati da qualcun’altra di quelle azioni di cui dianzi parlavo. […] Cerchiamo […] di spiegare che cosa mai accada loro quando dicono d’esser sopraffatti dai piaceri, per cui non agiscono secondo il bene, pur conoscendolo ». (Platone, Protagora, 352c-353°. Il corsivo è mio.)
Molti vorrebbero perseguire nella vita un bene più elevato, ma si lasciano “sopraffare” dal piacere. Aspirano a elevarsi, a porsi obiettivi a lungo termine, ma soccombono alle gratificazioni immediate.
Il giovane studente si propone di dedicare più tempo allo studio, salvo poi cedere per ore alla tentazione di scrollare lo schermo dello smartphone. La piccola scarica di dopamina prevale sul piacere differito di un buon voto o del successo scolastico.
Il ludopate sa bene che, se non si controlla, dilapiderà il proprio patrimonio con gravi conseguenze per sé e per i familiari. Eppure non riesce a fermarsi, e continua a soccombere alla mania del gioco.
Un discorso analogo si potrebbe fare per le tante forme di dipendenza, più o meno diffuse nella nostra società.
Per l’uomo comune si configura, insomma, un conflitto tra intelligenza e piacere: l’intelligenza sa cosa è bene e cosa è male, ma si lascia vincere dal piacere. Si è edonisti contro la propria volontà: una visione molto diffusa, che Platone tuttavia non condivide.
Nel Protagora, Socrate ne smaschera i punti deboli. L’argomentazione principale ruota attorno alla distinzione tra scienza e opinione. Chi è vinto dal piacere è, in realtà, vittima di un calcolo errato dei piaceri e dei dolori derivanti dalle proprie azioni, oppure dell’ignoranza del proprio vero bene.
Nel primo caso, non si valutano correttamente gli effetti di un comportamento in termini di piacere e dolore. Non funziona la metretica o, come direbbe l’utilitarismo, l’aritmetica del piacere.
Socrate osserva:
« Dopo avere raccolto da una parte il piacere, dall’altra il dolore, e avendo anche aggiunto, sul piatto della bilancia, il vicino e il lontano, dicci qual è il più grande. Se peserai piaceri contro piaceri, sono sempre da prendere i più grandi e i più numerosi; se dolori contro dolori, i più piccoli e i meno numerosi; se piaceri contro dolori, qualora i dolori siano soverchiati dai piaceri – dolori vicini siano soverchiati da piaceri lontani o mali lontani da piaceri vicini –, l’operazione della scelta deve farsi dove si abbia l’eccedenza; qualora invece i piaceri siano soverchiati dai dolori si deve evitare ogni azione. […] Non è così che va impostata la questione? È chiaro che non potrebbero rispondere diversamente » (Ivi, 356a-c).
Un problema dei molti è l’incapacità di valutare con oggettività piaceri e dolori vicini e lontani. Secondo Platone si genera spesso un errore di prospettiva: un dolore o un piacere futuro può apparire molto più piccolo di quanto sia in realtà, e per questo l’individuo cede a un piacere immediato. Così, il piacere a buon mercato dei cibi ultraprocessati può apparire preferibile ai dolori futuri che il suo abuso potrebbe generare. Il piacere a portata di mano dei videogiochi può apparire più allettante di quello, più lontano ma più duraturo, derivante dal sentirsi in forma praticando sport con continuità.
Non è si è allora “vinti” dal piacere; si è semplicemente vittime di un calcolo sbagliato.
Un consiglio che Platone sembra dare all’edonista inconsapevole o al cattivo edonista è: “calcola bene, misura con perizia i piaceri e dolori in modo che la somma dei piaceri prodotta dalle tue azioni sia sempre superiore a quella del dolore”.
Platone un utilitarista ante litteram?
Dopo oltre duemila anni il suo ragionamento riecheggia ad esempio in queste parole di Jeremy Bentham:
« Si dice che una cosa promuove un interesse, o che è a favore dell’interesse di un individuo, quando va ad aggiungersi alla somma totale dei suoi piaceri, o, che è la stessa cosa, a ridurre la somma totale dei suoi dolori » (J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della religione).
Sarebbe comunque una conclusione affrettata. La posizione di Platone è troppo articolata per essere racchiusa in categorie filosofiche che, del resto, non gli appartengono.
L’argomento di Socrate appare piuttosto come un tentativo di migliorare l’edonismo ingenuo dell’uomo comune. Se si vuole essere coerenti con il principio secondo cui il bene coincide con il piacere, allora è necessario imparare a effettuare i giusti calcoli, usare l’intelligenza senza cadere nelle illusioni generate dai sensi e dalla fantasia.
Ma non dimentichiamo che esiste anche un secondo caso. Spesso si sa cosa è bene, e tuttavia si soccombe comunque al piacere. Non vi è un cattivo calcolo, né inganno sul fine. Come si spiega?
Il punto è che l’intelligenza non è guidata dalla vera conoscenza, cioè dalla scienza, ma da un’opinione vera. In altri termini, la verità non è radicata, non è sentita, non trasforma la maniera di vivere. Si sa in astratto cosa è bene, ma non si comprende fino in fondo “perché” lo è.
Il giovane studente che passa ore intere a scrollare lo schermo dello smartphone sa che potrebbe fare altro – ad esempio studiare per costruirsi un futuro – ma questo sapere è astratto. Non vuole ciò che sa, perché l’opinione vera non è sentita. Non visualizza ciò che potrebbe essere, non si emoziona di fronte ai futuri possibili che potrebbero dischiudersi davanti a lui; non afferra come l’impegno profuso lo renderebbe migliore: più consapevole, più pronto ad affrontare le sfide della vita.
L’opinione vera è un guscio vuoto: non dà piacere, non motiva. Ecco perché, per il giovane, non è il vero bene, che resta piuttosto il piacere immediato dello scrolling, l’unico, in effetti, a coinvolgerlo realmente.
Lo studente non è dunque “vinto dal piacere”, ma vittima di un’ignoranza più subdola, che nasce da una finta consapevolezza di ciò che è bene. Si illude di sapere, e crede di non riuscire nei
suoi scopi per debolezza, quando in realtà il problema è che la sua opinione del bene non è ancora diventata conoscenza del bene.
Se non si colgono queste importanti sfumature – soprattutto la distinzione tra opinione vera e scienza – l’intellettualismo etico non può reggere al confronto con la realtà.
Non è tuttavia questo l’aspetto che vogliamo approfondire.
L’edonismo ingenuo e l’edonismo calcolante (metretico) rappresentano solo due possibili stili di vita edonisti.
Ne esistono altri due, molto più pericolosi e difficili da confutare, rappresentati nei dialoghi platonici da due personaggi emblematici: Filebo e Callicle.
Entrambi incarnano forme di edonismo consapevole, impermeabili al dialogo.
Filebo
Iniziamo da Filebo, che dà il titolo all’omonimo dialogo platonico. Filebo – il cui nome significa letteralmente “amante della giovinezza” – non scambia quasi alcuna battuta con Socrate. È chiuso in un altezzoso e significativo silenzio. Anche la sua tesi è riassunta da chi se ne farà portavoce, Protarco, l’unico a volerla sottoporre alla prova della dialettica.
Così Protarco enuncia la tesi di Filebo:
« Filebo allora afferma che bene per tutti gli animali viventi è la gioia e il piacere e la dolcezza del godimento e quanto ancora appartiene al genere comune a queste cose » (Platone, Filebo, 11b).
Filebo è colui che nella vita ricerca il piacere per il piacere. Non ha interesse a calcolare, a mettere sul piatto della bilancia piaceri vicini e lontani; non teme il giudizio degli altri; non ricerca altro bene al di fuori del piacere immediato, né quindi si sente vittima. È un edonista consapevole che non questiona il suo modo di vivere. La sua vita va per lui bene così come è.
Potremmo dire che Filebo è la versione migliorata di un giovane paziente, Kevin, di cui parla la psichiatra Anna Lembke nel saggio L’era della dopamina. Così il ragazzo sintetizza il proprio stile di vita:
« Faccio ciò che voglio, quando voglio. Se voglio restare a letto, lo faccio. Se voglio giocare ai videogiochi, gioco ai videogiochi. Se voglio sniffare una riga di cocaina, mando un messaggio al mio spacciatore, lui me la consegna e io sniffo una riga di cocaina. Se voglio fare sesso, vado online, trovo una ‘tipa’, la incontro e faccio sesso » (A. Lembke, L’era della dopamina)
Dico “versione migliorata”, perché in effetti Kevin non è soddisfatto della sua vita. Alla domanda della psichiatra «come ti sta andando la vita Kevin?», risponde «non molto bene» (ivi). Filebo non ha invece rimorsi, non si sente vuoto o a disagio. È un po’ come il duca de Blangis di De Sade quando afferma:
« Non ho affatto bisogno di forzare le mie inclinazioni […]; ho ricevuto dalla natura queste inclinazioni [..]. Se me le ha date malvagie, è perché sono diventate così necessarie ai suoi scopi; nelle sue mani io non sono che una macchina che lei [la natura] muove a suo piacimento, e non c’è un solo dei miei crimini che non la serva. Più me ne suggerisce, più ne ha bisogno » (De Sade, Les cent vingt journées de Sodome).
D’altra parte le mie sono supposizioni. Filebo non parla, interviene in rarissime occasioni senza comunque scendere realmente nel merito della discussione tra Protarco e Socrate. Il suo silenzio è più significativo di quello che dovrebbe o potrebbe dire. Filebo è l’edonista che rifiuta il confronto, che non ha bisogno di mettere alla prova la propria condotta.
Con il suo atteggiamento Filebo è al di fuori della filosofia, del logos; non può essere raggiunto da Socrate o scalfito dai suoi ragionamenti. Questo aspetto è importante. Le varie vulgate sul pensiero platonico-socratico tendono a enfatizzare il potere terapeutico del dialogo. In realtà, Socrate ha presa solo su chi vuole lasciarsi condurre dai suoi discorsi.
Bisogna almeno essere nella postura ben espressa da Nicia nel Lachete:
« Chi è abituale interlocutore e famigliare nel dialogare con Socrate, necessariamente anche se prima ha cominciato a discutere con lui di altro, non può evitare di essere condotto nel discorso in un giro di ragionamenti, fino a che non giunga a dare conto di se stesso, del modo in cui vive e in che modo sia vissuto in passato. E una volta che sia giunto a questo, Socrate non lo lascerà scappare, prima di averlo sottoposto a esame bene e accuratamente su tutte queste cose.
Io ho dimestichezza con quest’uomo, e so che è necessario sopportare queste cose da lui, e so bene che io stesso dovrò subire tutto questo » (Platone, Lachete, 187e-188a).
Il prerequisito è una disponibilità a mettersi in discussione, ad accettare che qualcuno, spinto da conoscenza, benevolenza e franchezza (come Socrate appunto), possa costringere a dare conto di se stessi, del modo in cui si vive e si è vissuti. Il dialogo socratico è prima di tutto elenchos, nel senso di un attento esame dell’anima degli interlocutori. Tuttavia, non tutti resistono alle parole di Socrate che spesso pungono come un tafano (L’apologia di Socrate, 31e), paralizzano come la torpedine marina (Menone, 88 a-b) o mordono come la vipera (Simposio, 217e-218b).
I logoi filosofici funzionano su chi riconosce di essere malato e di aver bisogno di cure. Altrimenti sono vani e inutili.
Platone lo rammenta con forza nella Settima lettera:
« Chi dà consigli a un uomo malato e che segue una condotta dannosa per la salute, deve per prima cosa intimargli di cambiare vita; se quello intende obbedire, deve allora procedere con ulteriori consigli; ma se non intende farlo, personalmente riterrò coraggioso ed educato all’arte medica colui che rifuggirà dal dare consigli a un individuo simile, e invece vigliacco e incapace chi farà l’opposto » (Platone, Settima lettera, 330c-e).
Nicia è disposto a dare conto di sé, ad essere confutato da Socrate. Lo stesso non si può dire di Filebo, che non ha alcuna intenzione di riflettere sul proprio stile di vita.
La filosofia, allora, non è per tutti: non perché sia difficile, troppo complicata o astratta. L’ostacolo maggiore non è sul piano della comprensione, ma dell’ascolto. Vi sono persone che si accontentano di vivere come meglio credono, senza interrogarsi sulle reali motivazioni del loro agire. L’eventuale incoerenza nei gesti o negli atteggiamenti non rappresenta un problema.
Filebo è l’edonista che non distingue tra un piacere e un altro; prende ciò che è a portata di mano, non valuta, non soppesa. È in contraddizione con se stesso, ma la cosa gli è del tutto indifferente.
Ribadisco: ciò non implica affatto che lo stile di vita di Filebo non sia confutabile, né che non conduca all’infelicità. Ma per scoprirlo, bisogna compiere un salto: entrare nella dimensione del discorso. Protarco, portavoce di Filebo, sceglie questa strada, e Socrate può così mostrare i limiti di questa maniera di vivere.
L’edonista alla Filebo ritiene che si possa vivere ricercando solo il piacere, che l’intelligenza sia superflua. Per essere felici basterebbe concentrarsi sul presente, perché è lì che si dà il piacere. Come l’ape vola da un fiore all’altro per succhiare il nettare, così l’edonista Filebo pretende di poter passare da un piacere all’altro. Tra il piacere di vincere in duello, di ubriacarsi o di mangiare fino a rimpinzarsi, non c’è differenza: un piacere vale l’altro.
Anzi, se proprio si vuole introdurre un criterio, per questo tipo di edonista esso non potrebbe che essere l’intensità. Per essere felici nella vita, bisogna ricercare i piaceri più intensi, quelli che riempiono. Più i piaceri sono intensi, più si raggiunge la vera eudemonia.
Ma è possibile vivere così? Rinunciare del tutto all’intelligenza? Si può condurre un’esistenza meramente sensibile? Disumanizzarsi al punto di spegnere la coscienza?
Tanti ci provano, soprattutto oggi, quando si hanno a disposizione miriadi di sostanze per alterare e addormentare la mente. Tuttavia, di fatto, una strada del genere non è praticabile.
Leggiamo uno dei passaggi principali della critica di Socrate a Protarco:
« SOCRATE: Accetteresti tu, Protarco, di vivere l’intera vita godendo dei più grandi piaceri? PROTARCO: E perché no? SOCRATE: E penseresti di aver bisogno di qualche altra cosa ancora, una volta pienamente ottenuta tale vita? PROTARCO: Per nulla. SOCRATE: Osserva bene: non avresti bisogno dell’intelligenza, del pensiero, del calcolo di ciò che è necessario e di tutto ciò che è ad essi fratello? PROTARCO: E perché? Avrei tutto infatti avendo la gioia, io direi. SOCRATE: Dunque vivendo così tu potresti godere dei più grandi piaceri sempre, tutta la vita? PROTARCO: E perché no? SOCRATE: Ma senza aver intelletto, memoria, scienza, senza opinione vera, non sarebbe questa la prima cosa che, direi, ignoreresti necessariamente, se godi o non godi cioè, poiché saresti privo di ogni barlume di intelligenza? » (Platone, Filebo, 21a-b)
L’uomo non può mai vivere nel presente. La sua temporalità è costitutivamente estatica: non può fare a meno di ricordare (memoria), di anticipare (intelligenza), di avere consapevolezza (scienza). Del resto, come si può provare piacere se non se ne ha coscienza, se non si può paragonare ciò che si sente a ciò che si è vissuto o si potrebbe vivere?
Filebo – e gli edonisti come lui – cercano la felicità dell’animale, una felicità per noi inaccessibile, perché nonostante tutti gli sforzi, non si vivrà mai alla stregua «di un “polmone marino” oppure di quegli animali […] che vivono avendo il corpo sotto la conchiglia nel mare» (Ivi, 21c-d). Il paragone con le meduse e i molluschi è efficace. Rende bene non solo l’idea del livello di disumanizzazione, ma anche il profondo senso di torpore cui aspira inutilmente Filebo.
Ancora una volta, dopo oltre duemila anni, le considerazioni di Socrate trovano un’eco in questo celebre e poetico passo della considerazione inattuale di Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia nella vita:
« Osserva il gregge che pascola dinnanzi a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggi; salta intorno, mangia, riposa, digerisce, salta di nuovo, e così dal mattino alla sera e giorno dopo giorno, legato brevemente con il suo piacere e con la sua pena al piolo, per così dire, dell’attimo, e perciò né triste né annoiato. Vedere tutto ciò è molto triste per l’uomo poiché egli si vanta, di fronte all’animale, della sua umanità e tuttavia guarda con invidia la felicità di quello – giacché egli vuole soltanto vivere come l’animale né tediato né addolorato, ma lo vuole invano, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo chiese una volta all’animale: Perché mi guardi soltanto, senza parlarmi della tua felicità? L’animale voleva rispondere e dire: “La ragione di ciò è che dimentico subito quello che volevo dire” – ma dimenticò subito anche questa risposta e tacque: così l’uomo se ne meravigliò.
Ma egli si meravigliò anche di se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di essere sempre attaccato al passato: per quanto lontano egli corra e per quanto velocemente, la catena lo accompagna » (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita).
L’edonista che vorrebbe degradarsi alla condizione animale vive uno scacco perenne. L’oblio di sé non è mai completo: i ricordi, le attese, la consapevolezza – anche parziale – del proprio abbrutimento generano un senso di frustrazione che non può essere del tutto rimosso.
Filebo può rifiutarsi di ingaggiare il dialogo, di mettersi alla prova. Ma la sua esistenza resta infelice, sospesa in un limbo da cui non potrà uscire per la sua incapacità di aprirsi ai logoi terapeutici.
Callicle

Un’altra figura dell’edonismo è Callicle, l’interlocutore più importante di Socrate nel Gorgia. Callicle è un uomo ambizioso, appartenente all’aristocrazia ateniese, che spera di ottenere potere e onori adulando le masse con la retorica.
Per lui è naturale che il “più forte” comandi e il “più debole” obbedisca. Non bisogna, dunque, avere paura dei propri desideri: occorre lasciarli crescere senza freni e cercare ogni mezzo per soddisfarli.
Anzi, più si ha potere, più è legittimo fare tutto ciò che si desidera.
Ecco un passo importante del discorso di Callicle:
« Bello e giusto per natura è ciò che ora ti dirò con tutta franchezza: chi vuole vivere come si deve, ha da sciogliere, non da frenare, la briglia ai propri desideri per quanto grandi siano; e, per quanto grandi siano, deve esser capace di assecondarli con coraggio e con intelligenza e dare sempre piena soddisfazione alle proprie passioni. Ma tutto questo, penso, è impossibile per la maggioranza: ecco perché i più biasimano chi vive come dico io, per vergogna, credendo così di nascondere la propria impotenza; ed ecco perché sostengono che brutta cosa è la dissolutezza, come già dicevo, asservendo gli uomini migliori per natura e, non essendo capaci di dare piena soddisfazione alle proprie passioni, causa appunto la loro impotenza, fanno l’elogio della temperanza e della giustizia » (Platone, Gorgia, 491e-492a).
Sono i deboli a condannare le passioni. Non avendo il coraggio né i mezzi per assecondare i propri desideri, hanno istituito un sistema di valori contro natura. Giudicano dissoluti e viziosi coloro che vivono intensamente, che non si pongono regole; elogiano invece chi si accontenta di un’esistenza anonima, meschina, all’insegna della temperanza e della giustizia.
Callicle è anch’egli un edonista: il potere, la ricchezza, gli onori servono a vivere piaceri intensi e grandi. Il piacere gioca un ruolo centrale nel suo stile di vita.
Tuttavia, vi è un’importante differenza che lo distingue da Filebo. Se nell’edonismo di Filebo tutti i piaceri – e dunque tutti i desideri – si equivalgono, per Callicle non si può dire lo stesso.
Socrate mette in luce questa contraddizione, facendo raggiungere al dialogo uno dei momenti di più alta drammaticità. Alla sfrontatezza di Callicle, che sembra non avere peli sulla lingua, Socrate replica a sua volta bandendo ogni ritegno:
« SOCRATE: Bene, carissimo: continua così come hai incominciato e cerca di non avere ritegni. E a quanto pare bisogna che non ne abbia neppure io. Dimmi, innanzi tutto: se uno avesse la scabbia e il prurito e potesse grattarsi come vuole, passando tutta la vita a grattarsi, questa è per lui una vita felice?
CALLICLE: Sei ben stravagante, o Socrate, e parli proprio come un oratore da plebe! […]
SOCRATE: Forse se ha prurito solo alla testa… o ti devo fare ancora delle altre domande? Guarda, Callicle, che cosa potresti rispondere se qualcuno ti rivolgesse, una dopo l’altra, tutte le altre domande, per tutte le restanti parti del corpo? Stando così le cose, in conclusione, la vita degli impudichi non è forse spaventosamente turpe e sciagurata? O avrai la sfrontatezza di affermare che costoro sono felici, purché abbiano in abbondanza ciò che occorre loro per soddisfare i loro bisogni?
CALLICLE: Non ti vergogni, o Socrate, di portare il discorso su cose di questo genere?
SOCRATE: Sono io che li porto su queste cose, o nobile uomo, o è invece colui che afferma senza alcun ritegno che sono felici coloro che godono e in qualunque modo godano, e non precisa quali piaceri siano buoni e quali cattivi? Ma dimmi ancora: affermi tu che piacere e bene sono la stessa cosa, o che c’è qualche piacere che non è buono?
CALLICLE: Dico che sono la stessa cosa, perché, se lo negassi, il mio discorso risulterebbe incoerente.
SOCRATE: Tu distruggi, o Callicle, i discorsi che abbiamo fatto prima e non potrai più esaminare con me le cose come si conviene, se dici cose contrarie alle tue convinzioni » (Ivi, 494c-495a).
Nel passo si delinea un climax. Callicle ha appena ammesso che il suo stile di vita basato sulla crescita smodata dei desideri implichi la coincidenza di felicità e piacere e che quest’ultimo vada considerato come il bene supremo dell’esistenza.
In apparenza, la deduzione va da sé: se non bisogna frenare i desideri, se tutti hanno diritto di esistere ed è giusto assecondarli con ogni mezzo possibile, allora il fine di questa condotta di vita può essere diverso dal provare piaceri grandi e intensi?
La concessione di Callicle ha tuttavia delle conseguenze paradossali, che Socrate evidenzia. Nell’ipotesi che tra un piacere e un altro non vi siano differenze sul piano valoriale, si dovrebbe considerare felice la persona affetta da scabbia che trascorre il tempo a grattarsi. Per essere coerenti si dovrebbe aggiungere che non importa ove si gratti, visto che proverebbe comunque piacere. Non ci sono zone del corpo “più lecite” da grattare! L’edonista “serio” non istituisce limiti al soddisfacimento dei pruriti!
Cosa dire poi della vita degli “impudichi”? Qui il termine greco corrispondente è κίναιδος. Nella società greca il κίναιδος era l’uomo passivo nei rapporti sessuali. La distinzione attivo/passivo era allora fondamentale: l’uomo passivo veniva assimilato alle donne e agli schiavi. Addirittura il cittadino ateniese scoperto a consumare rapporti di questo genere poteva essere privato della cittadinanza.
In qualità di uomo dell’alta società, Callicle non può che essere indignato dalla deriva dell’argomentazione socratica. Paragonare il suo stile di vita all’uomo malato di scabbia e al κίναιδος lo offende. Callicle accusa Socrate di essere un oratore della plebe e osserva come dovrebbe vergognarsi per quello che blatera.
Come si permette il vecchio Sileno di pronunciare simili sconcezze di fronte a una persona di elevata estrazione?
Da quel momento della discussione, Callicle inizia a chiudersi nel silenzio. Interagisce sempre di meno con Socrate, fino a che, nella parte conclusiva del dialogo, Socrate sarà costretto a simulare di dialogare ancora con lui, dandosi da sé le risposte alle domande.
Come Filebo, anche Callicle non è disposto a mettere in dubbio la propria maniera di vivere, o almeno per ora. Se in una prima fase del dialogo, si era gettato con foga nella discussione prendendo le difese di Gorgia e Polo (i precedenti interlocutori), successivamente, davanti all’evidenza della contraddittorietà del suo modo di vivere, si tira indispettito indietro e si rifiuta di proferire parola.
La lezione che possiamo ricavare è la stessa appresa con Filebo: la scoperta dell’incoerenza del proprio stile di vita è condizione necessaria ma non sufficiente per abbandonarlo.
Callicle è stato confutato, ma non ha colto il “senso” del logos socratico. Già nelle prime battute, ha pensato il confronto in chiave “polemica”. L’aggettivo è preso nel suo significato letterale: per Callicle, lo scambio con Socrate è visto come una sfida, un vero e proprio duello al cui termine bisogna designare un vincitore e un perdente. Al contrario, per Socrate, si tratta di testare le proprie convinzioni. Callicle è come la pietra che serve a verificare l’autenticità dell’oro:
« SOCRATE: Se avessi avuto in sorte un’anima d’oro, Callicle, non pensi che sarei tutto lieto se trovassi una di quelle pietre con cui si saggia l’oro, la migliore, per toccare con quella la mia anima, e se mi comprovasse che ho l’anima bene educata, saprei che altro non occorre e che non ci sarebbe bisogno di nessun’altro assaggio? » (Ivi, 486d).
Per Socrate non è questione di vincere o perdere, ma di comprendere se si è un’anima ben educata, se la vita sta prendendo la giusta direzione. Callicle non si rende conto che la confutazione socratica ha l’obiettivo di renderlo migliore, non di umiliarlo.
Socrate e Callicle parlano due lingue diverse: il primo la parola che cura, il secondo la parola che adula, che seduce, il cui solo scopo è primeggiare e manipolare l’interlocutore. Per questo all’avanzare della confutazione, Callicle prova solo rabbia e decide di tacere per non arrendersi in uno scontro che si gioca in realtà solo nella sua mente.
Fuori dal dialogo, anche l’edonismo di Callicle resta quindi irraggiungibile: contradditorio e incoerente per il filosofo che si colloca nel discorso, mentre per l’aristocratico desiderabile.
Il miele e l’acqua sorgiva
Platone non approva l’atteggiamento nei confronti del piacere dell’uomo comune e condanna gli edonismi di Callicle e di Filebo. È allora favorevole a un edonismo calcolante o dobbiamo considerarlo un antiedonista? In verità, soprattutto se si legge con attenzione il Filebo, la posizione di Platone non è affatto semplice da delineare. Definirlo un edonista o un antiedonista pare riduttivo: la sua concezione del piacere sembra piuttosto collocarlo al di là dell’edonismo.
Il piacere gioca per Platone una funzione importante nell’esistenza, ma occorre reinquadrare la questione all’interno di una prospettiva insieme etica e ontologica.
Nel Filebo, Platone discute di quattro generi fondamentali che costituiscono la realtà e guidano l’indagine filosofica: l’illimitato, il limite, il misto e la causa.
L’illimitato è caratterizzato da mancanza di quantità determinata e di essere stabile, comprendendo tutto ciò che è infinito per numero, senza termine e indifferentemente diveniente. Appartiene alla sfera del “più e del meno” (eccesso, intensità). Esempi includono il “più caldo e più freddo”, “più secco e più umido”, “di più e di meno”, “più veloce e più tardo”, “più grande e più piccolo”, “acuto e grave” e “fortemente e debolmente”.
Il limite agisce come una causa formale ed è interno alle cose. Si manifesta come ciò che rifiuta l’illimitato. La «progenie del limite» include l’“uguale” e il “doppio”, e tutto ciò che «fa cessare la reciproca discordanza degli opposti e li rende commisurabili e li armonizza ponendo fra di loro il numero» (Platone, Filebo, 25d-e). La misura e la proporzione sono caratteristiche chiave associate al limite.
Il misto è il risultato della mescolanza dell’illimitato e del limite. Corrisponde a quasi tutta la realtà, essendo un genere che accoglie tutto ciò che deriva dall’azione del limite sull’illimitato. Esempi di misto citati nel Filebo sono la salute, la musica, le stagioni e tutte le cose belle.
La causa è ciò che produce la mescolanza e presiede alla generazione. Nel dialogo tende a essere identificata a un’intelligenza superiore (un Nous divino) che governa l’intera realtà. Si tratta comunque di un genere che include molte cose, come la mente divina, la mente umana e tutte le cause efficienti di mescolanza (ad esempio, le conoscenze e le tecniche come principi di produzione) – queste cause particolari esemplificano infatti la causa universale.
Oltra ad avere una valenza in sé, la digressione ontologico-cosmologica fornisce delle coordinate per cogliere la prospettiva etica di Platone. Il piacere dovrebbe per definizione rientrare nel genere dell’illimitato. Il piacere è sempre in apparenza più o meno intenso, più o meno durevole. Al contrario, la conoscenza e l’intelligenza appartengono al genere del limitato e della causa e dovremmo considerarle interamente distinte dal piacere. Tra intelligenza e piacere vi sarebbe una sorta di dualismo: la prima sarebbe ciò che impone un ordine e una misura a quanto di per sé sarebbe illimitato e indeterminato.
Ma le cose non sono così semplici. Platone sostiene che non può darsi piacere senza intelligenza, memoria e conoscenza – ricordiamo quanto abbiamo appena detto a proposito dell’edonismo di Filebo. Allo stesso modo si afferma anche non può darsi per l’uomo una vita di intelligenza priva di piacere. In altri termini sia una vita di sola intelligenza che una vita di solo piacere sono impossibili, perché entrambe disumane e perché intelligenza e piacere sono inseparabili.
Nella complessa disamina sul piacere, Socrate distingue varie forme di piacere: piaceri misti, piaceri puri, piaceri veri e piaceri falsi.
Misti sono quei piaceri che racchiudono in sé anche il dolore, ad esempio quelli legati alla dinamica di riempimento e svuotamento. Possono coinvolgere l’anima, il corpo o entrambi. Sono i tipi di piacere più diffusi e frequenti.
Puri sono invece i piaceri legati alla conoscenza, alla contemplazione delle forme belle e, sul piano della sensibilità, derivanti dall’ascolto di suoni puri, di colori puri o di odori piacevoli. I piaceri puri non servono a colmare un dolore, né a porre fine a una sofferenza fisica o psichica. La loro assenza non genera dolore, e la loro presenza è spesso connaturata a certi oggetti, come nel caso del piacere estetico.
Con la distinzione tra piaceri veri e piaceri falsi, Platone salda ancora di più la sfera affettiva e quella cognitiva. I piaceri falsi possono derivare da un’opinione errata o da una speranza infondata. Mi illudo, ad esempio, di poter diventare un cantante di successo quando non ho né talento né voce. L’illusione genera piacere, ma questo si basa su una valutazione distorta delle mie qualità, generatrice di vane speranze.
Un piacere può inoltre essere falso se la sua intensità non è “normale”. Una persona avara e molto attaccata ai beni materiali può, ad esempio, provare un piacere eccessivo nel ricevere una piccola eredità, che un individuo equilibrato considererebbe irrisoria o comunque poco rilevante. La percezione distorta della realtà altera qui profondamente il vissuto del piacere.
Infine, un piacere falso può anche derivare dal considerare piacevole uno stato di quiete. Ad esempio, la cessazione di un dolore può essere giudicata piacevole, sebbene si tratti di una condizione psico-fisica in sé neutrale (né piacevole, né dolorosa).
Analogo discorso, ma di senso inverso, vale per i piaceri veri. Sono veri i piaceri che derivano dall’opinione retta, dalla scienza, da un’autentica comprensione della realtà e di noi stessi. I piaceri veri sono anche puri, perché non possono essere uniti o legati a sensazioni dolorose che ne altererebbero, in senso soggettivo, l’intensità.
La stretta connessione tra affezione e cognizione rende dunque problematica la scissione tra intelligenza e piacere. La loro separazione non va intesa come contrapposizione, piuttosto come una distinzione concettuale che implica, al tempo stesso, reciprocità.
L’intelligenza si sviluppa pienamente solo se ci si “innamora” della conoscenza, di un sapere vero portatore di piaceri puri. Allo stesso modo, chi ricerca un piacere autentico deve il più possibile rivolgersi ai piaceri della conoscenza ed educare la sensibilità ad apprezzare i piaceri puri. I piaceri misti vanno il più possibile ridotti, e chiaramente bisogna rifuggire i piaceri falsi.
Per dirla hegelianamente, l’Aufhebung di Filebo, di Callicle e dell’edonista ingenuo non è nell’edonismo calcolante, quanto nel trascendimento del piacere nel logos, nel discorso filosofico che conserva e supera il piacere, portandolo nella dimensione dell’intelligibile.
In questa prospettiva, il corpo non è negato, ma sussunto, potenziato dall’intelletto, che ne amplifica le capacità di assaporare e di soffermarsi sui piaceri puri. D’altra parte, tra intelligenza e soma il rapporto è reciproco e non unidirezionale. L’intelligenza non può fare a meno del corpo per risvegliare il desiderio di conoscenza.
Non dimentichiamo, infatti, come i diversi livelli dell’eros individuati da Platone nel Simposio siano da leggere come un percorso di ascesi, in cui il sensibile diventa la chiave per accedere all’amore dell’intelligibile.
In cosa consiste allora la vita felice, se il piacere ne è una componente essenziale, inseparabile dall’intelligenza e dalla conoscenza?
Per Platone, la felicità può darsi unicamente nella vita mista, in quell’esistenza in cui si mescolano in modo sapiente intelligenza e piacere. Nel dialogo, Socrate ricorre a un’immagine che merita di essere approfondita:
« SOCRATE: E dunque a noi come coppieri stanno di fronte certe sorgenti; si può paragonare quella del piacere alla sorgente del miele e quella dell’intelligenza a una sorgente sobria e senza l’ardore del vino, di un’acqua severa e sana. Questo è ciò che noi dobbiamo sforzarci di mescolare nel miglior modo possibile » (Platone, Filebo, 61c).
Quando ci si avvicina all’intuizione centrale di un ragionamento filosofico, le immagini possono essere di grande aiuto. Il filosofo francese Henri Bergson parla dell’importanza dell’immagine mediatrice, di «un’immagine che è quasi materia in quanto si lascia ancora vedere, e quasi spirito in quanto non si lascia più toccare – fantasma che ci ossessiona quando giriamo intorno alla dottrina e a cui occorre rivolgersi per ottenere il segno decisivo, l’indicazione dell’attitudine da assumere e il punto da cui guardare» (H. Bergson, L’intuizione filosofica).
Platone è – come è noto – un maestro delle immagini, delle analogie, degli esempi e, ovviamente, dei miti.
In questo caso ricorre a un’immagine efficace, che rilancia quanto appena detto.
Il piacere è paragonato al miele e l’intelligenza a un’acqua sana e severa. Solo chi sa ben mescolare miele e acqua otterrà l’idromele, la bevanda degli dèi. Nel mondo antico, l’idromele era una bevanda molto diffusa.
Per la buona riuscita della miscelazione è fondamentale la qualità dell’acqua, in quanto, oltre ad avere la funzione di solvente del miele, è l’ingrediente presente in maggior quantità. L’assenza di elementi estranei nell’acqua è quindi essenziale per non aggiungere al composto sapori o odori sgradevoli.
La gradazione alcolica della bevanda varia, ovviamente, in funzione della quantità di miele utilizzata: con l’aumentare della percentuale di miele, l’idromele diventa più liquoroso.
Fatte queste precisazioni, l’immagine risulta molto suggestiva. Come l’acqua pura per l’idromele, così l’intelligenza gioca nella vita un ruolo essenziale. Più l’intelligenza è pura – ossia aspira alla conoscenza ed è guidata da essa – più l’esistenza sarà piacevole.
I piaceri della vita, i suoi sapori, saranno “esaltati” dall’intelligenza; allo stesso tempo, la purezza dell’intelligenza, il suo essere cristallino, sarà valorizzata dai piaceri, che le daranno densità e sostanza.
Senza piacere, la vita è insapore; ma priva di intelligenza, la vita diventa viscosa, lenta, ottusa, agglutinata in un presente che non sa fare tesoro del passato e non guarda con saggezza al futuro.
Eppure, come ogni immagine che tenta di esprimere un’intuizione, anche la coppa di acqua sorgiva e miele, contiene molteplici sfumature, che ne impediscono la piena concettualizzazione. Miele e acqua appaiano a prima vista se non contrapposti – in quanto sono pur sempre mescolabili – almeno totalmente distinti. Tuttavia i due elementi anche nella loro separatezza si rinviano l’un l’altro. Il miele richiama un piacere del gusto in sé puro, proprio come un odore o il piacere provocato dalla visione di un colore. In quanto puro, il piacere del miele evoca i piaceri veri, quelli che dovrebbero essere perseguiti dall’uomo perché oggettivi e non dipendenti dal dolore. Inoltre sebbene viscoso, il miele ha una sua mobilità, una parziale liquidità che rinvia al carattere fondamentale dell’autentico esercizio dell’intelligenza come capacità dialettica di sapere mettere in relazione l’identico e il diverso, di adattarsi ai molteplici oggetti della realtà per comprenderli.
Analogamente, l’acqua limpida e severa ha un suo sapore e una sua consistenza, benché leggera e percepibile solo ai palati raffinati. E infatti l’esercizio più elevato dell’intelligenza è fonte di piaceri puri, apprezzabili da quelle anime che hanno appreso ormai a non essere schiave dei beni materiali e dell’apparenza.
I rinvii tra miele e acqua non solo allora solo esterni – la giusta mescolanza per ottenere una buona bevanda –, ma anche interni, perché ognuno dei due elementi implica potenzialmente l’altro.
Non dimentichiamo inoltre che il composto, l’idromele, ha qualcosa in più che le sostanze separatamente non hanno. La bevanda non è la semplice giustapposizione di acqua e miele, ma qualcosa di identico e di diverso dai due elementi. Acqua e miele sono conservate e a un tempo superate dalla loro unione che determina caratteri nuovi come ad esempio il grado alcolico. Tale aspetto costituisce un indizio rilevante, perché Platone vuole farci capire come la vita felice sia la giusta proporzione tra intelligenza e piacere, ma in senso dialettico e non matematico. Infatti – cerchiamo sempre di tenere a mente l’immagine – se la misura della vita felice fosse intesa matematicamente, allora dovremmo dire che l’eudemonia è data dalla giusta somma di intelligenza e piacere – la giusta mescolanza di acqua e miele. Tuttavia, la questione è più complessa, perché la misura della vita felice è interna al composto, ha un aspetto qualitativo, che non può essere espresso dalla semplice addizione della giusta “quantità” delle componenti.
Con l’immagine dell’idromele Platone conferma quindi il superamento dall’aritmetica del piacere, collocando la sua riflessione al di là dell’edonismo e dell’antiedonismo.
Cosa direbbe Platone dalla società edonista di oggi?
Chiudiamo la nostra riflessione ritornando alla domanda iniziale: cosa direbbe Platone della società edonista di oggi?
Alla luce delle nostre considerazioni, è chiaro che non si può dare una risposta semplice. Platone non avrebbe pillole di saggezza da dispensarci. Non approverebbe l’atteggiamento dei vari rapsodi odierni, che giocano sul piacere delle opinioni, illudendo il loro pubblico di poter acquisire a buon mercato qualche grande verità. Anzi, con molta probabilità, sarebbe preoccupato da questi adulatori dei social che si spacciano per filosofi e che ricorrono al suo pensiero per mistificarlo in frasette innocue da Baci Perugina.
Sebbene i tempi siano molto cambiati, troverebbe molte affinità tra i nostri edonismi e gli edonismi del suo tempo. L’edonista ingenuo, Filebo, Callicle sono i volti principali che l’edonismo ancora assume. L’uomo vinto dal piacere per mancanza di intelligenza, quello che si abbrutisce assecondando le molteplici dipendenze offerte dalla società, quello arrogante che pensa di avere il diritto di fare tutto e di avere tutto sono tra noi: al lavoro, per strada, nelle nostre famiglie e anche in noi stessi come pericolose disposizioni pronte a emergere non appena si abbassa la guardia.
Platone non ha la formula magica per guarirli. Di sicuro il primo passo è mettersi in discussione: a differenza di Filebo e di Callicle bisogna riconoscere che questi stili di vita generano infelicità, che condurre tali generi di esistenza significa rinunciare alla propria umanità. È la fase più difficile, perché va compiuta da soli, guardando in se stessi. Qui non vi è alcun filosofo che possa aiutare: chi non vuole farsi curare, chi è sordo, non potrà ricevere consigli.
Una volta accettato di esporsi al dialogo e alla confutazione che cura, si potrà iniziare un lungo cammino di verticalizzazione, di elevazione e di purificazione. Ma, come osserva più volte Platone nei suoi dialoghi, spesso si tratterà di soffrire, di vedere le convinzioni sgretolarsi sotto la consapevolezza delle incoerenze. Verranno a galla i pregiudizi, le opinioni false e quelle vere senza però radici profonde. L’anima mostrerà le sue cicatrici, le sue ferite ancora aperte. Si proverà vergogna per ciò che si è.
In questo cammino non vi nulla di facile, né di rassicurante. Platone direbbe anche che ben pochi saranno in grado di intraprendere il percorso e chi lo farà dovrà subire resistenze interne ed esterne. Più avanzerà nella conversione dello sguardo e nella trasformazione del sé, più si troverà solo e sarà spesso oggetto di scherno da parte degli altri. Non dimentichiamo quanto insegna il mito della caverna, soprattutto cosa accade quando l’ex-prigioniero decide di rientrare per aiutare i compagni.
Oggi è ancora più arduo rispetto ai tempi di Platone uscire dal torpore della vita dis-umana, dall’oblio di sé che la società quasi ci impone con i suoi mille divertissement.
Tuttavia, non è impossibile; la filosofia può costituire ancora un rimedio. Forse efficace per pochi, non alla portata di tutti, ma pur sempre un rimedio, sicuramente quello che può dare la svolta più profonda e durevole verso un’esistenza felice.
Ringraziamenti
Questo articolo è il frutto di lunge discussioni su Platone con Gabriele Zuppa e Francesco Pietrobelli. I loro spunti di riflessione, le loro obiezioni e domande sono alla base di questo piccolo testo. La ricerca più viva e autentica è quella che si costruisce insieme. Grazie!
13 settembre 2025
