L'arte di essere depressi
In una società nichilista e secolarizzata come quella odierna, che non costituisce altro che la continuità di quella ottocentesca e novecentesca – nell’accezione in cui viene meno il tradizionale assetto veritativo, giungendo alla mancanza di valori e ad un qualcosa di trascendentale, ovverosia indipendente dalla realtà stessa –, ecco che il punto di riferimento di ogni analisi e indagine speculativa non diviene altro che l’uomo in se medesimo.
di Yassemine Zitouni

Già ai suoi tempi, Fichte, con grande lucidità e lungimiranza, scrisse: «[Questa è] l’età dell’assoluta indifferenza verso ogni verità e dell’assoluta sfrenatezza senza un concorde filo conduttore.» (J.G. Fichte, I tratti fondamentali dell’epoca moderna presente).
Da quando Nietzsche rese noto al mondo la morte di Dio – che già Immanuel Kant aveva espresso, seppur in modo implicito, con la negazione delle sue prove esistenziali –, avvenne una definitiva rottura col passato e trapelò il relativismo. La tirannia di questo ultimo si fa riconoscere nella depressione, nella quale è possibile notare la realizzazione di quella contraddizione coltivata e divenuta sempre più radicata nel corso dei secoli.
La definizione canonica di depressione solitamente è “disturbo psichico”, “deviazione del tono dell’umore in senso malinconico”: definizioni evidentemente vaghe, che potrebbero addirsi ad un coacervo di “malattie mentali”, dalla nevrosi alla paranoia, dall’angoscia alla schizofrenia. Eppure, perché mai questo termine possiede questa sorta di prerogativa? A questo interrogativo risponde Alain Ehrenberg, ne La fatica di essere se stessi. Depressione e società:
« La depressione si assicura il successo nel momento in cui il modello disciplinare di gestione dei comportamenti, ossia le regole d’autorità e di conformità ai divieti che finora hanno orientato la storia delle classi sociali così come quella dei due sessi, devono far posto a norme che stimolano ciascuno all’iniziativa individuale, sollecitandolo a diventare se stesso. Conseguenza di questa nuova normatività la intera responsabilità delle nostre vite si colloca non solo in ciascuno di noi, ma anche nello spazio collettivo: la depressione si presenta come una malattia della responsabilità in cui domina il sentimento di insufficienza. »
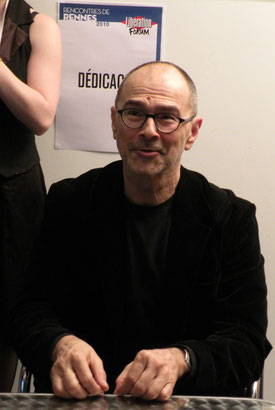
Se l’imperativo categorico “diventa te stesso” viene percepito in un accorto quadro di assoluta sovranità dell’individuo, di “autonomia decisionale” e di pressione sociale verso la volontà personale, non risulta arduo immaginare che alcuni si possano trovare in uno stato di panne di fronte alla suddetta responsabilità; questo perché, nel momento in cui viene meno il valore del bene, del giusto, del vero, ecc. viene meno anche la possibilità di discernere il concesso dal vietato, così come ciò che è malato da ciò che è sano: «se Dio è morto, tutto è permesso», diceva Dostoevskij. Ogni apparente differenza tra due situazioni non è permessa, non può più esistere uno stato migliore dell’altro. In tal senso, quello che doveva essere un processo di responsabilizzazione del singolo, che doveva farsi scrupolo di se stesso – cercando di giungere a quella che è la Verità – si trasforma, inevitabilmente, in un processo diametralmente opposto, ovverosia in uno di de-responsabilizzazione. Ogni dibattito diventa vuoto di contenuto, ogni cosa lo diviene. L’unica certezza, l’unico elemento esistente è il relativismo, per cui ognuno ha la propria opinione, che non può, però, pretendere di sopraffare quella degli altri e valere su di essa: ciascuno ha un mondo precluso, in sé, una “realtà” appartata. Il che porta il rapporto Io-Altro a cadere nell’oblio più profondo.
Se ci si addentra, ora, nel tumulto economico-politico, “il male di vivere”, in coerenza con la visione nichilistica della realtà, trova la sua giustificata presenza. Il sistema economico internazionale si basa sul capitalismo, termine oramai familiare alle orecchie di tutti, che sta ad indicare una mera usurpazione di pochi a discapito dei più, dediti ad accumulare denaro – uno strumento che si delinea come unico ed esclusivo fine dell'agire umano. Nella fattispecie, la “materializzazione”, che ne deriva e si verifica, comporta, come sostiene Marcuse, «l’unione di una produttività crescente e di una crescente capacità di distruzione; la politica condotta sull’orlo dell’annientamento; la resa del pensiero, della speranza, della paura delle decisioni delle potenze in atto; il perdurare della povertà in presenza di una ricchezza senza precedenti.» (H. Marcuse, L'uomo a una dimensione)
Pertanto, sulla base di quanto denota il sociologo e filosofo americano, per chi è assuefatto dal capitalismo, i tratti delineati verso cui si tende a puntare il dito non sono altro che la buona riuscita ed applicazione degli “ideali” capitalistici. La critica al capitalismo, in tal caso, risulta essere tanto vana quanto essa è contraddittoria. Come ingiustizia viene infatti intesa soltanto la mancata capacità di poter concorrere, come fanno i grandi capitalisti, alla lotta per il denaro, che si traduce, alla luce di quanto già asserito, in una lotta per l’esistenza, che, conseguentemente, conduce a quel sentimento di fallimento e di rancore, rientranti nella depressione.
Si diceva che la lotta per il capitale e quella per l’esistenza posso essere equiparati. Ordunque: «la competizione non funziona, però, quando la protezione legale è debole. Quando gli azionisti non sono ben protetti, la competizione favorisce il manager più disonesto, non il migliore. Quando gli investitori sono ignari, la competizione favorisce il più grande truffatore, non il migliore gestore. Quando i consumatori sono male informati, la competizione induce le imprese a sfruttare questa ignoranza, invece che a migliorare l’efficienza.»
Come afferma Luigi Zingales nel Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta – a differenza di Darwin che riteneva che a sopravvivere fosse il migliore a prescindere –, non è plausibile qualificare nessuno e nulla “migliore” (tenendo conto dell’abbattimento valoriale da parte del capitalismo), ma si potrebbe oggi parlare soltanto di un gran branco di depressi e disperati affamati.
Svoltando pagina, risulta quanto meno bizzarro il considerare depresso chi non risulta esserlo di fatto. È il caso di Giacomo Leopardi, considerato, malauguratamente, il prototipo di depresso e di pessimista, quando, invece, fu colui che, per primo, rilevò le contraddizioni che iniziarono a soffocare l’umanità. Perché l’uomo si è sbarazzato dei “dogmi” del passato, il poeta ci insegna che, tuttavia, «la responsabilità di giudicare il mondo appartiene ormai all’individuo: responsabilità che può impaurire, ma proprio assumendosi questa responsabilità diventa persona morale. […] i valori morali non più ontologicamente sorretti e garantiti devono essere rielaborati ed aver fondamento nella coscienza storica dell’uomo.» (Bruno Biral, La posizione storica di Giacomo Leopardi). Nel canto La ginestra è possibile scorgere la rivendicazione di Leopardi a tornare all’osservazione dei valori di cui l’uomo stesso ha fatto uso nel passato, già schiacciati dalla cultura relativista dell’industrialismo.
Accusa l’individualismo e, di qui, la “morale individualistica”, accusa la passività degli uomini, accusa il proprio secolo: tutti rimproveri che toccano da vicino l’uomo del XXI secolo. Chi si propone come portavoce di una tal critica non può che essere colui che maggiormente è e si sente responsabile del suo essere:
«[…] Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti
abbandonasti, e vòlti addietro i passi,
del ritornar ti vanti,
e procedere li chiami. […]»
19 agosto 2019
DELLA STESSA AUTRICE
La potente e misera pubblicità
SULLO STESSO TEMA
G. Lovison, Una realtà opprimente
A.G. Pilotto, La grande depressione postmoderna
PER APPROFONDIRE
