Adolf Portmann e la forma animale
Adolf Portmann, biologo, zoologo e filosofo svizzero ha messo in rilievo nei suoi studi una diversa concezione riguardo gli esseri viventi, in particolare gli animali, valutando il ruolo della loro forma e di ciò che appare, attraverso i concetti di interiorità e autopresentazione, instaurando così una nuova modalità di percepire e valutare gli esseri viventi.

L’importanza della forma e di ciò che appare
La visione di Portmann riguardo la necessità di un ampliamento di veduta intorno al mondo naturale, in particolare quello animale, parte da una constatazione filosofica che mette in luce alcune modalità ormai fossilizzanti che hanno caratterizzato il nostro approccio al mondo.
« Sin dai tempi più remoti, l’esperienza ha portato gli uomini a considerare gran parte di ciò che è visibile intorno a loro come una parvenza ingannevole che nasconde la vera natura delle cose. Le scienze naturali stesse hanno consolidato l’opinione secondo cui il nucleo essenziale della realtà si troverebbe celato al di sotto di numerosi rivestimenti, e le scoperte nel regno dell’invisibile o del difficilmente accessibile sono giunte a un punto tale che non dobbiamo stupirci se anch’esse, prese tutte insieme, hanno contribuito a far sì che si vedesse proprio in ciò che è nascosto il luogo in cui i grandi enigmi vanno cercati e risolti ». (Adolf Portmann, La forma degli animali).
Portmann chiama in causa un tipo di ragionamento che ha portato nel corso del tempo a svalutare il mondo fenomenico: da un lato attraverso filosofie e credenze religiose (basti pensare al pensiero platonico e alla sua suddivisione tra il mondo sensibile illusorio e il mondo intellegibile delle essenze, o anche alla concezione massiva cristiana-cattolica che si è sviluppata in occidente con un dio completamente trascendentale), dall’altro attraverso il metodo scientifico e le sue metodologie.
Un approccio quello scientifico che dal Rinascimento in poi ha creato un’indagine sul mondo basata su ricerche chimico-fisiche e su una concezione meccanicistica della natura. Lo sviluppo del mondo odierno nasce da questo approccio che continua ad essere dominante attraverso la totale predisposizione alla quantificazione dei dati e degli esperimenti che si susseguono pedissequamente perpetrando la stessa immagine della natura. Portmann insiste in un approccio qualitativo piuttosto che quantitativo della natura attraverso lo studio della morfologia, sull’importanza della forma negli esseri viventi. Non più quindi un’attenzione soltanto ai processi fisiologici e biochimici ma al mondo fenomenico in sé, alla sua apparizione. Attraverso l’approccio qualitativo nello studio degli esseri viventi, Portmann vuole ripristinare una spiritualità che si lega alla biologia, ad una integrazione tra mente e corpo superando la divisione cartesiana.
L’interiorità
È in gioco una nuova concezione dell’essere vivente che deve tener conto della propria interiorità. Attraverso questo concetto il biologo svizzero non vuole antropomorfizzare la natura, trovare una semplice esperienzialità umana negli enti naturali ma sostenere che gli organismi sono entità formali che organizzano la loro esperienza vitale nel mondo attraverso processi interiori che rimangono inconsci.
« Dato primario è per noi l’essere individualizzato, la cui attività interna produce un rapporto con il mondo di ricchezza assai variabile, e che, in nuce, in alcuni suoi tratti essenziali ci appare già predisposto a questo rapporto in forza di determinate strutture e processi ereditari. Certi caratteri distintivi dei viventi, come la reazione agli stimoli, l’attività nervosa, le funzioni dei sensi e il movimento, sono elementi di quel complesso stato di cose che costituisce il rapporto con il mondo. L’insieme di queste attività correlate all’ambiente è ciò che chiamiamo l’interiorità, espressione designante una realtà non spaziale che non va confusa con l’insieme degli organi interni del corpo ». (A. Portmann, Le forme viventi).
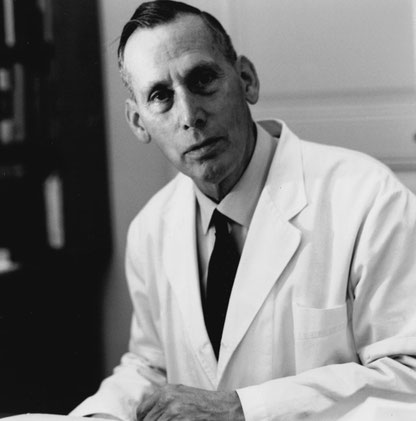
L’interiorità si manifesta nel mondo sensibile attraverso la forma esteriore. L’indagine portmanniana si concentra nel valutare le apparizioni delle forme animali nel mondo. L’importanza della forma animale come manifestazione dell’interiorità serve a proporre una nuova visione rispetto a quella strettamente neo-darwiniana che valuta la morfologia un aspetto secondario, rispetto alle caratteristiche ritenute fondamentali dell’animale: la riproduzione e la conservazione attraverso la selezione.
L’apparenza fenomenica ha significato in sé stessa e non deve essere ricondotta ad un riduzionismo che tenta di svalutarne la forma per ricondurre il significato a funzioni riproduttive o conservative delle specie animali. Portmann vuole evitare che il fenotipo venga interpretato solo in relazione alle funzioni, quali il comportamento alimentare, predatorio, la selezione sessuale, il mimetismo ecc. Intorno agli esseri viventi c’è da ripristinare un ventaglio interpretativo più ampio.
Pur essendo uno scienziato evoluzionista, l’enfasi posta da Portmann intorno al significato della forma e di ciò che appare deriva dal pensiero di Johann Wolfgang von Goethe, interessato ad indagare i fenomeni sensibili vedendone l’essenzialità manifesta. Ciò che si manifesta, discostandosi dal rapido riduzionismo, deve essere indagato poiché è un linguaggio che parla da sé. Portmann lega ciò che è superficiale ed esterno con la massima profondità esprimibile. Esiste una sorta di superficie profonda ed è lì che secondo il biologo svizzero deve indagare la scienza. Negli animali questo avviene attraverso le più svariate modalità: i mammiferi con pelli e pellicce, i volatili con penne e piume e i pesci con le scaglie.
L’autopresentazione come caratteristica principale
La manifestazione dell’aspetto visibile viene descritta da Portmann con l’autopresentazione: l’espressività di ogni individuo nel suo rapporto con il mondo. L’autopresentazione travalica il semplice funzionalismo biologico per addentrarsi in una considerazione vitale maggiore che tenga conto del valore formale in sé. Portmann avanza una diversa considerazione di ciò che comunemente si intende per organismo, sostenendo che ogni essere vivente è una totalità manifestantesi che supera le concezioni ordinarie di comprensibilità. Non può quindi esserci un approccio soddisfacente che non parta da questa visione totalizzante poiché si incorrerebbe in una visione parziale ed insufficiente riguardo una tematica che trascende tali approcci semplicistici.
« Solo una concezione complessiva di questa realtà a noi ignota ci permette di intendere in tutta la loro ampiezza i rapporti degli esseri viventi tra loro e con il mondo inanimato». La morfologia dei viventi induce a trovare un nuovo approccio di studio a cui Portmann dà il nome di fanerologia, che comprende tutto quello che si manifesta e che diventa assimilabile dai nostri sensi. Una considerazione fanerologica degli animali consente di capire che le «forme organiche intorno a noi non sono affatto fenomeni casuali, bensì ‘composizioni’ che vengono messe in scena. La possibilità di comprendere la pièce rappresentata non dipende dalla conoscenza tecnica scenica, ma da fattori del tutto diversi ». (A. Portmann, La forma degli animali).
L’autopresentazione serve a dire che le manifestazioni senza destinatario (ciò che compone esteriormente la forma animale) esistono in sé e la percezione rimane in potenza. C’è nell’autopresentazione il nuovo valore d’essere degli organismi, che si discosta dalla mera percezione in quanto «essere non equivale ad essere percepito». (Pietro Conte, Prefazione a La forma degli animali).
Prima di essere visto l’animale è, si manifesta a sé stesso attraverso la forma e le sue apparenze fenomeniche servono a ricordare questo carattere distintivo primario. La percezione è quindi un carattere potenziale, da cogliere secondariamente, e che si sottomette alla dominanza dell’autopresentazione come manifestazione dell’interiorità. L’essenzialità per Portmann è nel manifestarsi, nel venire alla luce della vita. Proprio la visione del vivente che si dischiude alla luce attraverso l’autopresentazione deve «essere considerata secondo la massima ampiezza e […] intesa come un modo di essere che si radica nell’incomprensibile, nell’enigma della realtà». (A. Portmann, La forma degli animali).
18 ottobre 2025
SULLO STESSO TEMA
Leonardo Ursillo, Evoluzione, Antropocene ed ecologia: una riflessione filosofica
M. Pieretti, Libero uomo in libera Natura
