Considerazioni comparative su Schopenhauer e il Buddha
A Schopenhauer è da tempo stato attribuito il merito di esser stato tra i primi intellettuali in Europa ad aver introdotto nel proprio edificio filosofico elementi provenienti dalle tradizioni sapienziali indiane. Questo contributo, ponendosi idealmente sulla scia di un mio precedente articolo, Schopenhauer e il Buddha: abbozzo di un confronto, intende proseguire la comparazione tra il “saggio di Francoforte” e il Buddha, sia pure entro limiti di spazio ristretti che, com’è ovvio, impediscono analisi particolarmente approfondite.

In termini schopenhaueriani, potremmo dire che in linea di massima valga anche per la gnoseologia della tradizione pāli quella palmare verità di chiaro stampo idealistico con la quale il filosofo di Danzica apriva il suo chef-d'œuvre, e cioè die Welt ist meine Vorstellung (“il mondo è la mia rappresentazione”): da par sua, il Samiddhilokapañhā-sutta, non dissimilmente nella sostanza, chiarisce come il mondo (loka) e la sua nozione (lokapaññatti) risultino dalla sinergia dei fattori in virtù dei quali solo ha senso parlarne ed esso può apparire, ovverosia occhio, forme visibili, coscienza visiva e oggetti per suo mezzo conoscibili, e così via con i successivi elementi.
L’apparato cognitivo tramite cui il mondo è percepito (lokasaññī) e concepito (lokamānī) potrebbe essere inteso come condizione di possibilità dell’esperienza stessa del mondo, e in quanto tale come “a priori”, ma allo stesso tempo esso stesso sarebbe “a posteriori”, in quanto parte di quello stesso mondo (lokasmi) che per suo tramite si manifesta. Schopenhauer parlerebbe forse, rispettivamente, di un metodo d’indagine “soggettivo”, basato sull’autocoscienza, e uno “oggettivo”, basato su considerazioni a posteriori che, nel suo caso, erano soprattutto d’ordine fisiologico.
Come, poi, in Schopenhauer, fin dalla Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente (1813), è limpidamente formulato il pensiero per cui il soggetto del conoscere non possa mai esser reificato, giacché esso costituisce in ogni caso l’immancabile correlato e la condizione necessaria di ogni rappresentazione, similmente, il citta (mente/coscienza) buddhista è essenzialmente definito come ciò che, avendo la funzione di conoscere un oggetto, senza il quale non potrebbe manifestarsi, non può a sua volta essere ridotto al suo rango: paritetici, soggetto e oggetto si sostengono a vicenda, ma mantenendo ciascuno la propria immiscibile natura. Dunque, che “ogni conoscenza presuppone necessariamente il soggetto e l’oggetto”, come si esprime Schopenhauer, è posizione teoretica che anche un buddhista di scuola Theravāda potrebbe sottoscrivere senza con ciò sconvolgere il proprio sistema dottrinale: anche per lui varrebbe che:
« Con il soggetto è posto subito anche l'oggetto e , nello stesso modo, con l'oggetto il soggetto, dunque essere soggetto significa esattamente la stessa cosa che avere un oggetto ed essere oggetto la stessa cosa che essere conosciuto dal soggetto » (A. Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, § 41).
Soggetto e oggetto, quindi, esistono e cadono insieme, e tra di essi non è possibile alcun rapporto di subordinazione: essi esistono a pari titolo, sicché né il soggetto prevale sull’oggetto, come vorrebbe l’idealismo soggettivo di Fichte, dove l’Io pone il Non-io, né può darsi il caso contrario di prevalenza dell’oggetto sul soggetto, come vorrebbe un certo materialismo che, indagando la materia nelle sue tappe evolutive fino alla sensibilità animale e alla coscienza, vorrebbe infine farne scaturire il soggetto stesso.
Ma come analogamente in ambito buddhista, ove la causalità non si applica alla realtà ultima del nibbāna, bensì soltanto al saṃsāra, che ne è una sorta di “copertura” ed esperienza trasognante, Schopenhauer osserva che il materialista fa della causalità una veritas aeterna, non considerandone la natura trascendentale, ossia a priori.
Ora, è vero che il Buddha non ha mai formulato la tesi dell’idealità della causalità ed egualmente delle forme di spazio e tempo, tuttavia, avendo invece espresso in termini inequivocabili l’alterità reciproca tra saṃsāra e nibbāna, che presentano caratteristiche non semplicemente diverse, ma opposte (come si desume, ad esempio, dall’Ajāta-sutta e dal Paṭhamanibbānapaṭisaṃyutta-sutta), in un certo senso potremmo ritenere che avesse in qualche misura intuito che le leggi del primo (spazio, tempo, causalità) non valgono nel secondo, perché il saṃsāra rappresenta il dominio del fenomeno o della rappresentazione, mentre il nibbāna è di natura metafisica, ancorché sia “proprio qui” (idheva, dice l’Ātāpī-sutta) a poter essere realizzato. Non può essere, dunque, il principio di causa a portare al nibbāna: come dirà Buddhaghosa (V sec.) in un passo del suo Visuddhimagga (XVI, 71), anche se esiste un metodo che conduce al nibbāna, questo permane come “non-prodotto” (appabhava), poiché, in quanto estraneo alla categoria della causalità, che pur impera anche dal punto di vista etico (kamma) nel saṃsāra, non può essere inteso come l’effetto di un processo causale, foss’anche di cause virtuose.
Questo è senz'altro un aspetto rilevante, se si considera quanto importante sia la causalità nell'insegnamento del Buddha, tanto da esser stato compendiato da un pur giovane e inesperto monaco di nome Assaji attraverso una famosa strofa (gāthā), ancora popolare in Asia, che dice: “Di quei dhamma che sorgono da una causa, il Tathāgata (viz. il Buddha) – il Grande Asceta – ha insegnato la loro causa e la loro cessazione”; per tacere della minuta ed estesa analisi della “condizionalità” (idappaccayatā) da parte del monumentale Paṭṭhāna.

Ripercorrendo il corso di cause ed effetti non si arriverà alla loro sorgente originaria, ma – come dice Schopenhauer - “ci si muove senza termine e senza meta”, di fenomeno in fenomeno, giammai oltre quel che ancora esiste indipendentemente da esso: il Wille per lui, il nibbāna per il Buddha. È vero - corre l’obbligo di dirlo con chiarezza e franchezza - che, pur essendo queste a pari titolo realtà metafisiche che stanno dietro l’apparenza, il secondo, a differenza del primo, non è ciò che si oggettiva come “adeguata obiettità” nei paradigmi delle realtà sensibili (le idee platoniche) e come natura, né ciò che sorregge la manifestazione in ogni sua espressione. Su questo punto, così importante, la distanza tra Schopenhauer e il Dhamma buddhista è enorme e incolmabile.
Più interessante e accostabile è invece la concezione del corpo: il Buddha e Schopenhauer, in questo mirabilmente concordi, ma solo da un punto di vista generale, ne fanno il locus revelationis della verità: il primo, infatti, nel Rohitassa-sutta dice esplicitamente che è “in questo corpo” (kaḷevara), con la sua percezione (sasaññī) e il suo intelletto (samanaka), che vengono descritti il mondo, la sua origine, la sua cessazione e la via che a ciò mena, ossia esso dischiude le quattro verità dei nobili, come da glossa del commentario; il secondo, dal canto suo, fa osservare che, se per un verso il corpo è oggetto tra gli oggetti sottoposto alle loro stesse leggi, per altro verso, vissuto introspettivamente in prima persona, è ciò che per ognuno è l’immediatamente conosciuto, e cioè quella che egli stesso chiama volontà (Wille).
Dunque, sebbene ciò che il corpo rivela sia ben diverso, il Buddha e Schopenhauer vedono nel corpo-vivo (il Leib, direbbero i fenomenologi), similmente, il luogo attraverso cui la dimensione fenomenica “tocca” quella più profonda che vi soggiace, nel primo caso svelando le verità che servono a trascendere il saṃsāra, nel secondo, che ne parla come di un “camminamento sotterraneo”, svelando la radice noumenica del mondo come rappresentazione. Detto altrimenti, il corpo è in entrambi veicolo di una conoscenza che non si arresta alla sfera fenomenica, ma permette di travalicarla, attingendo la realtà dietro l’apparenza o, nei termini di Schopenhauer, penetrando nella “cittadella” della cosa in sé.
Sebbene sia la tradizione buddhista antica che la filosofia schopenhaueriana in fin dei conti siano, però, ambigue nei confronti del corpo - l’una perché invita ad averne una certa diffidenza, ad esempio contemplandone le impurità (asubhabhāvanā) per allentare l’attaccamento virtuale o attuale, l’altra perché addirittura invita a farne oggetto di macerazione, sottoponendolo a durissime privazioni ascetiche e arrivando a vedere favorevolmente la morte d’inedia come unica forma accettabile di suicidio -, entrambe vi vedono non un elemento di oscuramento e di disturbo dell’autentica conoscenza della realtà, ma come ciò che permette, piuttosto, di condurre a siffatta conoscenza: non facendo astrazione dal corpo stesso, ma sprofondandovi introspettivamente. Tutt’altro, allora, che tomba dell’anima, secondo il celebre gioco di parole tra soma e sema, il corpo si configura come quel “luogo” in cui la verità su se stessi e sul mondo viene alla luce più direttamente e chiaramente che in altre condizioni.
Del resto, Schopenhauer era d’avviso che la conoscenza che all’essere umano è possibile avere della volontà come in-sé del mondo fosse in ogni caso imperfetta e inadeguata, proprio perché essa matura (nell’uomo) con la mediazione del corpo e dell’intelletto, che sono, peraltro, ambedue sue oggettivazioni. Il “saggio di Francoforte”, forte della lezione kantiana, insiste a più riprese sui limiti teoretici dell’essere umano nei confronti dell’intimo nucleo del mondo, affermando chiaramente che vi sono questioni propriamente trascendenti destinate a rimanere insolute non soltanto nella sua stessa filosofia, ma in ognuna che, semplicemente, voglia essere seria e onesta.
Domandarsi, pertanto, cosa possa essere in sé quella volontà che si manifesta nel mondo e come mondo, ossia indipendentemente dal suo fenomenizzarsi, è questione che la filosofia non è in grado di risolvere: infatti, l’esser-conosciuto implica già che si perda il “contatto” diretto con l’essere-in-sé, poiché “ogni conosciuto è già in quanto tale solo fenomeno”. Come chiarito ne Il primato della volontà, “ciò vale anche nel caso in cui il conosciuto è la mia propria essenza [viz. la volontà], dal momento che, cadendo nella mia coscienza, essendo cioè conosciuta, è già apparenza, ossia qualcosa di diverso da quella essenza”.
Problemi analoghi si trovano anche nella tradizione buddhista antica, seppur non esplicitamente formulati. Ci si potrebbe chiedere, infatti: quel passaggio dal condizionato all’incondizionato dato come possibile dal Buddha dal punto di vista pratico, quale giustificazione teorica può ricevere? Ovverosia, se il nibbāna – come dice Buddhaghosa – non è prodotto dal Sentiero che pur vi conduce, si dovrebbe forse concludere che sia un assoluto del tutto irrelato e incommensurabile al dominio fenomenico? Se così fosse, in che modo sarebbe possibile “realizzarlo”? Servirebbe un “salto”, ma in che senso esattamente? La tradizione scolastica risponde alla questione introducendo forme sopramondane di coscienza (lokuttaracitta) che assumono come oggetto il nibbāna, ma se invece si volesse limitare il nostro interrogare i testi in lingua pāli ai soli sutta, quale risposta vi troveremmo? Se noi non fossimo che esseri in tutto e per tutto condizionati, allora, con tutt’evidenza, qualsiasi cosa facessimo o ci astenessimo dal fare non potremmo far altro che rimanere nella dimensione condizionata. Affinché il transito verso “quella dimensione” (tad āyatana) che è il nibbāna sia possibile, non bisognerebbe postulare che già all’interno del fenomenico vi sia il germe del suo stesso superamento o, comunque, un principio di natura non fenomenica che renda possibile la scoperta e l’attingimento di quello che in termini buddhisti si chiama asaṅkhata-dhātu (“elemento incondizionato”)?
Anche Schopenhauer, d’altro canto, dovette ammettere che nel fenomenico vi fosse quello che è stato chiamato un “residuo non fenomenico”, riconoscendo, nei Parerga e Paralipomena (1851), che l’individualità non sia cosa che riguardi unicamente il fenomeno tramite il principium individuatonis, ma abbia altresì radici nella cosa in sé. In modo abbastanza simile, come si ricorderà dall’insegnamento del Rohitassa-sutta, è a partire dal corpo, nel saṃsāra, che si dà l’accesso a quell’oltre il fenomenico che è, tuttavia, anche immanente in esso: “in questo corpo” – diceva il Buddha (concezione che, per altre vie, raggiungerà il suo apice in quella spiritualità tantrica secondo la quale “senza il corpo, non c'è liberazione”, nei termini del Kiraṇa-tantra: na dehena vinā muktiḥ).
Una possibile soluzione per il buddhismo antico sarebbe quella di ammettere che l’incondizionato non sia anch’esso conosciuto come fenomeno, sia pure in modo eccezionale, ma ciò che permane quando l’intera manifestazione, col suo continuo sorgere e svanire, sia superata attraverso l’estinzione della mente e dei suoi fattori: non a caso, il nibbāna è detto bhavanirodha, “cessazione del divenire” oppure “cessazione dell’esistenza condizionata”.
L’immagine complessiva dei sutta intorno al nibbāna è quella di un elemento che, sfuggente, è sia immanente che trascendente; ma qual è il tessuto connettivo tra questi suoi due aspetti? Come si conciliano? Come si rapportano l’uno all’altro? Se, poi, esso fosse davvero incommensurabile e totalmente altro rispetto alla dimensione condizionata, al saṃsāra, allora a rigore non dovrebbe essere in alcun modo pensabile e raggiungibile e, di conseguenza, neppure sarebbe filosoficamente corretto derivarne le caratteristiche in modo antitetico con quelle del saṃsāra stesso, come però fa, ad esempio, il Paṭhamanibbānapaṭisaṃyutta-sutta.
Cosicché, rigorosamente ragionando, non se ne dovrebbe poter dire davvero niente, nemmeno, al limite, che sia il contrario del saṃsāra, perché questo suo esser-contrario presupporrebbe che tra i due vi sia un rapporto: un rapporto, nella fattispecie, di antitesi.
L’assenza o l’insufficienza della giustificazione teorica del rapporto tra condizionato e incondizionato suggerisce che, pur avendo un riferimento in qualche modo metafisico al nibbāna, l'insegnamento del Buddha, eminentemente pratico, non fosse interessato a tematizzarlo in termini speculativi, quali richiesti, invece, da una filosofia genuinamente teoretica.
Dunque, dalla prospettiva del Buddha, che teoreta non era, presumibilmente si riteneva bastante la fattibilità, la possibilità pratica - da lui stesso e dai suoi discepoli realizzati inverata - di prendere la via d'uscita dal saṃsāra “pervenendo”, se è lecito esprimersi così, al nibbāna, quale che possa essere la delucidazione teorica di un simile “passaggio”, per esprimersi ancora in termini approssimativi e “metaforici” in mancanza di migliori. Ciò suffraga l'idea schopenhaueriana secondo la quale un santo non sia necessariamente un filosofo e, come testimonia la vita stessa del “saggio di Francoforte”, un filosofo non sia necessariamente un santo. Di conseguenza, un santo-asceta può essere in grado di estinguere il dolore pur senza sapersi dare spiegazioni precise in termini filosofici astratti; viceversa, un filosofo può sapersi spiegare il mondo in modo chiaro ed esatto senza per questo essere automaticamente un mistico che ha redento se stesso dal male.
Proseguendo, tanto nel Buddha quanto in Schopenhauer, il dolore è visto come il punto d’avvio della riflessione e auspicabilmente della prassi volta al suo superamento. Nella tradizione buddhista, è solo a partire dalla completa comprensione del dolore (pariññeyya), nella sua natura e nelle sue cause, che è possibile adoperarsi per trascenderlo con un metodo, quello messo a punto dal Buddha, preordinato esattamente a tale scopo. Lo sprone, in particolare, è dato dal saṃvega, vale a dire quel senso opprimente di sgomento dinanzi alla vanità dell’esistenza come data e vissuta ordinariamente, che, d’altra parte, dà l’abbrivio a quella ricerca spirituale – ora sentita come assolutamente urgente – finalizzata a trovare una via d’uscita dal ciclo insensato della vita comune.
Il Buddha parla proprio di nissaraṇa (Itivuttaka, 43) per indicare la strada che conduce di là da ciò che è nato (jāta), divenuto (bhūta), fatto (kata) e condizionato (saṅkhata): in una parola, di là dal saṃsāra che, più o meno penoso, è comunque insoddisfacente. Non diversamente nella sostanza, a ragionare sull’articolazione dell’opus magnum di Schopenhauer, vi si potrebbe vedere – secondo le parole di Giuseppe Invernizzi –
« La storia del percorso ascetico dell'uomo che, colpito dal dolore del mondo, ne cerca la ragione dapprima nell'evanescente mondo fenomenico, poi nell'essenza stessa della realtà. In seguito, attraverso l'arte, la morale e l'ascesi, egli giunge alla liberazione da questa stessa realtà e con essa dal male » (G. Invernizzi, Invito al pensiero di Schopenhauer)
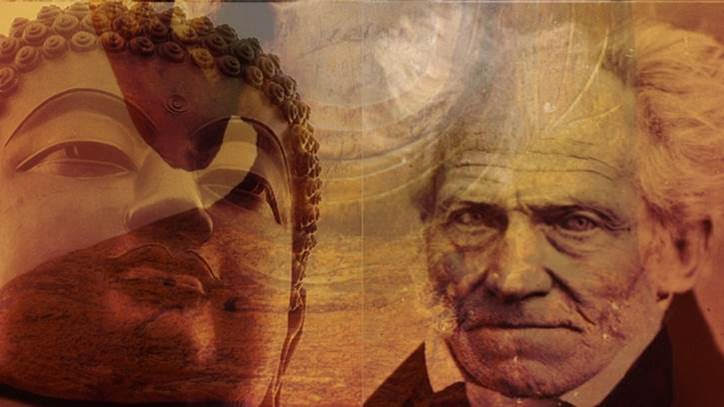
Se già la nascita è connotata da sofferenza (dukkha) – come si apprende dalla prima specificazione della nobile verità della sofferenza offerta dal Buddha nel Dhammacakkappavattana-sutta -, intendendo per nascita (jāti) il costituirsi dell'esperienza in virtù della manifestazione (pātubhāva) degli “aggregati psico-fisici” (khandha) e dell’acquisizione (paṭilābha) delle “basi sensoriali” (āyatana), ne consegue che, coincidendo gli uni e gli altri con il “mondo delle formazioni” (saṅkhāraloka), il mondo stesso è (caratterizzato da) sofferenza. Questa, del resto, non è la sua natura immutabile, ma una caratteristica che, applicando il metodo a otto membra buddhista (ariyāṭṭhaṅgikamagga), è possibile risolvere nel suo contrario: uno stato di felicità incondizionata, non più soggetta a questa o quella condizione, com’è, invece, per l'uomo comune (puthujjana).
Un simile esito è ammesso anche da Schopenhauer, quando parla del santo che abbia superato il mondo, ovvero che sia passato dal Velle al Nolle, del quale però, come del nibbāna, pressoché nulla si può dire, a parte che “la sua apparenza non può essere quella del Velle”, in modo analogo al nibbāna che è altrimenti dal saṃsāra.
Al netto delle più ovvie e vistose differenze tra i rispettivi sistemi, buddhista e schopenhaueriano, si può inoltre osservare che, come il santo tratteggiato da Schopenhauer non attende che la dissoluzione del corpo per attingere la piena liberazione, comparabilmente quello buddhista ha spezzato le catene dell’esistenza o divenire (parikkhīṇabhavasaṃyojana) e, dunque, portando il suo ultimo corpo (antimadehadhārī), ne attende pazientemente il venir meno per essere affrancato totalmente e irrevocabilmente dall’intera dimensione condizionata: entrambi i tipi di santo hanno superato il mondo. Come scrive Schopenhauer in riferimento alla sua figura del santo, usando termini che in linea generale sarebbero applicabili anche a quello buddhista (arahant),
« Vediamo in essi in luogo dell'inquieto aspirare, della gioia esultante e dell'acuta sofferenza in cui consiste l'esistenza dell'uomo voglioso di vita, una quiete imperturbabile e un'intima serenità, uno stato che non possiamo guardare senza nostalgia e che dobbiamo riconoscere come infinitamente preferibile, come il solo giusto, al cui confronto diventa chiara la nullità di tutto il resto. » (A. Schopenhauer, Manoscritti giovanili, 1816)
A questo punto, bisogna segnalare come al buddhismo antico manchi una chiave interpretativa del reale che, sola, ne consenta una spiegazione unitaria, com'è invece il Wille, che, nel sistema di Schopenhauer, si applica a tutto, dalle idee alle forze naturali, dalla natura inorganica agli animali e all'uomo. Se nel Dhamma di primo acchito si potrebbe pensare - in certa misura legittimamente - al non-sé (anattā), in quanto riguardante tutti i dhamma (ossia, i fattori irriducibili dell'esperienza), è pur necessario notare che questo non è la realtà essenziale del mondo al pari del Wille, ma, semmai, quella caratteristica (lakkhaṇa) che, soprattutto nel Mahāyāna, della realtà significa l'insostanzialità, la mancanza di un'essenza separata e sempiterna, ciò che tecnicamente si chiama svabhāva (“natura propria”).
Inoltre, come Schopenhauer sosteneva che per trovare vera quiete, felicità e pace bisognasse abbandonare l’illusione e, dunque, la vita, in cui la volontà afferma se stessa, analogamente il Buddha riteneva che solo il nibbāna – per definizione altro dalla dimensione dell’esistenza ordinaria - potesse fornire quella felicità suprema (sukha) che nel saṃsāra può, tutt’al più, essere un “ideale regolativo” della propria condotta volta a trascenderlo. Ciò non esclude che anche nel saṃsāra sia possibile vivere esperienze felici, come quelle finanche “beatifiche” legate agli stati di assorbimento meditativo profondo, ma in ultima istanza nessuna può reggere il confronto con la gioia del nibbāna.
E ancora, è interessante che – come riportato or ora - Schopenhauer leghi strettamente illusione e vita, non così diversamente, mutatis mutandis, da quanto si ritiene nel buddhismo: infatti, l'esistenza, il tornare a esistere sempre di nuovo, è frutto di un errore epistemologico – in tal senso di una “illusione” da parte del soggetto - che si ripete da tempo incalcolabile, sicché un buddhista, entro certi limiti, potrebbe convenire con il filosofo tedesco quando questi sostiene che illusione e vita siano indisgiungibili. Già il mero fatto d’esistere, infatti, è dovuto a un certo grado di nescienza, poiché, se questa non fosse, neppure l’esistenza nel saṃsāra sarebbe: il soggetto ne sarebbe svincolato e, dunque, non rinascerebbe. In breve, finché la retta conoscenza del mondo non maturi, si è destinati a rinascere e, dunque, a esperimentare in misura variabile la sofferenza intrinseca al ciclo di nascita e morte.
Se, quindi, Schopenhauer scriveva che la vita fosse qualcosa “da cui dobbiamo ravvederci come da un errore”, un adepto buddhista potrebbe trovarsi d’accordo nella misura in cui anche per lui la vita saṃsārica si deve a un’illusione che occorre smascherare e riconoscere come tale per potersene finalmente affrancare.
Nella tradizione buddhista, solo il nibbāna è paramaṃ ariyasaccaṃ, suprema, nobile verità, laddove il saṃsāra è un sogno dal quale ci si deve destare, com'è implicito nella nozione di bodhi, ossia, appunto, “risveglio”.
Eppure, per quanto possa essere dolorosa e negativa, foriera di continui attriti con la vera natura delle cose, è a partire dall’esperienza dell'illusione che la persona assennata dirige la mente verso l'attingimento del vero, è l’illusione che pone le condizioni di partenza affinché il soggetto passi da uno stato di confusione e oscurazione mentale alla chiarezza luminosa della gnosi (paññā), la cui caratteristica è proprio quella di illuminare (obhāsanalakkhaṇa). Se, dunque, non c'è risveglio senza sogno, se non c'è sapienza senza ignoranza, allora proprio l'illusione del saṃsāra ha una sua certa qual funzione soteriologica e, in questo senso, è importante, per non dire indispensabile.
Dal saṃvega, perciò, derivano le premesse della liberazione: in Schopenhauer come nel Buddha, è la natura dolorosa del mondo a dover essere sfruttata in direzione del sommo scopo della vita, e cioè, per entrambi in linea generale, il superamento definitivo della sofferenza: “proprio il dolore e gli affanni mirano a raggiungere il vero scopo della vita”, asserisce Schopenhauer, ovvero, in particolare, nel suo caso l’annullamento del volere come forza metafisica, nel caso buddhista l’attingimento del nibbāna tramite l’arresto di quella brama (taṇhā) che, come fattore mentale causa di continuo dolore, è tipica dell’esistenza cieca dell’individuo comune.
Anche intorno alla natura del mondo si registra un certo grado di affinità tra la filosofia schopenhaueriana e la tradizione buddhista antica, poiché, se nella prima il dolore non è un accidente, un’eccezione, qualcosa di imprevisto e imprevedibile, bensì la necessaria conseguenza dell’affermazione della volontà, nella seconda il Vajirā-sutta afferma che “niente a parte la sofferenza sorge, niente a parte la sofferenza cessa”.
Come intendere questa dichiarazione inizialmente sibillina? Essa vuol esprimere l’idea che, in quanto la sofferenza è intimamente connessa o addirittura si identifica con il “condizionato” (saṅkhata), che continuamente sorge e scompare, senza mai poter essere afferrato, se non in modo chimerico e in definitiva frustrante, allora si può anche dire che la sua caratteristica sia quella del dolore, ma anche, con pari forza, che il suo destino sia passibile di essere modificato in senso soteriologicamente profittevole: se è vero, infatti, che – di concerto con la Weltanschauung schopenhaueriana - tutto ciò che viene in essere e scompare è solo sofferenza, è egualmente vero che, in Schopenhauer come nel buddhismo, è possibile mettere in moto un processo di trascendenza che, pur seguendo tappe diverse, culmina nella piena liberazione dal dolore esistenziale.
La compassione è un altro campo in cui Schopenhauer (Mitleid) e il Buddha (karuṇā) trovano un terremo comune in cui poter dialogare: se per il primo essa deriva dal trapassamento del principium individuationis, per cui si scopre l’identità dell’unica volontà nell’apparente alterità delle sue manifestazioni, le quali per l’appunto condividono egual essenza e destino, il secondo è detto sabbabhūtānukampī, “compassionevole verso ogni essere vivente”, cui bada con la stessa cura che si adotterebbe nei confronti dei propri figli; il Buddha si è prodigato per il bene del mondo (lokahita), senza aver di mira un tornaconto personale. Insomma, il Risvegliato è sabbapāṇabhūtahitānukampī, ovvero, si muove con sollecitudine verso il bene (hita) di tutti gli esseri senzienti. Karuṇā, più in particolare, è volta ad attenuare o, idealmente, a eliminare la sofferenza altrui, che fa tremare e opprime il cuore delle buone persone. Non diversamente, Schopenhauer definisce in questi termini la compassione: “immediata partecipazione, indipendente da ogni altro riguardo, alla sofferenza di un altro e con ciò all’impedimento o annullamento di questo dolore”.
Se, ancora, per Schopenhauer “l’opera della Māyā è indicata come questo mondo visibile in cui noi siamo, un evocato incantesimo, un’apparenza inconsistente, in sé irreale, paragonabile all’illusione ottica e al sogno”, già la tradizione antica del buddhismo invitava a contemplare il mondo in modi che ne suggeriscono l’inconsistenza e la transitorietà, ossia come fosse un grumo di schiuma (pheṇapiṇḍa), una bolla d’acqua (udakapubbuḷa), un miraggio (marīci), un tronco di banano (kadalikkhandha), che è vuoto di dentro, il trucco di un prestigiatore (māyā) e un sogno (supinanta).
Il condizionato, dunque, è una sorta di abbaglio che è necessario riconoscere come tale al fine della liberazione dalla morsa più o meno stringente di quel dolore che, risultante dalla continua frizione con la vera natura della realtà concepita erroneamente in base a rappresentazioni inadeguate che la distorcono, non lascia scampo a chi non eserciti costantemente il discernimento e la consapevolezza: non a caso, il Buddha era caratterizzato da un atteggiamento nei confronti del mondo definito sada sato, ossia “ognora consapevole”, “ognora vigile”.
In conclusione, soffermiamoci su un aspetto così caratteristico del pensiero schopenhaueriano qual è quello del desiderio. Spesso, anche proprio per via di Schopenhauer, la “sete” (taṇhā) di cui parla già la seconda nobile verità buddhista, relativa all’origine della sofferenza (dukkha-samudaya), è stata accostata, se
non proprio identificata, con l’Endloses Streben del filosofo tedesco. Ma mentre questi ne fa un principio metafisico che si estende universalmente e che costituisce l’essenza di tutto ciò che esiste, il Buddha ne ha un’idea più limitata: taṇhā non ha una portata metafisica, e tuttavia è - stavolta non molto dissimilmente da Schopenhauer – inappagabile e causa di dolore in pari misura al grado del suo anelito inesausto.
Già nel celeberrimo e già menzionato Dhammacakkappavattana-sutta, che la tradizione considera il primo discorso pubblico del Buddha dopo il suo risveglio, la brama è qualificata come trovante appagamento qua e là (tatratatrābhinandī), ossia, in quanto anelare irrefrenabile, passa da un oggetto all’altro senza mai acquietarsi. Almeno, finché non intervenga il metodo buddhista, che costituisce nel suo complesso un percorso strutturato per educare la mente - di cui taṇhā è una delle caratteristiche più appariscenti nella sua condizione non disciplinata - e liberarsi in misura via via crescente della sofferenza, fino al suo completo svanimento nella figura dell’arahant.
Beninteso, molti e molto importanti sarebbero ancora i temi attraverso cui interrogare, con metodo comparativo, la tradizione buddhista e la filosofia schopenhaueriana, ma in questa sede è d’uopo rispettare dei limiti di spazio che, tuttavia, hanno permesso, se non altro, di iniziare a mettere a fuoco alcune questioni intorno alle quali si registrano talvolta convergenze, talaltra discordanze, comunque interessanti e degne d’attenzione per il rapporto che Schopenhauer stesso istituiva, a torto o a ragione, tra il proprio pensiero e quello buddhista.
11/10/2025
SULLO STESSO AUTORE
Schopenhauer e il Buddha: abbozzo di un confronto
Il corpo e la sua instabilità come mezzo di liberazione nella prospettiva buddhista pali
Meditazione metafisica sull'Assoluto nel buddhismo antico
SULLO STESSO TEMA
D. Zambon, Il paradosso della felicità
S. Grandone, L'amore: tra essenza ed esistenza
