L'avventura di essere due: cosa succede dopo l'ultima riga delle favole?
Nella nostra società individualista, l’amore come “scena del Due” (Alain Badiou) tende a dissolversi in un gioco referenziale e narcisista, dove l’io non incontra l’altro ma solo simulacri di se stesso. Riscoprire la differenza, il compromesso, il sacrificio dell’essere-con e dell’esser-per l’altro è essenziale per ritornare ad abitare la complessità della relazione, lo scarto dia-logico che solo rende possibile il discorso.

Di amore si vive, di amore si muore, di amore non si può fare a meno. Eppure, quanto è difficile amare! La storia, la letteratura e l'arte sono piene di racconti di amanti, di grandi amori eterni e indimenticabili, ma anche di storie difficili e di tradimenti. Se un tempo ci bastava il "e vissero felici e contenti", oggi siamo curiosi di conoscere ogni sfumatura delle storie d’amore, specialmente di quelle più travagliate. Forse perché, come scrive Alain Badiou in Elogio dell'amore:
« Nell’amore dev’esserci qualcosa di universale per spiegare come mai queste storie interessino un pubblico tanto ampio. E tale universale consiste nel fatto che ogni amore propone una nuova esperienza di verità su ciò che significa essere due e non uno: il mondo può essere incontrato ed esperito in modo differente da come lo esperisce una coscienza solitaria, ecco quello di cui qualunque amore ci offre una nuova dimostrazione » ( ivi, p.28).
L'amore, dunque, ha qualcosa di universale: ogni relazione ci offre una nuova verità su cosa significhi essere due persone e non una. La nostra idea di amore è "figlia del tempo", un mosaico che riflette secoli di pensiero, desiderio e conflitto, unendo il sacro al profano, il razionale al passionale nel tentativo di non essere più soli. Badiou lo descrive così:
« Penso qualcosa di simile, ossia che nell’amore si faccia esperienza del passaggio dalla pura singolarità del caso a un elemento che possiede un valore universale. Muovendo da un punto inaugurale che, preso di per sé, non è nient’altro che un incontro, una cosa da nulla, si impara che è possibile fare esperienza del mondo a partire dalla differenza e non soltanto dall’identità » (ivi, p. 26).
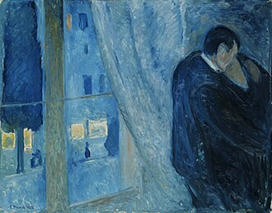
Quel momento inaugurale è immortalato dagli esseri umani e alimenta l'immaginario collettivo, determinando molteplici immagini dell'amore affinché "quello che fu" possa ancora essere. A proposito delle forme che questo sentimento assume, Grandone sostiene:
« Spesso queste si intrecciano e coesistono. A volte, quando amiamo ci sentiamo completi; altre volte amare è consumarsi per l’assenza dell’altro o dell’altra; altre ancora è godere della presenza dell’amato o dell’amata, essere felici di condividere con lui o con lei la propria esistenza; altre, infine, dare gratuitamente senza pretendere nulla in cambio » (S. Grandone, Duelli filosofici, p.194).
Proviamo, allora, a dare un volto a questo sentimento, a dare corpo al nostro immaginario, rintracciando nella storia del pensiero filosofico qualche esempio a cui far riferimento, nel tentativo di tornare a parlare dell'amore.
Abelardo ed Eloisa, un amore difficile
Pasquale Vitale, nel suo saggio Filosofia medievale. Storie, opere e concetti, riprende uno degli amori più tormentati e affascinanti della storia occidentale: quello tra Abelardo ed Eloisa. Un'icona di passione, scandalo e tragedia che ancora oggi non smette di farci sognare è messa in scena attraverso un avvincente storytelling.
Vitale ci fa immergere nei panni di Abelardo, il brillante filosofo e teologo che, superati i trent'anni, si innamora perdutamente della giovanissima Eloisa. Lei non è solo bella, ma dotata di un'intelligenza rara. Con lei Abelardo vive la sua prima e unica passione travolgente. L'autore ci svela che i grandi pensatori non sono statue di marmo, figure astratte e lontane, ma esseri umani in carne e ossa, guidati da sentimenti e desideri che plasmano la loro visione del mondo. L'Abelardo di Vitale ci confessa l'inizio di questa storia d'amore clandestina:
« A questo punto, non mi resta che raccontare la mia travagliata vicenda d’amore con Eloisa... A Parigi viveva una giovane, Eloisa appunto, nipote di un canonico chiamato Fulberto, che l’amava al punto da tentare di farla progredire in ogni disciplina letteraria, tanto che la fanciulla era conosciuta in tutto il regno per la sua cultura. Proprio per questa ragione, mi appariva la più adatta a stringere con me un legame d’amore, data la mia fama non nutrivo dubbi che sarei riuscito nell’impresa e cercai un’occasione per frequentare la sua casa quotidianamente » (Ivi, p.170-171).
La loro relazione, iniziata come un vortice di passione, si trasforma in un legame spirituale e platonico dopo la brutale evirazione di Abelardo, una vendetta che segna per sempre le loro vite. Abelardo stesso descrive la loro travolgente intimità, che finisce per prevalere persino sullo studio:
« In ogni caso, con la scusa delle lezioni ci abbandonavamo all’amore, aprivamo i libri ma proferivamo poi parole d’amore più che di studio, erano più baci che sentenze e le mani andavano più al seno che ai libri... E quanto più la passione si impossessava di me, tanto meno potevo dedicarmi alla filosofia e impegnarmi nella scuola » (Ibidem).

Nonostante le immense avversità, il loro amore resiste per quasi trent'anni, un'epopea raccontata attraverso l'autobiografia di Abelardo, Historia calamitatum mearum, e una fitta corrispondenza che ci svela la profondità del loro legame. Le lettere di Eloisa mostrano un'audacia e una forza emotiva straordinarie per l'epoca, testimoniando un amore che ha saputo superare ogni ostacolo. Le parole e i ricordi leniscono le ferite dei due amanti che non possono più vivere il proprio amore fisicamente. Per questo Eloisa:
« chiede ad Abelardo di scriverle lettere frequentemente, perché chi prova un forte dolore può ricevere consolazione solo da chi partecipa realmente alla sua afflizione. Qualsiasi fardello, infatti, distribuito sulle spalle di più persone diventa sostenibile » (Ivi, p.178).
Vitale, tra le righe del suo manuale, ci restituisce l'essenza di una relazione che ha infiammato i cuori dei posteri, che vedono in Abelardo ed Eloisa un modello a cui ogni storia d’amore dovrebbe tendere. L'amore erotico perde la sua carica in seguito alle disgraziate vicende dei due protagonisti, ma continua ad alimentare le loro esistenze. I due vivono insieme le disgrazie che gli capitano, nella convinzione di poter sopportare meglio certi pesi se condivisi.
Eros in agonia
Cosa resta dell'amore “di un tempo”? Forse solo simulacri, capaci di incantare quei pochi che vi posano lo sguardo, sacrificando il tempo dell’utile per quello dell’anima. Se in passato gli innamorati dovevano lottare contro parenti e avversari per affermare il proprio sentimento, oggi il vero amore si scontra con il nemico più grande della nostra era: l'individualismo. Come sottolinea il filosofo Byung-Chul Han nel suo saggio Eros in agonia, tutto viene valutato in base al suo valore di mercato e le relazioni sono spesso percepite come contratti basati sul tornaconto personale.
L’amore autentico, al contrario, rifiuta le logiche del capitalismo globalizzato. Non è un semplice accordo per una piacevole convivenza, ma l’unica esperienza radicale che ci permette di riconoscere e accettare pienamente l’esistenza dell’Altro. Il dialogo amoroso lascia sempre più spazio alla ricerca di specchi in cui l’essere umano possa riflettere la propria immagine, desiderando il consenso e non il confronto. A tal proposito, Han osserva:
« L’odierno soggetto di prestazione narcisistico è teso soprattutto verso il risultato (Erfolg). I risultati implicano una conferma di un soggetto attraverso l’Altro, così l’Altro, privato della sua alterità, si degrada a specchio del soggetto, che conferma quest’ultimo nel suo ego» (Ivi, p.15).
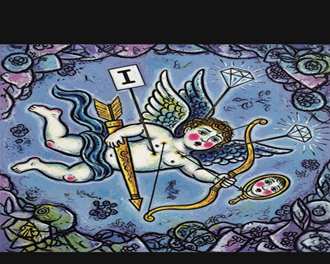
Se l’amore era la forza che animava gli esseri di un tempo e dischiudeva uno spazio nuovo dove incontrare l’Altro, nella nostra società a scandire l’esistenza è l'affermazione del sé. L’Altro diventa un mezzo in questo processo. Presi come siamo dal desiderio di affermarci, la nostra carica erotica è in agonia. Han prosegue la sua analisi con una critica ancora più aspra:
« L’amore si positivizza, oggi, nella sessualità, che è comunque sottomessa al diktat della prestazione. Il sesso è una prestazione. L’erotismo è un capitale che si deve accrescere. Col suo valore di esposizione (Ausstellungswert) il corpo equivale a una merce. L’Altro, che è stato privato della sua alterità, viene sessualizzato come oggetto di eccitazione: non può essere amato, ma solo consumato. Dal momento che viene frammentato nella parzialità dell’oggetto sessuale, l’Altro non è neppure più una persona: non è data una personalità sessuale » (Ivi, p.28).
Cosa resta di quegli amori difficili, delle parole struggenti, della passione più grande indagata, tradita, dipinta, che ha ispirato un tempo l'umanità? Solo frammenti. Cupido è crollato sotto i colpi di un Io sempre più pieno di sé.
« L’amore viene positivizzato, oggi, in una formula per il godimento. Esso deve produrre soprattutto sentimenti piacevoli. Non è più una trama, una narrazione, un dramma, bensì emozione ed eccitazione prive di conseguenze. L’amore è libero dalla negatività dell’offesa, dell’assalto o della caduta. Cadere (innamorati) sarebbe già troppo negativo. Ma proprio questa negatività determina l’amore: L’amore non è una possibilità, non si deve alla nostra iniziativa, è senza fondamento, ci coglie di sorpresa e ci ferisce » (Ivi, p.30).
Il filosofo sudcoreano mette in luce un aspetto cruciale del nostro tempo: il peculiare indebolimento della carica erotica. Eros è tensione, spinge l’essere umano a trascendere il sé per l’Altro, un'antitesi che ci spinge a uscire da noi stessi, spogliandoci della nostra natura per accogliere l’estraneo. Un concetto inconcepibile per un essere che ama soltanto se stesso. Come sottolinea Han, «è nell’amore che il soggetto va oltre se stesso, oltre il narcisismo» (Ibidem).
Amare: un atto di ribellione
Gli amanti sono dei ribelli perché, sacrificando il proprio "io" per l'altro, inaugurano un modo nuovo di vivere il tempo. Hanno il coraggio di annientare il proprio sé per scoprire l’altro. Amare è durare, non vivere di "prime volte", ma sfidare la fugacità per abbracciare la quotidianità. Proviamo per un attimo a non pensare ai gesti eclatanti, alle proposte romantiche, alle dichiarazioni poetiche, a pensare cosa voglia dire davvero amare, al vivere in due mentre si conduce un'esistenza scandita da bollette, faccende di casa, scadenze e difficoltà lavorative. Quando dopo una giornata faticosa, si torna a casa e ci si trova il proprio amato ad attenderci. Scopriamo così in un momento qualsiasi che «Un amore vero è quello che trionfa durevolmente, talvolta duramente, sugli ostacoli posti dallo spazio, dal mondo e dal tempo» (A. Badiou, p. 41).
Nell’amore, ci riconosciamo impotenti, perché l’altro si rivela quando meno ce lo aspettiamo. Non ci sono previsioni, non abbiamo un piano, non ci sono risorse da calcolare. L’amore, quando arriva, divampa nel petto senza preavviso e inaugura un modo diverso di vivere il mondo. Significativa è ancora la riflessione di Alain Badiou:
« Cos’è il mondo quando se ne fa esperienza a partire dal due e non dall’uno? Cos’è il mondo esaminato, esperito e vissuto a partire dalla differenza piuttosto che dall’identità? Sono convinto che l’amore sia esattamente questo: un progetto che include naturalmente il desiderio sessuale e le sue prove, che include la nascita di un bambino, ma egualmente mille altre cose, in realtà qualunque cosa, a condizione che si viva una prova dal punto di vista della differenza » (Ivi, p. 31).
La tradizione occidentale ci ha consegnato due immagini dell'amore: quella romantica e quella tragica. Non c'è via di mezzo, non sappiamo cosa accada il giorno dopo il "e vissero felici e contenti". C'è la fatica di vivere in due, di sopportarsi, parlarsi, ascoltarsi, costruendo giorno dopo giorno un nuovo mondo: quello che nasce dalla differenza.
« L’amore non porta "in alto", né "in basso", ma è un proposito esistenziale: costruire un mondo da un punto di vista decentrato rispetto al mio semplice istinto di sopravvivenza, o al mio interesse » (ivi, p.33).
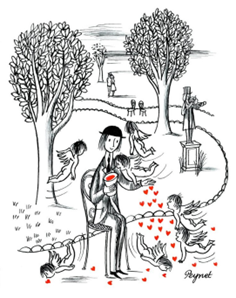
Non abbiamo più un gran bisogno delle favole, ma da soli rischiamo di vivere in agonia. Vale allora la pena provare a cercare qualcuno con cui contemplare «la pace del crepuscolo in un luogo di montagna, il pascolo di un verde dorato, l'ombra degli alberi, le pecore dal muso nero immobili tra i cespugli e il sole che sta per tramontare dietro le rocce» (ivi, p.58). In quel momento, i nostri sguardi convergono verso lo stesso mondo a cui guarda la persona amata. È lì che ci accorgiamo che
« l’amore esiste, e promette di esistere ancora. Io e la persona amata siamo incorporati in quest'unico Soggetto, il Soggetto dell’amore, il quale considera il dispiegarsi del mondo attraverso il prisma della nostra differenza, sicché questo mondo si dà, nasce, invece di essere solo ciò che riempie il mio sguardo. L’amore è sempre la possibilità di assistere alla nascita del mondo » (Ibidem).
Spunto di riflessione
Per chiudere l’articolo propongo al lettore di riflettere su questa sentenza di François de La Rochefoucauld: «Nella gelosia c’è più amor proprio che amore» (Massime morali). Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti!
5 settembre 2025
SULLO STESSO AUTORE
L'amicizia: una sfida esistenziale ed evolutiva
Dalla Tv ai social: la profezia di Popper sulla "cattiva maestra"
Guardare le stelle per orientarsi sulla terra
SULLO STESSO ARGOMENTO
F. Pietrobelli, La logica del tradimento
F. Pietrobelli, L'amore è un'arte?
M. Ciraci, Alla riscoperta dell'amore tramite la poesia di Catullo
