Definire la filosofia. Alcune linee guida
A tutti coloro che si sono avvicinati alla filosofia sarà sicuramente capitato di sentirsi porre domande del tipo «Che cos’è la filosofia?» oppure «Cioè? psicologia?». A tutte queste domande saranno seguite risposte arzigogolate, terminologia specialistica e citazioni d’autore; il tutto per chiudere la conversazione con un «è complicato». Come ha scritto il filosofo francese Paul Ricœur: la filosofia non è vincolata da un solo specifico oggetto di studio e forse è da questo che segue la difficoltà nel definire la disciplina. Tuttavia, se si segue l’excursus della storia delle idee, e lo stato dell’arte della ricerca filosofica contemporanea, c’è un elemento che permette di definire la filosofia in generale. Nel seguente articolo, tenteremo di fare chiarezza su questo punto.
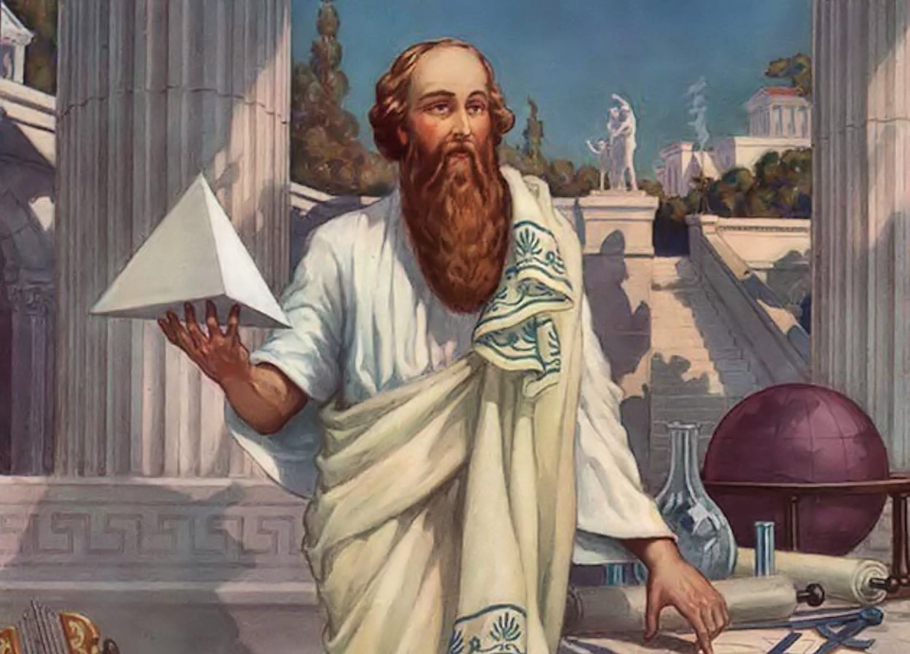
Per prima cosa, tagliamo la testa al toro: che cos’è la filosofia? La filosofia è quella disciplina che cerca di rispondere alle domande a cui non è ancora possibile, o a cui non è proprio possibile, rispondere attraverso il metodo scientifico. Facciamo due esempi: "Esiste il bosone di Higgs?" a questa domanda si può rispondere per via sperimentale, di conseguenza, essa sarà di competenza della fisica. Se invece chiediamo: "Esistono i numeri o sono convenzioni linguistiche?" a questa domanda è più difficile pensare una risposta attraverso il metodo scientifico, perché i numeri non sono entità fisiche. Perciò, questa domanda sarà di competenza della metafisica. Un filosofo puntiglioso potrebbe obiettare che anche l’esistenza del bosone di Higgs può risultare filosoficamente problematica, in quanto, bisognerebbe definire che cosa significhi “esistenza” e valutare se il bosone rientri nell’insieme delle cose che esistono. Questo è certamente vero, tuttavia, ad un livello scientifico e linguistico ordinario, possiamo affermare con una certa sicurezza che il 4 luglio del 2012 al CERN sia stato scoperto un x definibile come “bosone di Higgs” e che quindi vada annoverata tra le cose che esistono. Se prima era solo un’idea, quindi mentale, da quel giorno si è scoperto essere qualcosa di extramentale e dunque esistente.
Un buon backup di ciò che la filosofia è, lo si trova in un libro del filosofo inglese Timothy Williamson:
« Tradizionalmente, i filosofi hanno voluto capire la natura di tutto, in modo molto generale: l’esistenza e la non esistenza, la possibilità e la necessità; il mondo del senso comune, il mondo della scienza naturale, il mondo della matematica; parti e interi, spazio e tempo, causa ed effetto, mente e materia. Essi vogliono capire la comprensione stessa: conoscenza e ignoranza, credenza e dubbio, apparenza e realtà, verità e falsità, pensiero e linguaggio, ragione ed emozione. Vogliono capire e giudicare con questa comprensione: azione e intenzione, mezzi e fini, buono e cattivo, giusto e sbagliato, fatto e valore, piacere e dolore, bellezza e bruttezza, vita e morte e altro ancora. La filosofia è iperambiziosa. » (T. Williamson, Fare filosofia. Dalla semplice curiosità al ragionamento logico).
La filosofia, dunque, s’interroga su quei problemi (o metaproblemi) a cui per il momento non è possibile rispondere attraverso gli strumenti della scienza o a cui non sarà mai possibile rispondere per via scientifica. Ciò non rende la filosofia né superiore, né inferiore alle discipline scientifiche, ma la rende un’attività squisitamente umana che cerca di dare qualche risposta a quelle domande che possono sorgere nel corso della vita e a cui non abbiamo ancora risposte certe o a cui non ne avremo mai.
Una volta definita la filosofia, bisogna chiedersi quale sia il suo rapporto con la scienza. Entrambe hanno, l’obbiettivo di fare chiarezza nelle oscurità del mondo. Bisogna allora capire come queste due forme di sapere si relazionino. Guardando alla storia della filosofia e alla storia della scienza, possiamo dire che il rapporto tra le due sia genitoriale: la filosofia è madre della scienza. Ciò non significa che la filosofia sia più adulta della scienza, ma che sia l’incubatore all’interno del quale la scienza moderna storicamente è nata. I primi filosofi della storia cercavano di rispondere alla domanda sull’origine dell’universo e vi diedero diverse risposte. Si vedano i filosofi presocratici di Mileto: Talete, Anassimene e Anassimandro. Ma si vedano anche altri nomi ben noti come Pitagora. Quando fu possibile indagare l’universo da un punto di vista empirico, e non più da un punto di vista speculativo e teorico, quest’indagine diventò scienza.
La fisica è stata, dall’antichità fino alla modernità, una parte della filosofia e il suo nome era filosofia della natura o, seguendo la nomenclatura di Aristotele, filosofia seconda. Essa si occupava di rispondere a quesiti elementari come la natura dei corpi materiali e della natura in generale, la ragione della caduta dei gravi, il moto degli astri e così via, l’origine del cosmo o la natura della materia. Tutto questo era saldo dominio della filosofia e lo rimase per lungo tempo. Come avvenne la separazione? Il primo testo scientifico in senso moderno può essere individuato nel De revolutionibus orbium coelestium del polacco Niccolò Copernico, che pose le basi per la rivoluzione scientifica del nostro connazionale Galileo Galilei.

Galilei fu fondamentale perché pronunciò quella frase che avrebbe permesso di separare la fisica del grembo della filosofia. Ne Il Saggiatore, Galilei scrive che la natura è come un libro che Dio ha scritto con il linguaggio della matematica. A partire da ciò, si è potuto iniziare a descrivere la natura in termini matematici e a trattarla con rigore, facendo osservazioni sulla natura e ipotesi sul suo funzionamento, per poi provarle mediante esperimenti, calcolarne la meccanica e formulare leggi. Così la filosofia della natura smise di essere una disciplina speculativa per avviarsi verso quella cosa che oggi chiamiamo “fisica”.
L’opera più nota di Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi, si propone come una sorta di dialogo filosofico, simile a quelli che Platone scrisse. Tuttavia, il contenuto dell’opera è totalmente diverso rispetto ai dialoghi filosofici: le argomentazioni adottate per confutare il geocentrismo non sono speculazioni, ma esperimenti (anche se a volte solo mentali). Attraverso di essi, si mostra come le argomentazioni della fisica aristotelica non stessero in piedi alla prova sperimentale. Siamo davanti ad uno stile di scrittura filosofico, ma ciò che si vede è una scienza totalmente trasformata. Lo stesso dicasi per l’opera più famosa di Isac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, il titolo rimanda alla filosofia naturale che si fonda su principi matematici, un approccio totalmente nuovo al discorso sulla conoscenza della natura.
Quelli descritti sopra sono solo i rudimenti semplificati di quel processo lungo e complesso che va sotto il nome di “rivoluzione scientifica” e che renderà la fisica autonoma dalla filosofia, trasformandola nella scienza che oggi conosciamo. Un processo lungo e articolato, ma che ben aiuta a capire quale sia il rapporto tra la filosofia e la scienza, un rapporto di tipo genitoriale.
Quali sono alle tematiche di cui oggi si occupa la filosofia? La filosofia ha diverse branche, si occupa di cose molto diverse tra di loro. Una delle parti più iconiche della filosofia, quella di cui chi scrive si occupa, è la metafisica. La metafisica, nota anche come ontologia, è lo studio degli enti in quanto tali. Come scrive il filosofo inglese Michael Dummett: «la metafisica riguarda la natura generale della realtà» (M. Dummett, Verità e passato). Ci sono diversi modi con cui gli enti in quanto tali possono essere studiati, un esempio, molto diffuso nel mondo anglosassone, è la mereologia: lo studio del rapporto tra le parti e il tutto. Un tavolo o un corpo umano sono riducibili alle loro parti o sono qualcosa di più? In base a come si risponde a questa domanda, si avrà un approccio riduzionista, il tutto è identico alle parti, o anti-riduzionista (emergentista), il tutto è qualcosa di più delle sue parti. Ciò conduce a temi importanti della metafisica come la natura dell’identità di un oggetto o di un individuo, la sua continuità nel tempo, il rapporto necessità/possibilità dei suoi predicati e così via. Tutto ciò conduce poi ad un'altra questione molto vivace nella metafisica ossia, la natura della mente: esiste la mente? Che cos’è la coscienza? Qual è il rapporto tra la mente e il cervello?
La filosofia della mente si rapporta molto alle neuroscienze e, secondo molti specialisti, è una disciplina che presto verrà assorbita dalle stesse. Quello della filosofia della mente è proprio uno di quei casi in cui vi sono delle domande a cui le scienze non riescono ancora a rispondere e perciò c’è maggiore spazio per la speculazione filosofica. Ciò non elimina il dialogo con la scienza, tant’è che vi è un particolare tipo di filosofia della mente, detto neurofilosofia, che viene talvolta inserita nel novero delle neuroscienze, come fa ad esempio il biologo americano Ed Wilson nel suo libro L’armonia meravigliosa. Anche nel caso della filosofia della mente, ci sono diverse posizioni che vanno dal riduzionismo all’anti-riduzionismo. Ci sono filosofi e neuroscienziati che ritengono la mente riducibile al cervello (ad esempio Daniel Dennett) e altri che ritengono che la mente, e la coscienza in particolare, l’esperienza soggettiva specie-specifica, sia irriducibile al cervello (un esempio è Thomas Nagel). Vi sono poi forme più estreme di riduzionismo, l’eliminativismo, secondo cui, la mente in astratto non esiste, esiste solo il cervello: se dovessimo immaginare di palpare il nostro cervello staremo letteralmente toccando i nostri stati mentali. Vi è poi l’anti-riduzionismo estremo, o dualismo cartesiano, secondo cui la mente è totalmente altro rispetto al corpo e al massimo interagisce con esso in un modo che ancora non conosciamo. Eliminativismo e dualismo sono posizioni minoritarie, mentre l’emergentismo e il riduzionismo vanno per la maggiore. Le neuroscienze sono un campo dove filosofia e scienza s’incontrano e s’invischiano, alcune volte tanto da risultare quasi indistinguibili.

La metafisica cerca inoltre di spiegare perché sia possibile dire che tutte le cose nel mondo “sono qualcosa” pur nelle loro diversità. Che cosa origina tutti gli enti? Che cosa li fonda? Che cos’è quell’essere che tutti gli enti hanno? La metafisica si spinge allora oltre i confini del mondo fisico, cercando di capire se vi sia o meno un mondo non percettibile dai sensi da cui il mondo fisico tragga la sua esistenza e il suo senso d’esistere. In una domanda: perché c’è in generale qualcosa e non piuttosto il nulla? Il filosofo italiano Luigi Pareyson commenta una tale ambizione con le seguenti parole: «(La filosofia) è coscienza non di ciò ch’è ultimo, ma di ciò che è primo, non d’una storia conclusa, ma d’un’origine inesausta, non della presunta totalità dello spirito umano, ma della sua infinita virtualità originaria» (L. Pareyson, Iniziativa e libertà).
Tematiche tradizionali e, vivacemente discusse, tra i metafisici sono l’esistenza di Dio e dell’anima (teologia e teologia filosofica), o l’eventuale senso dell’esistenza. In questo caso, un contributo fondamentale è dato dall’ermeneutica (filosofia dell’interpretazione), che cerca grandi verità esistenziali a partire dalla poetica, dai simboli, dai miti, dalle metafore o dai testi delle tradizioni religiosi viste come rivelatrici di un senso e di una qualche verità. Come scrive sempre Pareyson: «il simbolo è in grado dunque di salvaguardare l’abissale inesauribilità e preservare la radicale indicibilità della trascendenza. Solo attraverso il mito si giunge al cuore della realtà, e solo attraverso il simbolo se ne può dare una qualche rappresentazione e figura» (L. Pareyson, Ontologia della libertà).
La metafisica, in ultima istanza, cerca di capire che cosa sia la realtà, le cose che esistono, la loro struttura e l’eventuale senso ultimo di tutto questo mondo in cui viviamo: chi siamo? (ente in quanto tale) da dove veniamo? (il principio) e dove andiamo? (il senso ultimo).
Altre cose di cui si occupa la filosofia è capire che cosa sia la verità e che cosa la conoscenza. Proprio per questo, molto spesso alla domanda: «a che cosa serve la filosofia?», si risponde: «Serve a imparare a pensare». Si dice così, perché la filosofia cerca di definire i criteri attraverso i quali sia possibile ottenere una qualche conoscenza, scientifica o meno che sia e cerca d’identificare come si svolge un ragionamento corretto e le fallacie logiche nelle quali si può incappare, questo è il compito delle così dette logiche filosofiche, che si occupano del rapporto tra verità e validità logica.
L’affermazione per cui la filosofia insegna a pensare significa che attraverso di essa si possono imparare a distinguere le opinioni dalle idee fondate e argomentate. Questo è un compito tradizionale della filosofia, si pensi a Socrate che insegnava a distinguere le opinioni e la retorica, dalla vera conoscenza che aveva bisogno dell’argomentazione e della dialettica. Non solo attraverso la filosofia si può acquisire questa capacità, ma si può dire che questo sia stato uno dei tratti che ha contraddistinto la filosofia fin dalle sue origini: distinguere la verità dal senso e dalla opinioni comuni.
Le discipline filosofiche che si occupano della natura della conoscenza e della distinzione tra vere conoscenze, opinioni e menzogne è la gnoseologia (teoria della conoscenza), la quale frequentemente si accompagna all’epistemologia (filosofia della scienza), che si occupa di capire quale sia il metodo scientifico, come distinguere una proposizione scientifica da una pseudoscientifica e così via. Alcuni importanti epistemologi e gnoseologi nella storia del pensiero sono stati: Immanuel Kant, Karl Popper, Thomas Khun, Paul Feyerabend.
L’epistemologia e la gnoseologia sono discipline di grande importanza, molto utili a capire come funzioni la conoscenza e per addentrarsi nel meccanismo dell’affascinante mondo delle scienze dure. Queste discipline ci permettono di capire la struttura e i mezzi che permettono all’essere umano di conoscere la realtà che lo circonda.
La filosofia, come visto nei paragrafi precedenti, ha un’anima prettamente teorica, ma come emerge dalla citazione di Williamson vista all’inizio, essa ha anche un’anima pratica, interessata alle società ai rapporti interpersonali, alle norme consociali e alla vita rettamente condotta. L’etica è uno dei campi più importanti, oltre che più vicini alla nostra vita concreta, che possano esistere. Esistono diversi tipi di etiche, alcune che cercano di capire come distinguere il giusto dallo sbagliato, il bene dal male: questi approcci all’etica vengono indicati generalmente con il nome di filosofia morale.
Altre sottobranche dell’etica sono le etiche applicate e la bioetica, che si occupano di temi come la responsabilità, le azioni collettive, le questioni inerenti temi come l’aborto e il fine vita e molto altro ancora. Anche in questi casi, il dialogo tra la filosofia e le scienze è serrato. Si pensi, per fare un esempio, ai comitati etici dove filosofi e scienziati sono seduti ad uno stesso tavolo per discutere e ragionare su quale sia la scelta giusta da prendere per una legge o altro. Vi è poi lo studio del linguaggio e della sua eticità, dei suoi usi e delle sue funzioni, qui troviamo la pragmatica del linguaggio introdotta nel secolo scorso da autori come John L. Austin e Paul Grice.
La filosofia pratica s’interessa poi a quale sia il giusto modo per governare i gruppi umani e qui abbiamo l’ambito della filosofia politica, oppure sulla natura delle leggi e degli ordinamenti giuridici dov’è il campo della filosofia del diritto.
Un’altra importante branca della filosofia è l’estetica che si occupa di comprendere la sensibilità umana, la nozione del bello e la comprensione del fenomeno artistico.

In ultima analisi, capire che cosa sia la filosofia non è affatto complicato, non è difficile capire le sue tematiche e i suoi molteplici oggetti di studio. Ciò che può risultare ostico nella filosofia, proprio per il suo occuparsi di tematiche di cui non abbiamo risposte scientifiche e in alcuni casi forse mai avremo, è la vastità di posizioni e di approcci, di linguaggi utilizzati, di stili argomentativi e molto altro. Certo la filosofia avrà delle sue complessità, come del resto ce le ha qualsiasi altra disciplina, ma questo certo non renderà impossibile o esclusivo il suo studio. Esiste sempre un maggiore sforzo divulgativo e un sempre più ampio lavoro sul linguaggio per rendere la disciplina più fruibile. Certamente, alcuni filosofi hanno ancora uno stile di scrittura molto barocco ed ermetico, ma questi sono sempre più minoritari. Con il giusto approccio, la filosofia è una disciplina a cui tutti possono approcciarsi e, grazie alla sua vastità di tematiche, tutti possono trovare qualcosa capace di catturare il loro interesse e la loro attenzione.
Il quadro tracciato in questo contributo è estremamente ridotto e approssimativo, ma può essere comunque un ausilio per far apparire una disciplina così tanto temuta, più amichevole e familiare di quanto si creda.
14 agosto 2025
