Sull'indeterminatezza dell'angoscia
L'angoscia sembra fatta di carta velina: osservarla con l'intento di definirla porterebbe lo sguardo a posarsi su ciò che è al di là di essa, oltre la sua (im)materialità. Essa sembra poter reggere il paragone con qualcos'altro diverso da sé, può essere ripartita in versi e percepita senza, però, consegnarsi alla formula data una volta per tutte ed è ciò che tale breve analisi vuole mettere in luce a partire dal concetto freudiano di ''perturbante'' per giungere a quello heideggeriano di ''angoscia''.
di Giusy Bracco

Sentirsi travolti da uno stato d’animo inqualificabile, fuori dagli schemi della psicologia, ma non per questo poco potente. Il sentirsi spaesati, immersi nel perturbante [Unheimliche] perché qualcosa – ma forse non c’è neppure un qualcosa – ci è amico e ci è estraneo allo stesso tempo, come Freud definisce tale sensazione di estraneità angosciante. Perturbante come la storia dell'Uomo di sabbia di Hoffman terminata con la pazzia, con la sclerotizzazione di una mente annebbiata dal significato notturno che si insinua, a gocce, nelle viscere. L'uomo della sabbia – ritrovato nell'inquietante avvocato Coppelius e poi nell'italiano Coppola – perseguita il protagonista del racconto, Nathael, esordendo durante la sua infanzia tanto da provocargli uno stato d’inquietudine mai provato prima; tutto si può far risalire ad una fantasiosa e ‘’innocente’’ (ma pure terribile) minaccia da parte della madre. Se non fossero andati a letto presto, Nathael e i suoi fratelli sarebbero stati sottoposti ad un'atrocità ammessa soltanto in una comunità fatta di sogni e di retaggi primitivi: il signore della sabbia avrebbe loro cavato gli occhi per poi darli in pasto ai suoi figli muniti di un becco puntuto.
Tale immagine e quell'uomo misterioso assumeranno con gli anni forme diverse che, molto probabilmente, si esauriscono soltanto nell'immaginazione nevrotica del protagonista che vede lacci dove non esistono occhielli, connessioni generate dal senso di repulsione che quella minaccia puerile, da parte della madre, gli aveva provocato. Tutto appare, in questo racconto, amico ed estraneo: un tuffo nel passato dal quale è difficile uscire perché la piscina nella quale ci si è fiondati sembra allargarsi sempre di più, assumendo le dimensioni dell’oceano. I ricordi sembrano essere ovunque, riaffiorano nel presente acquisendo carne e dove c’è carne c’è anche dolore.
Lo stato d’animo descritto da Freud nel ‘’Il perturbante’’ non è riconducibile direttamente all’angoscia a causa delle loro innumerevoli differenze, ma gli si avvicina per il fatto che sono ambedue sfumati, irrimediabilmente privi di contorni e, per questo, difficili da descrivere. Il perturbante riguarderebbe un altro strato sotterraneo, diverso da quello dell’angoscia, ossia l’inconscio. Ciò che ci tormenta, quando siamo attraversati dalla sensazione del perturbante, non è semplicemente qualcosa di nuovo o di estraneo, ma piuttosto qualcosa di conosciuto (durante l’infanzia) e in un secondo momento rimosso e che riemerge sottoforma di uno stato d’inquietudine ed estraneità che è, allo stesso tempo, familiare. Allora, il perturbante è stato richiamato in questo breve contributo per via della sua consistenza gassosa, cioè sfuggente, che lo accomunerebbe all’angoscia, caratterizzata dalla stessa difficoltà di trattazione. E in più, lo stesso Freud nel descrivere tale stato, parla di un moto angoscioso, una sorta di tremito interiore, ciò che «ingenera angoscia e orrore» [zum Schreckhaften, zum Angst- und Grauenerregenden gehört].
È tra le righe di una poesia che è, forse, possibile percepire il suono autentico dell’angoscia, sentirne il peso e l'ampiezza perchè la poesia non pretende di afferrare alcunché, ma dona il linguaggio dove esso non c'è. ‘’La sera del dì di festa’’ di Leopardi dice l’indicibile portandolo allo scoperto. Eppure svelare l’indicibile – si pensi all’Essere heideggeriano – significa parlare di qualcos’altro, cercare un volto a qualcosa che non ne ha uno, facendo emergere così solo una parvenza di occhi e di una bocca, ossia una maschera aggiunta a posteriori e che poco ha a che fare con il ‘’volto’’ reale dell’indicibile. Leopardi, però, dice e non dice l’angoscia, la nomina non nominandola, rispettando il suo essere diafano e impenetrabile:
« […] E fieramente mi si stringe il core,
A pensar come tutto al mondo passa,
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
Il dì festivo, ed al festivo il giorno
Volgar succede, e se ne porta il tempo
Ogni umano accidente. Or dov’è il suono
Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
De’ nostri avi famosi, e il grande impero
Di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
Che n’andò per la terra e l’oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona. »
Il moto angoscioso di un’anima investita dalla sua medesima finitezza: dove è finita la gloria dei popoli antichi, primi fra tutti i Greci che, nelle nostre menti, hanno lasciato la buccia dell’ammirazione? Dove, poi, andremo a finire noi tutti? L’angoscia si insinua nelle orecchie come un canto ancestrale proveniente da una radura abbandonata, nei tessuti come un ago in una stoffa di fronte all’istantanea percezione del nulla.

Dunque, appare difficile descrivere e incasellare una volta per tutte l’angoscia per via della sua natura sfuggente, tanto da poterla definire ''ritraente''. Essa si ritrae quando gli occhi si posano sugli oculari del microscopio i cui obiettivi sono posizionati vanamente nella sua direzione. Un’analisi sola pare rispettare l’indeterminatezza dell’angoscia, evitando un approccio psicologistico nel quale la si affronta come uno «stato di sofferenza psichica» e, poi, una miscela di «stati mentali di ansia, paura e depressione» come riporta un articolo dedicato all’angoscia come problema del sito web dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO); essa, invece, si radicherà su un altro terreno: quello ontologico-esistenziale.
Affrontare l’angoscia in chiave ontologica, come fa Martin Heidegger, significa inoltrarsi nel nucleo di tale «tonalità emotiva» [Stimmung] evitando di darle delle connotazioni di matrice psicologica, ossia contingente, al fine di concepirla come una modalità grazie alla quale l’Esserci è in rapporto con l’Essere. Infatti, in ''Essere e Tempo'' il filosofo tedesco si dedica all’analisi fenomenologica (che è necessariamente anche ontologica) dell’Esserci prima di giungere al problema dell’Essere dal momento che il Dasein sarebbe l’unico a comprendere l’Essere, godendo, così, di un primato ontico e ontologico. L’Esserci possiede un primato ontico perché è l’ente al cui essere appartiene la comprensione quotidiana dell’Essere; ed un primato ontologico perché solo per suo tramite si potrà comprendere il «senso dell’essere in generale» da cui dipendono tutte le ontologie particolari [Essere e tempo, M. Heidegger].
Nella Sezione Prima, Capitolo VI, intitolato "La cura come essere dell’esserci" e, in particolare, nel paragrafo 40, Heidegger parla appunto dell’angoscia come modalità d’essere dell’Esserci diversa ma, in qualche modo, affine alla paura:
« Ma l’affinità tra i due fenomeni è evidente. Ne è indice il fatto che i due fenomeni restano per lo più indistinti e si chiama angoscia ciò che è paura e paura ciò che ha il carattere dell’angoscia. »
Paura e angoscia per la loro affinità evidente vengono, in genere, scambiate l’una con l’altra, tanto che non le si riesce più a distinguere come nella definizione data dall’IPSICO. La paura è una fuga davanti a qualcosa di determinato che reca con sé il carattere della minaccia, riconducile, dunque, agli enti intramondani. Ma il «davanti-a-che» dell’angoscia non è un ente intramondano, è «l’essere-nel-mondo come tale». Ossia, ciò che determina l’angoscia, standogli dinanzi, non è un ente determinato (un lupo o l’immagine sempre incombente dell’Uomo della sabbia), ma è l’indeterminatezza stessa. Perciò l’angoscia «non vede neppure un determinato ''qui'' e ''là'' a partire dal quale la minaccia si avvicini», ciò che la caratterizza è il minaccioso che è in «nessun luogo». Quando l’angoscia è passata e ci si sente sollevati – prosegue Heidegger – si usa dire nella vita di tutti i giorni che ''non era niente'' perché non è possibile cogliere onticamente (come se fosse un ente fra gli altri) l’angoscia e la quotidianità del linguaggio sa dire soltanto dell’ente. L’angoscia può essere provata da un commesso di un negozio di articoli sportivi, ma non la saprà dire, non potrà afferrarla come solitamente fa con le scatole di scarpe ginniche quando, a fine giornata, spolvera sugli scaffali opachi.
L’angoscia è un modo fondamentale dell’essere-nel-mondo e rende palese nell’esserci l’essere-al più proprio poter essere, «cioè l’esser libero per la libertà di scegliere-e cogliere-se-stesso». Ciò a cui l’angoscia porta davanti l’esserci sarebbe «il suo essere libero per… l’autenticità del suo essere come possibilità, quella possibilità che esso già sempre è». È la stessa possibilità di scegliere – la sua libertà – a far emergere l’angoscia, a far sì che essa si mostri in tutta la sua indeterminatezza.
Gennaro Imbriano in un articolo intitolato: «PAURA» E «ANGOSCIA» NEL PENSIERO DI MARTIN HEIDEGGER DALL’ANALITICA ESISTENZIALE AL PENSIERO DELLA «SVOLTA» scrive:
« Il nulla come si vede non è per Heidegger un vuoto ontico, ma unicamente un vuoto di significatività, che emerge quando l’esserci si relaziona al mondo nella situazione emotiva dell’angoscia, che lascia apparire la totalità del mondo, e dunque l’essere nel-mondo come tale, come privo di senso. Come la paura, anche l’angoscia ha un «per-che». A questo punto è facile intuire che anche «il per-che dell’angoscia è l’essere-nel-mondo come tale», in quanto esso non può essere «un determinato modo di essere o una possibilità dell’esserci. »
Il per-che dell’angoscia è il nudo essere-nel-mondo ovvero quel fenomeno cooriginario secondo il quale non può darsi mai l’Esserci senza mondo e neppure, al contrario, un mondo senza l’Esserci. Il significato quotidiano si ritrae, il senso si nasconde a tal punto che l’essere umano (adesso discostandomi dal lessico heideggeriano) viene assalito da un misterioso senso d’angoscia proprio come se avesse sfiorato qualcosa su cui il linguaggio e, dunque, la comprensione non attecchisce. Un senso di smarrimento che tormenta e inibisce il produrre del giorno, spesso concepito come un intralcio, il quale è meglio ignorare e coprire al più presto con le parole vuote e coi gesti meccanici del lavoro.
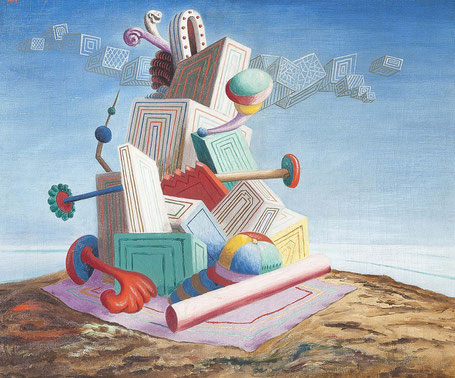
Salvatore Natoli nel suo libro ''L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale'' dedica diversi approfondimenti all’angoscia heideggeriana, facendo emergere tutto il fascino di questa analisi. L’universalità del dolore – scrive Natoli – si radica nell’esposizione al nulla che è, appunto, l’angoscia. «Sotto certi aspetti, il semplice fatto di essere esposti rende precari» e, dunque, partecipi di «quella forma indefinita di tormento che va sotto il nome di angoscia». E citando un passo dell’''Inibizione, sintomo, angoscia'' di Freud, egli scrive che, a ben guardare, tale tormento sembra essere legato all’attesa perché è «angoscia prima di e dinanzi a qualcosa», ma in modo tale che il dinanzi a qualcosa si riveli essere un alcunché di indeterminato. L’angoscia, in sintesi, è dall’autore rintracciata nell’universalità del dolore perché essa non è una semplice esperienza soggettiva, ma un’esperienza esistenziale profonda in grado di mettere in discussione gli intrecci di senso della vita.
Essa genera «spaesamento» proprio come l’Unheimliche di Freud, ma sia le loro ragioni che i piani d’analisi sono differenti. L’angoscia [Angst] heideggeriana riguarda il piano ontologico, il fondamento dell’Esserci e si palesa difronte alla presa di coscienza delle nostre possibilità, la nostra pure finita libertà. Al sottrarsi del senso culturale, ossia lo strato storico-valoriale, emerge un senso d’angoscia, uno strappo interno che chiede del senso, che vuole giungere alla radice. Mentre il perturbante freudiano riguarda perlopiù l’inconscio, un congelamento di figure destabilizzanti negli angoli reconditi della mente.
«[…] Stanca di vivere, paurosa della morte, simile/ al vascello perduto, prigioniero del flusso e del riflusso,/ salpa l’anima mia per orrendi naufragi.» recitano questi tre versi de L’angoscia di Verlaine, i quali parlano della vita che si estende per poi ritrarsi nel niente, l’assenza di significato, la perdita del senso. Il niente che per Heidegger diventa il «ni-ente», ossia l’esserci che scade inautenticamente nelle cose, perdendosi negli enti in un riflusso che lo porta ad atteggiarsi come se fosse un ente fra gli enti. Il niente che stimola l’angoscia, quell’urlo senza voce alcuna e che chiede dell’Essere, del significato del tutto, di quell’albero ricoperto dalla schiumosa muffa d’autunno e di noi, io e te che camminiamo adesso sul ciglio della strada.
24 maggio 2025
