Il problema antropologico e la democrazia
Per cambiare il mondo è sufficiente modificare le procedure? Una riflessione che prende le mosse dall'opera di un filosofo canadese, studioso del "modello Cina".

La nostra democrazia funziona? Esistono delle alternative politiche? Un testo di qualche anno fa, scritto dal filosofo canadese Daniel A. Bell, si pone l’obiettivo di accendere un dibattito pubblico e accademico proprio su quei temi. La “religiosità” che segna le democrazie occidentali non permette loro di dubitare della propria correttezza, delle proprie procedure, del proprio successo. Ciò che l’Occidente si limita a compiere è un’operazione di sostituzione dei suoi membri istituzionali, senza però mai venire a capo dei suoi insuccessi. Le ragioni della debâcle individuate dallo studioso sono molteplici: il lobbying dei più ricchi a discapito dei più poveri, la demagogia politica spinta dalle elezioni stesse e dal mandato breve che impedisce una reale progettualità, la cattiva formazione della classe politica che si lega alla tremenda incapacità politica delle masse votanti; interpellate – queste ultime –, nonostante la loro sfiducia, a scegliere proposte alle volte solo apparentemente contrapposte, relative a questioni assai complesse o addirittura “specialistiche”.
Bell non è un professore accreditato soltanto presso le università occidentali, bensì addirittura si tratta «forse [del] filosofo occidentale più ascoltato in Cina» (dalla prefazione all’edizione italiana), Paese in cui lavora e studia da diversi anni. Lì ha modo di indagare quotidianamente un modello per certi versi differente, di cui ambisce a illuminare pregi e difetti. Non è indispensabile riportare tutte le argomentazioni che avanza e i dati che copiosi penetrano come frecce nella corazza ideologica del lettore, abituato a dare per scontato il "pacchetto" di nozioni politiche consegnatogli dalla regione culturale cui appartiene; è sufficiente annotare qui come egli ritrovi in entrambi i sistemi analizzati dei punti di forza, capaci di compensare le vicendevoli mancanze. Il modello cinese è definito meritocratico. Lo è perché il politico, prima di divenire guida, è costretto a un duro tirocinio e itinerario di studio, che lo affaccia a continue e ardue prove. Solo una lunga selezione definisce il migliore, secondo l'obiettivo stabilito. In questo senso, i risultati della lotta alla povertà sono strabilianti, e si sono ottenuti proprio in virtù della ricerca instancabile di leader meritevoli. Sa bene (e racconta) come il processo si inceppi, come da noi, fra le maglie della corruzione e dell'autoritarismo. Tuttavia, i politici più noti sono anche i più preparati, di contro a ciò che accade da noi, quando la libera scelta elettorale dell'esecutivo, che permette a noi occidentali di scegliere l'indirizzo politico, il più delle volte consegna leader non altrettanto preparati rispetto ai cinesi, e, per i limiti del sistema, nemmeno architetti di progetti di lungo respiro. Allora Bell si domanda: perché diamo per scontato che le nostre procedure siano toto caelo le più valide? Alcune delle proposte meritocratiche possono essere integrate nel nostro mondo, e viceversa. Secondo il canadese questo dibattito imprescindibile, con cui dovremo fare i conti, avrà luce in futuro.
Ma avviciniamoci al punto della riflessione che vogliamo portare in questa sede. Egli racconta del complesso sistema di esami e selezioni che intercorrono durante la carriera politica di un progetto meritocratico, che, nel caso cinese, affonda le proprie radici (più o meno consapevoli) nella tradizione imperiale. Una storia assai interessante, ignorata dagli occidentali perché “in Cina e Giappone, in fondo, per millenni non è successo niente”. Dopo essersi occupato del modello occidentale e partendo dal presupposto (faticosamente conquistato) che la meritocrazia dopotutto non sia un’idea da rigettare in toto, egli si domanda: come far fronte alle sue mancanze, come correggerne le storture?
Per combattere la corruzione pubblica si potrebbero alzare i salari (e questo rimedio, si badi, è anche italiano), impedire alcuni negoziati fra privato e pubblico, e soprattutto favorire il recupero della tradizione confuciana, di modo che, per i funzionari, «non essere corrotti [diventi] una questione d’onore» (D.A. Bell, Il modello Cina, p. 160). Ecco il nodo della questione, a nostro avviso. Senz'altro è possibile ritrovare una combinazione fra aspetti di un modello e dell’altro, e forse alcune sembrano persino papabili, da provare per sperimentare dei miglioramenti. Potremmo fare dei passi avanti in relazione alla “partecipazione”, termine abusato ma attualmente non granché operativo nel nostro mondo. Si può immaginare una partecipazione popolare attiva a livello cittadino di contro a una meritocrazia – che attingerebbe da quel bacino – in “alto”, di modo da ovviare sia i difetti dell’elettoralismo sia della meritocrazia creando partecipazione. Se il leader nascesse nel contesto cittadino partecipativo, e fosse costretto a una dura preparazione, allora avremmo cittadini più consapevoli e leader più preparati. Il guaio è che, come si dice, fatta la regola trovato l’inganno, per cui esistono infinite strade per riuscire a mancare il bersaglio nonostante le regole preventive. Tutto ciò ricorda la ragione per cui le femministe, un bel giorno, decisero di imporsi delle assemblee separate; le stesse motivazioni che, di pratica in pratica, spingono a generare ulteriori limitazioni per far fronte alle vie traverse che il “male” scova per farsi avanti. Le femministe in riunione si separarono dagli uomini perché si sono accorte che, nonostante le simpatie dei colleghi maschi verso le rivendicazioni femminili, accadeva che gli uomini tendessero, al di là dei propositi, a monopolizzare le assemblee dedicate alle donne. Se con le parole supportavano, con i fatti rischiavano di essere asfissianti. E non solo: le donne erano, in politica, le donne di quel o quell'altro militante.
Se la strada che percorriamo rimane quella già intrapresa, l’unica possibilità in vista è quella di continuare a mettere delle toppe a un tessuto consunto che inesorabilmente si sfalda. Dove, beninteso, le toppe sono le regole di “contenimento” dell’errore. Più multe, più sanzioni, più controlli, più codici, più sottigliezze, più burocrazia. Se anche all’interno della partecipazione massima, l’assemblea, è possibile fare violenza, allora non c'è via di scampo. È noto che le prime invettive contro la democrazia (e si parla di democrazia diretta) vennero alla luce contro il modello democratico ateniese. Sì, perché sebbene a livello cittadino vi fosse un progetto similare a quello che stimavamo come migliore, rimane vero che già lì si innesta la più terribile demagogia, la più bieca sopraffazione, la più tragica incompetenza. Leggiamo i greci: ce ne mettono in guardia! Ma forse era scontato. Perché mai, se davvero si fosse trattato di un organismo sano, i grandi filosofi classici avrebbero tentato di aggiustare un complesso politico funzionante? Sembra pertanto che si possa scegliere il danno minore, ma mai abbracciare con entusiasmo una soluzione pienamente affidabile.
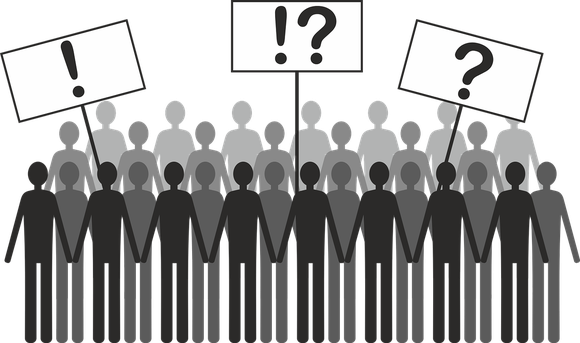
L’assemblea è l'ariete della sinistra non istituzionale, che vorrebbe, secondo un disegno vago, estendere la pratica assembleare alla popolazione intera, contro il parlamentarismo d’accatto che, appunto, non misura alcuna partecipazione reale. È chiaro che alla luce delle osservazioni fatte questo rimedio non ci basta più. Probabilmente si tratta della scelta più opportuna, ma così formulata non ci metterà in salvo da nulla. Anzi, potrebbe esistere un sistema non democratico (cioè elettorale) che però sia, in actu exercito, più democratico della democrazia elettorale. In altri termini, non escludo che una monarchia o un tipo ereditario o elettivo di altra natura (in cui appunto non sia implicato il suffragio) possa essere, nella sua quotidianità, anche più aperta e democratica delle nostre democrazie. In termini meno compromettenti, potremmo dire che è vero che le procedure proteggono di più dall'arbitrio, grazie alle leggi che impediscono atti eccessivamente tirannici, ma non garantiscono affatto la democrazia. La regola formale non riesce mai a riempire la lacuna della buona formazione. Dunque se insieme alle regole non ricerchiamo, come elemento indispensabile, anche la condotta, non riusciremo mai a cambiare nulla. Trotsky, a tal proposito, in un libriccino (La vita è bella, Chiarelettere 2015) rileva una lampante contraddizione fra l'alto ideale umanitario che muoveva i rivoluzionari e la freddezza e sufficienza che, dagli uffici, gli stessi uomini rivolgono ai cittadini. Può essere un mondo felice quello in cui l'altro è offeso e sottomesso? Si tratta davvero di un mero problema economico?
Bell parla di onore del giusto. Credo che oggi neanche nel più piccolo, e perciò gestibile, gruppo politico vi sia democrazia, e non vi sarà se non cominciamo a sollevare lo sguardo dal frammento politico che costituisce l’insieme di regole (“scegliamo queste o quelle?”), per indirizzarlo all’insieme della vita dei singoli membri. Fino a che il messaggio dell’“onore” non passerà; finché il punto focale, di base, di ogni educazione politica non sarà precisamente come non fare uso sull’altro del proprio potere, allora ci arrovelleremo (ancora) per un pugno di mosche.
19 maggio 2021
DELLA STESSA AUTRICE
Linguaggio, arte, filosofia alla volta del sacro
Per una fondazione ontologica dell'internazionalismo
Disobbedire
Capitalismo e ambiente. Una convivenza impossibile
L'estate 1944 in Carnia. La Repubblica degli uomini liberi
PER APPROFONDIRE CON LA SAGGISTICA
Fondazione dell'anima e della democrazia | Dov'è il Graal? | Alle origini del mondo
