Recensione
Luca Munaron, “La seducente illusione della semplicità”
Nel suo saggio La seducente illusione della semplicità. Genesi di un evoluzionismo plurale (Franco Angeli, 2025), Luca Munaron, professore ordinario di Fisiologia presso l’Università degli Studi di Torino, smantella il vecchio paradigma genocentrico per svelare l’affascinante complessità del vivente. Le sue riflessioni invitano a riconsiderare il nostro approccio alla conoscenza e offrono preziose coordinate di riferimento per chi desideri esplorare le frontiere di una biologia finalmente libera dalle gabbie del riduzionismo.

La semplicità affascina e, per certi versi, acceca. Come resistere alla tentazione di spiegare i fenomeni in maniera lineare, di poter comprendere tutto in base a pochi principi evidenti? L’idea di un sistema della conoscenza in sé chiaro e privo di zone d’ombra non è forse l’immagine della scienza che si è imposta tra il XVI e il XVIII secolo e che, nonostante le innumerevoli rivoluzioni di paradigma in ambito fisico e in altri settori scientifici, è ancora largamente condivisa?
Nel saggio La seducente illusione della semplicità (Franco Angeli, 2025), Luca Munaron, professore ordinario di Fisiologia all’Università degli Studi di Torino, affronta con grande accuratezza storica, scientifica ed epistemologica le insidie di quello che potremmo definire il bias cognitivo della semplicità.
L’autore concentra la sua attenzione sugli effetti deleteri che il criterio della semplicità può comportare in biologia e, più in generale, nella comprensione del vivente e delle sue evoluzioni a livello microscopico e macroscopico. Munaron comincia la sua riflessione mettendo in discussione la validità del celebre “rasoio” di Ockham. Per quale ragione una teoria scientifica che descrive “con meno” la realtà dovrebbe essere considerata più vera a priori rispetto a un’altra che spiegherebbe “con più”?
Tra le tante formule filosofiche che ripetevamo meccanicamente a memoria al liceo vi era – accanto, ad esempio, alle più note “L’Essere è. Il non essere non è” o “Conosci te stesso” – «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» («Non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario»).
Per inciso, l’ironia è amara. Come docente di filosofia nella scuola secondaria di secondo grado, non trovo nulla di più deplorevole della riduzione del pensiero di grandi filosofi a “frasette” prive di senso, che alimentano un apprendimento nozionistico e, ancor più grave, un pericoloso dogmatismo.
Il principio di parsimonia di Ockham è un corollario dell’illusione della semplicità. La predilezione per teorie chiare e lineari porta inevitabilmente a favorire modelli esplicativi costruiti su pochi assunti fondamentali a discapito di quelli che ammettono ridondanze, fattori aleatori o molteplici elementi intrecciati in modo complesso e circolare.
In biologia – prendo il termine nell’accezione estesa di “scienza del vivente” – l’illusione della semplicità si è un po’ alla volta affermata con il predominio del paradigma “genocentrico”.
Afferma Munaron:
« In termini più generali, le elaborazioni di inizio XXI secolo rendono più evidente come l’approccio del paradigma consolidatosi nella prima metà del Novecento sia non solo spiccatamente genocentrico ma anche basato su una concezione unidirezionale e lineare dell’informazione biologica […]. Il genotipo specifica le forme attraverso l’interazione con l’ambiente […]. L’anatomia è ridotta ad effetto e, in virtù della barriera somato-gametica weismanniana che esclude la possibilità di ereditare caratteri acquisiti, non può esercitare alcuna retroazione sul genotipo stesso, “ritornare” in una causalità circolare » (Ivi)
Nel Novecento si afferma il paradigma “genocentrico”, secondo cui tra genotipo e fenotipo esisterebbe un rapporto univoco e lineare. In altre parole, il genoma determinerebbe i caratteri dell’organismo e, in ultima istanza, il suo destino biologico. Ciò che siamo sembrerebbe inscritto nei nostri geni: nel codice della vita si vorrebbe rintracciare il mistero dell’esistenza, abbracciare il passato, il presente e forse persino leggere il futuro.
Ricorro volutamente a toni enfatici, perché non si deve sottovalutare quanto un paradigma scientifico possa essere amplificato in forme più radicali sul piano divulgativo o nel senso comune. Di fronte a una teoria “semplice”, chi non ha familiarità con il linguaggio scientifico tende a semplificare ulteriormente, formulando deduzioni infondate. Si genera così una lunga e tragicomica fallacia del piano inclinato, per cui tra la “vulgata” di una teoria e la teoria stessa si apre uno scarto che si accresce col tempo.
Munaron si sofferma sulla genesi del paradigma genocentrico, evidenziandone i limiti intrinseci alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche. Il suo focus si concentra in particolare sul rapporto tra genocentrismo ed evoluzionismo. Tra le numerose fonti citate e analizzate, spicca l’imponente testo di Stephen Jay Gould La struttura della teoria dell’evoluzione, da cui Munaron riprende i tre fondamenti del darwinismo:
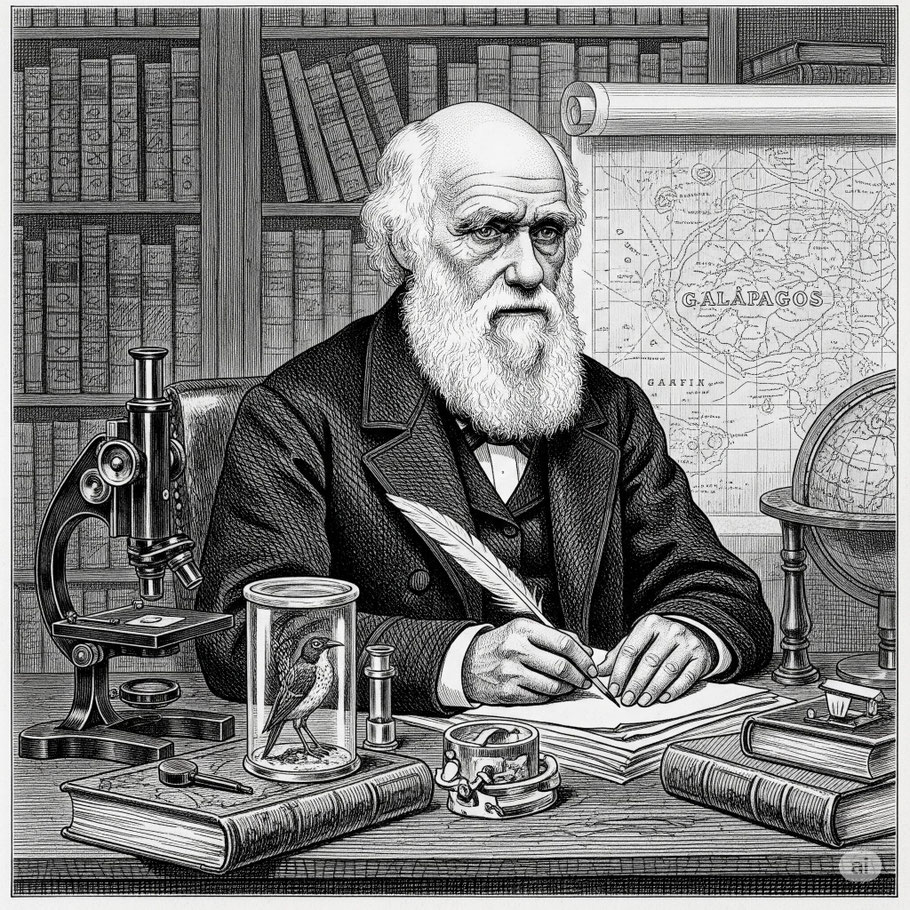
« Il darwinismo classico comprende tre fondamenti: l’attività o il livello su cui agisce la selezione, l’individuo per Darwin; l’efficacia, che comprende la prevalenza della selezione su tutte le altre forze in gioco – la deriva genetica e i vincoli biologici – nel modellare le influenze storiche, ecologiche e strutturali sull’evoluzione; e infine l’estensione o portata, cioè il grado a cui la selezione naturale può essere estrapolata ad elemento causale universale per spiegare la biodiversità su tutte le scale biologiche, compresa l’emergenza dei gruppi tassonomici superiori. È questo il cosiddetto tripode gouldiano della logica darwiniana » (Ivi)
Attività, efficacia ed estensione sono tre parole chiave del darwinismo classico. La selezione naturale è la forza prevalente che agisce sugli individui (gli organismi) e la sua portata o estensione come elemento causale va estrapolata, cioè ben isolata e determinata, per comprendere la biodiversità «su tutte le scale».
L’aspetto creativo dell’evoluzione è per Darwin dalla parte della selezione naturale e non solo delle “variazioni casuali” che costituiscono un “materiale grezzo” su cui essa opera.
Osserva in merito Gould:
« Darwin insisteva sul fatto che, anche ammettendone la debolezza e la valenza negativa, la forza della selezione naturale da lui proposta poteva nondimeno, quando si fossero stabiliti alcuni presupposti sulla natura della variazione (di cui più tardi si è accertata la correttezza), agire come meccanismo positivo della novità evolutiva, cioè poteva “creare l’adatto” e insieme eliminare l’inadatto, per mezzo della lenta accumulazione, in innumerevoli generazioni, degli effetti delle variazioni favorevoli » (S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione)
Nella sua versione originaria la teoria di Darwin non contempla ovviamente una spiegazione rigorosa dei processi alla base della variazione. Non che manchino nelle sue opere delle ipotesi interessanti – che tra l’altro Munaron prende in esame mostrandone il potenziale epistemologico inespresso –, ma i tempi non erano maturi.
Con la scoperta del DNA e dei meccanismi di trascrizione e di traduzione, inizia una “nuova era” ricca di prospettive. Si ha l’impressione di aver scoperto il Santo Graal, che l’uomo abbia risolto il mistero della vita, che addirittura si possa ricreare artificialmente la vita stessa.
Tutto appare in una fulgida luce; tutto sembra ormai possibile.
Per comprendere quanto tale fiducia sia ancora oggi radicata, leggiamo le parole del genetista Siddhartha Mukherjee:

« Decifrare l’atomo rappresentò la premessa indispensabile alla manipolazione della materia (e, tramite questa, all’invenzione della bomba atomica). Capire i geni ci ha permesso di manipolare organismi con un’abilità e una capacità senza precedenti. Abbiamo appreso che la vera natura del codice genetico era incredibilmente semplice: un’unica molecola e un unico codice recano le «nostre» informazioni ereditarie. “Che gli aspetti fondamentali dell’ereditarietà siano risultati inusitatamente semplici, rafforza in noi la speranza che la natura possa essere, alla fin fine, interamente accessibile” ha scritto il grande genetista Thomas Morgan. “Ancora una volta, la sua tanto strombazzata impenetrabilità si è rivelata un’illusione” » (S. Mukherjee, Il gene)
Il concetto di gene precede, com’è noto, la scoperta del DNA, ma è soprattutto con quest’ultima che la genetica tende ad assumere il ruolo di “verità ultima” della biologia. A partire dalla seconda metà del Novecento, il rapporto tra i molteplici saperi che indagano il vivente e la genetica si configura quasi come quello che, per Aristotele, intercorreva tra la filosofia seconda (la fisica) e la filosofia prima (la metafisica). Purtroppo – o almeno per gli strenui difensori della semplicità – le cose non stanno affatto così, e Munaron lo chiarisce con efficacia nel suo saggio. Procediamo però con ordine, seguendo il filo di Arianna storico-concettuale tracciato dall’autore.
Già prima dell’identificazione del DNA, il concetto di gene poneva un problema al darwinismo classico: come conciliare una teoria che interpreta l’evoluzione in termini macroscopici (ambiente-organismo) con un’altra che attribuisce un ruolo decisivo al codice inscritto nel vivente? La soluzione adottata – un escamotage semplice ed elegante, che avrebbe probabilmente incontrato il favore di Ockham – è la cosiddetta Sintesi moderna.
Munaron riporta l’utile definizione di Corning che qualifica la Sintesi moderna come
« una combinazione dei principi darwiniani basilari (1859) di variazione, ereditarietà e selezione naturale accoppiati con un focus mendeliano, centrato sui geni, e all’affermazione che le mutazioni genetiche (insieme alla ricombinazione sessuale) sono le fonti primarie di novità nell’evoluzione biologica » (Ivi)
Nel corso del Novecento, soprattutto dalla seconda metà, la teoria della Sintesi moderna subisce un notevole irrigidimento. Uno dei primi a sottolinearlo è lo stesso Gould che osserva come in studiosi come Ernst Mayr sia forte la tendenza a considerare «la completa sufficienza della teoria microevolutiva per spiegare l’intera storia della vita» (S. J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione). Si cade in una forma di determinismo dove il genotipo istruisce tout court il fenotipo e l’ambiente agisce solo negativamente attraverso la selezione naturale.
Si pensi ancora a quanto afferma Richard Dawkins nel noto saggio Il gene egoista (1976):
« Devo sostenere che il modo migliore di guardare l’evoluzione è in termini di una selezione che avviene al livello più basso possibile […]. Sosterrò che l’unità fondamentale della selezione, e quindi dell’egoismo, non è né la specie né il gruppo e neppure, in senso stretto l’individuo, ma il gene, l’unità dell’ereditarietà. Pertanto, la selezione si verifica solo al livello infimo del gene, definito ‘l’unità fondamentale della selezione’. Nulla di più inclusivo, nemmeno un organismo, può essere definito unità di selezione » (R. Dawkins, Il gene egoista)
Già alla fine del Novecento, e con crescente intensità nel XXI secolo, numerose voci si sono levate contro la rappresentazione riduttiva del rapporto genotipo-fenotipo e dell’evoluzione del vivente. Le nuove frontiere della biologia cellulare, gli studi su microorganismi come batteri e virus — si pensi alle ricerche di Lynn Margulis —, la fisiologia evolutiva e molte altre indagini pionieristiche hanno messo in discussione l’impianto epistemologico su cui si fonda la Sintesi moderna e la biologia “genomica”, ovvero quella teoria del vivente che postula una causalità lineare tra genotipo e fenotipo. Si è giunti perfino a formulazioni radicali, come quella proposta da Jean-Jacques Kupiec:
« Una rivoluzione è necessaria nelle scienze del vivente. La genetica – fondamentalmente determinista – non tiene la strada di fronte alla somma dei dati sperimentali che dimostrano che il caso è onnipresente nel vivente, compreso il funzionamento dei «geni». La genetica, sia nella sua versione forte (un gene determina un carattere di un essere vivente) sia nella sua versione ammorbidita chiamata «epigenetica» (il determinismo del gene è temperato da altri fattori, tra cui l’ambiente), è così scossa nelle sue fondamenta: il disordine regna dove si supponeva regnasse un programma. Ma, piuttosto che abbandonare questa teoria errata, i biologi praticano un doppio discorso che consiste nell’oscillare permanentemente tra le due versioni della genetica (forte e ammorbidita), il che ha l’effetto di trasformarla in un’ideologia infallibile. Per uscire da questa impasse, è tempo di accettare la parte anarchica del vivente, cioè la variazione aleatoria che ne è la proprietà prima, e di trarne le conseguenze. Non esiste alcun ordine biologico intrinseco che determinerebbe la vita. Gli esseri viventi non sono società centralizzate di cellule che obbediscono agli ordini del genoma o dell’ambiente, ma comunità di cellule anarchiche, libere e artefici del loro destino, grazie al caso che utilizzano a loro vantaggio. Né gene, né ambiente, una nuova via si apre qui alla ricerca biologica » (J.J. Kupiec, Et si le vivant était anarchique ?)
Una posizione in apparenza forte sul piano epistemologico che sembra però cadere in una sorta di dogmatismo di segno contrario. Kupiec arriva infatti perfino a ipotizzare – è il sottotitolo del suo libro – che la genetica sia un grande “arnaque”, cioè una truffa, un imbroglio.
Molto più prudente e sensata è la prospettiva di Munaron che guarda a una Sintesi estesa. Si enfatizza l’importanza di tenere presenti diversi fattori “omici” – la totalità di molecole biologiche, come DNA, RNA, proteine e metaboliti – in un sistema biologico e un approccio multiscala, non lineare e distribuito. L’avvento della “rivoluzione sistemica e omica” all’alba del XXI secolo ha generato trasformazioni radicali nella visione d’insieme della biologia.
In particolare, Munaron evidenzia come le tecnologie “omiche” (come la genomica, la proteomica e la metabolomica) permettano di investigare in profondità le dinamiche strutturali, funzionali e le interazioni di sequenze geniche, proteine e metaboliti cellulari. Questo approccio è olistico e anti-riduzionistico, perché riconosce che la complessità della vita risiede nell’organizzazione del sistema, non solo nelle singole biomolecole.
La plasticità dei sistemi complessi viventi e le loro risposte agli stress non sono solo geneticamente determinate, ma dipendono anche da marcature epigenetiche del DNA e dal controllo della trascrizione genica. Il differenziamento cellulare e le funzioni dipendono dal “trascrittoma” e dal “proteoma”, non direttamente solo dal genoma. Da un punto di vista “omico”, la plasticità si connette alla produzione di pattern trascrittomici e proteomici alternativi a partire dallo stesso genoma.
Si può dire allora, osserva Munaron,
« L’informazione biologica non è depositata in alcun singolo “luogo”, ma è distribuita su molteplici livelli oggi accessibili ad uno sguardo sistemico ed omico. In questo scenario, la storia biologica procede per mezzo di multiple con-cause coesistenti e differenzialmente pervasive delle micro e macroevoluzioni. Solo un approccio sempre più funzionale, fondato su una idea integrata della vita, ci consentirà di maturare una sempre maggiore consapevolezza della logica profonda, se una logica esiste, nella storia biologica » (L. Munaron, La seducente illusione della semplicità)
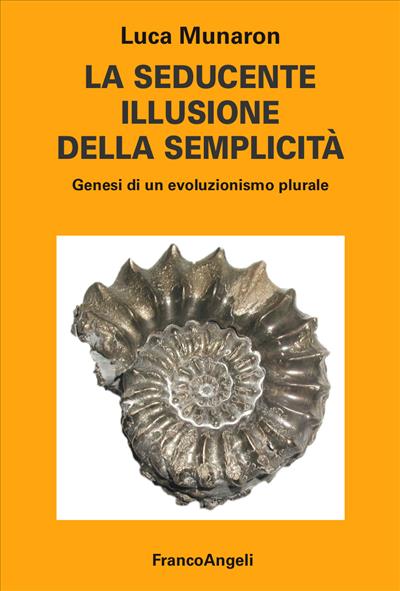
L’informazione biologica è distribuita; tra genotipo e fenotipo non sussiste un rapporto lineare. E, cosa più importante, la relazione organismo-ambiente va intesa come un tutto. Non si dà un organismo senza ambiente, né un ambiente senza organismo: tra i due vige una causalità circolare. Anzi, per essere più precisi, potremmo dire che ogni vivente è non solo sempre “essere-in-ambiente” – gioco qui in chiave biologia con il concetto di essere-nel-mondo di Heidegger –, o per dirla con Jakob von Uexküll inserito in un “mondo ambiente” (cfr. J. Uexküll, Ambienti animali, ambienti umani), ma accoglie al suo interno molteplici altri organismi-ambienti e “infravite” (cfr. T. Heams, Infravies. Le vivant sans frontières).
La biologia post-genomica sta offrendo una nuova chiave di lettura a una celebre sentenza di Anassagora, più volte ripresa nel corso dei secoli: “Tutto è in tutto”. Nel nostro caso, non si tratta di reinquadrarla — come avvenne nel Rinascimento — nella dialettica macrocosmo-microcosmo. Occorre piuttosto accettare l’idea che ogni vivente sia un sistema di sistemi, un intreccio di totalità in equilibri metastabili. Ragionare in questi termini non significa considerare il vivente come qualcosa di anarchico o sregolato. Occorre invece, come insegna Munaron, abbandonare il principio di parsimonia. Il vivente non segue una logica: non esiste “la logica” del vivente, ma innumerevoli logiche che dia-logano tra loro in modo problematico. Ognuna di esse ha la propria grammatica, le proprie regole, la propria sintassi. Gli elementi comuni, le interazioni e le traduzioni sono possibili, ma i “livelli” del vivente mantengono una propria autonomia. Non esistono, dunque, formule magiche per semplificare, né postulati riduzionistici sempre validi: il mondo della vita si sottrae alle assiomatizzazioni unilaterali, alla semplicità.
Prima di terminare, vorrei brevemente soffermarmi sullo stile e sui possibili destinatari de La seducente illusione della semplicità. Il testo di Munaron presenta innumerevoli pregi sul versante formale ed espositivo. La prosa è limpida, e concetti scientifici complessi vengono esposti in modo tale che anche i non esperti possano coglierne la portata. L’autore evita i tecnicismi; cita passaggi chiave dei più grandi studiosi dell’evoluzionismo, del passato e del presente, commentandoli con grande chiarezza; riesce a tenere insieme, nello sviluppo dell’argomentazione, l’aspetto storico-scientifico e quello epistemologico, senza generare salti o fratture.
Consiglio il volume a chi desideri acquisire un quadro generale e critico sull’evoluzionismo e sui diversi orientamenti della biologia contemporanea, e in particolare ai docenti di scienze della scuola secondaria di primo e secondo grado. Purtroppo, nel nostro sistema scolastico, le scienze naturali vengono spesso presentate come blocchi monolitici, avulsi dalla storia. I manuali, inoltre, non tengono nella dovuta considerazione le più recenti acquisizioni scientifiche, crogiolandosi molte volte — nel caso della biologia — in paradigmi obsoleti. Il saggio di Munaron potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per quei docenti che desiderano ripensare, in una prospettiva meno dogmatica e più interdisciplinare, l’insegnamento della propria disciplina.
28 agosto 2025
